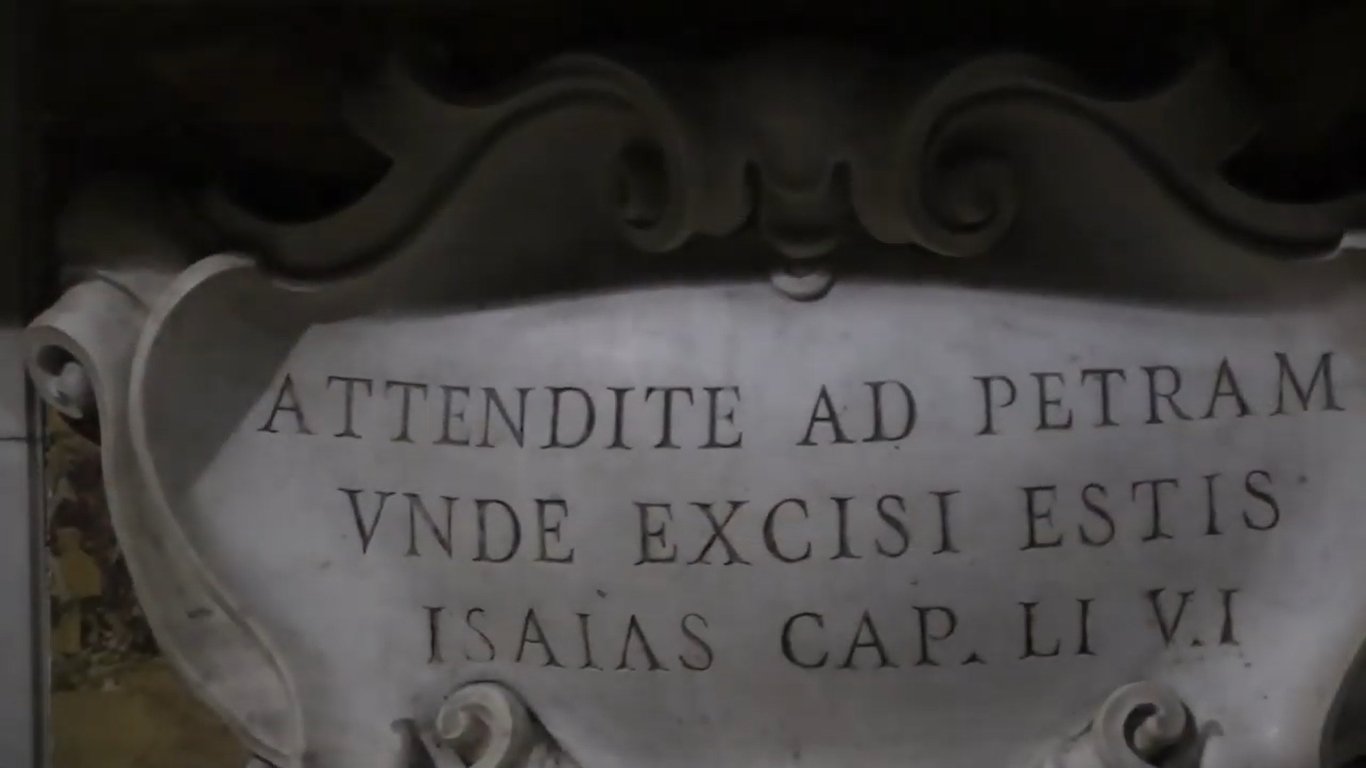
contatti : pierluigi18faber@libero.it
ing. Pierluigi Carnesecchi
MANUALE DI RICERCA GENEALOGICA GRATUITO
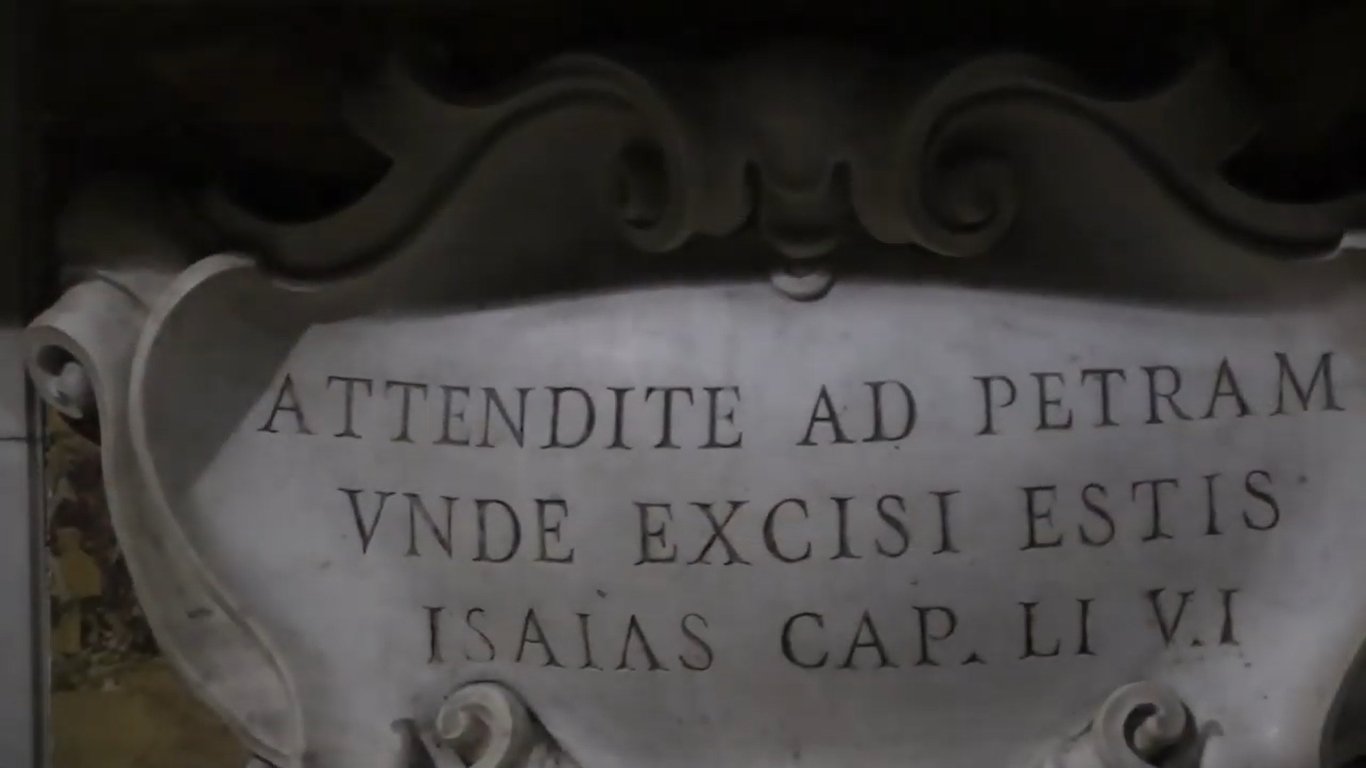
Attendite ad petram unde excisi estis
........Considerate la roccia onde foste tagliati, ( e la buca della cava onde foste cavati..........) Isaia capitolo 51 Antico Testamento
meditate sulla roccia da cui siete stati tagliati . Riflettete sulle vostre origini:
DUE MOTIVI DEL PERCHE' E' UTILE LA RICERCA GENEALOGICA E FAMILIARE
A : E' NOSTRO DOVERE RICORDARE E FAR RICORDARE I NOSTRI MORTI, ED E' PER LO STESSO PRINCIPIO NOSTRO DIRITTO CHIEDERE AI NOSTRI VIVI DI ESSERE RICORDATI A NOSTRA VOLTA , PER SFUGGIRE AL NULLA INCOMBENTE
B : IL RICORDO E' ESPERIENZA. L'ESPERIENZA DI MIGLIAIA E MIGLIAIA DI VICISSITUDINI UMANE E DOVREBBE POI SERVIRE AD EVITARE AGLI UOMINI DI RIPETERE ERRORI GIA' COMMESSI ED A RIPARTIRE PROPRIO DA QUEGLI ERRORI PER COSTRUIRE UNA VITA MIGLIORE PER TUTTI , EVITANDO I PRIVILEGI E LE RENDITE DI POSIZIONE. qUESTO S'INTENDE PER RICERCA DELLA FELICITA'
Nella Dichiarazione d'indipendenza degli Stati Uniti d'America (4 luglio 1776) leggiamo che «tutti gli uomini sono creati uguali; che essi sono dal Creatore dotati di certi inalienabili diritti, tra questi diritti vi sono la Vita, la Libertà e il perseguimento della Felicità».
Il perseguimento della felicità come diritto inviolabile, costituzionalmente garantito.
Significa che la felicità dei cittadini è qualcosa di cui i Governi devono farsi carico e qualora non siano in grado di garantirla, il popolo (We, the people leggiamo nel Preambolo della Costituzione americana) ha diritto di pretendere un nuovo Governo che organizzi i suoi poteri in una forma che sembri al popolo più adatta ad assicurarla.
Attraverso poi le microstorie si puo' verificare e convalidare o contestare e tentare di riscrivere in modo corretto la macrostoria.
Svelando le manipolazioni che spesso la macrostoria subisce dalle classi dirigenti che sempre cercano d'imporre una loro verita'
Ricordate che tanti hanno interesse a modificare la storia e a farla apparire con interpretazioni piu' utili ai loro interessi
Ma solo la STORIA vera e' utile come esperienza
Le favole storiche sono una dannosa perdita di tempo per la collettivita'
Premessa : Ricordate che la storia e' una sorta di esperienza collettiva e come tale va assunta a maestra di vita.
Pensate e valutate con la vostra testa. Date sempre una vostra interpretazione agli avvenimenti non accontentatevi di accodarvi a quello che dicono gli altri.
Neanche a quello che dicono gli storici troppo spesso , consapevolmente o inconsapevolmente, finiscono al servizio di ideologie
...............perche' ciascuno di noi col proprio volto e i propri sentimenti , contribuisce a creare nel mondo la violenza e la solidarieta', l'ingiustizia o la pieta' e la misericordia...............
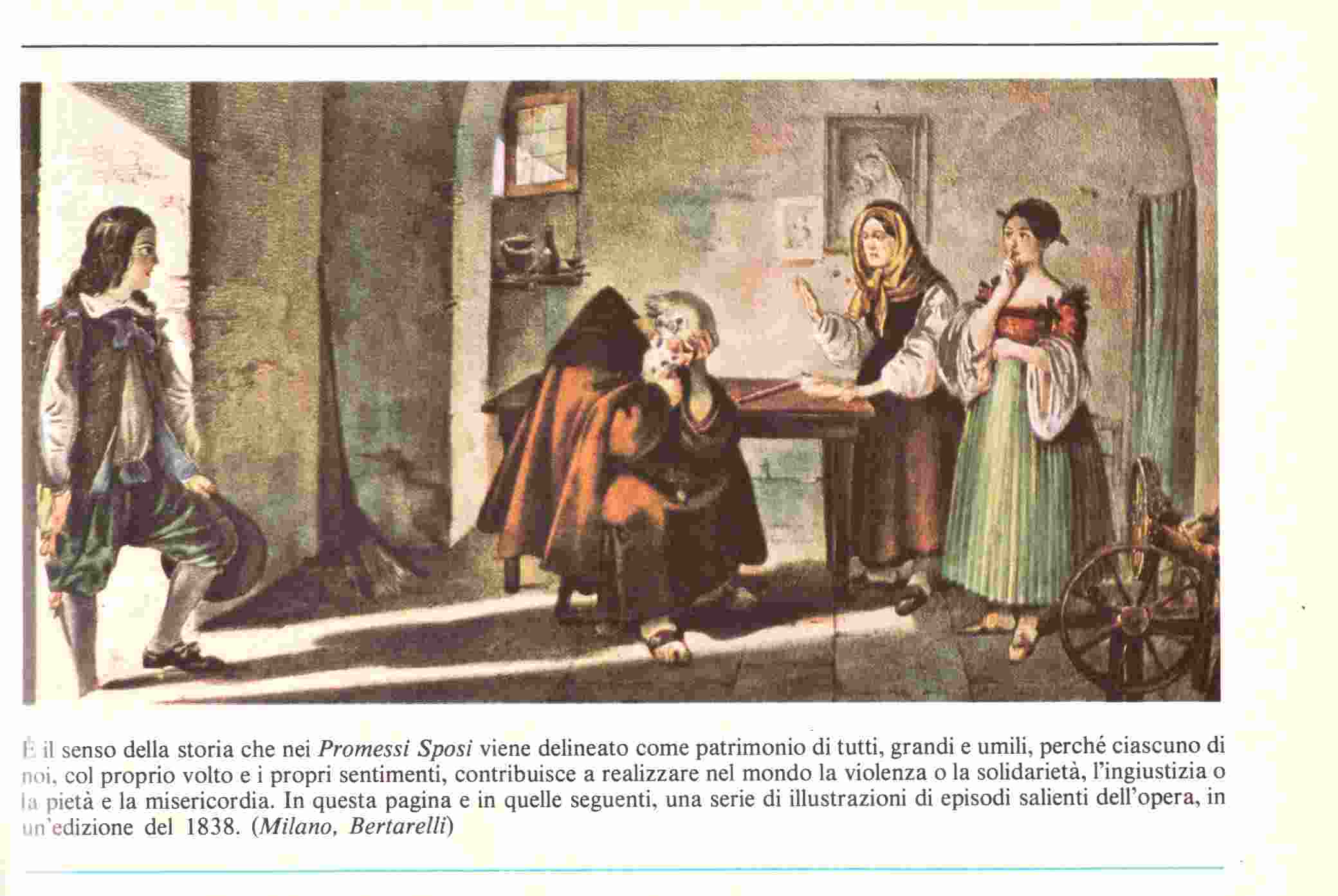
da la "storia d'Italia di Indro Montanelli Rizzoli editore
Il 13 aprile del 2021 Alfeo Giacomelli se ne e' andato L'amico Francesco Lenzi scriveva allora :
...........Tra l'altro, in qualche modo, come con quasi tutte le famiglie appartenenti alle “Corti del Reno”, i Giacomelli erano imparentati anche con noi Lenzi: la ricerca genealogica è una ricerca complessa e articolata che va analizzata nel suo insieme e nella sua totalità, questo è stato uno dei primi grandi insegnamenti di Alfeo.
Alfeo è stato uno studioso intelligente, poliedrico, attento, preciso a tal punto che nulla poteva essere scritto e definito se non sulla base di documenti certi. Alfeo mi ha insegnato a leggere la storia, a capirne le dinamiche e l'evoluzione nel corso dei secoli soprattutto attraverso la microstoria e le vicende occorse alle nostre famiglie, interpretandola non con gli occhi di oggi ma con quelli del tempo in cui si è svolta e questo lo si può fare solo e solamente attraverso la lettura attenta delle fonti che sono gli atti di stato civile, gli estimi, i catasti, i rogiti, i censimenti, le memorie di qualsiasi genere, anche criminali, i testi e tanto altro, ma anche i palazzi, le opere d'arte, le chiese e gli stemmi.
Potrei stare qui le ore a parlare di Alfeo, della sua gentilezza, della sua sensibilità, della sua generosità, della sua bontà, della sua sconfinata cultura, della sua pazienza, del suo amore per la storia ma chi lo ha conosciuto lo sa, chi invece non ha avuto la fortuna di conoscerlo, o di comprenderlo, si è perso una grandissima occasione di crescita, di maturazione delle proprie conoscenze dell'uomo e della vita perché è vero che solo conoscendo e interpretando correttamente il passato si può progettare un futuro migliore. .........
La macrostoria orienta miliardi di microstorie
Microstorie di tanti individui che subiscono le scelte di pochi
L'esperienza che viene da quei miliardi di microstorie puo' pero' generare un flusso destinato a cambiare la macrostoria e ad imponendole nuove direzioni piu' consone alla dignita' e alla felicita' di tutti
Chi si occupa di genealogia in realta' e' storico di microstoria. Ed ha la responsabilita' di trarre una morale dai suoi studi e di porgerla agli altri
Gli uomini debbono imparare a vivere per essere felici sulla terra, nel rispetto del vicino
Non sappiamo niente di altre vite ultraterrene, questa e' la sola vita che siamo sicuri di avere quindi non sprechiamola permettendo errori gia' commessi in passato
La corretta visione del passato e' una strada per la costruzione di un futuro piu' giusto e dignitoso per l'umanita'
PURTROPPO VENIAMO DA CIRCA 3 SECOLI DI CULTURA DEL PRIVILEGIO NOBILIARE . SECOLI IN CUI SI E' ALTERATA E MISTIFICATA PROFONDAMENTE LA STORIA PER GIUSTIFICARE PRIVILEGI ANACRONISTICI ED ASSURDI
OGGI OCCORRE RIPULIRLA DALLE MOLTE FALSITA' E DALLE MOLTE STUPIDAGINI INCULCATE PER PUNTELLARE UNA COSTRUZIONE CHE ALTRIMENTI NON SAREBBE STATA IN PIEDI
QUINDI INTANTO COMINCIATE COL DUBITARE DELLE VECCHIE STORIE
Il passato si legge con i documenti coevi. Documenti che debbono essere quelle che vengono chiamate fonti primarie
Lo storico puntella le sue conclusioni a mezzo di fonti primarie e solo talvolta attraverso fonti secondarie che egli cita e ritiene degne di fede
Vale insomma il principio che tutte le fonti debbono poter essere verificate nella loro autenticita'
Un documento ieri come oggi non e' sempre vero
Bisogna guardarsi da una gran quantita' di falsi . Esistono antiquari specializzati nel riconoscere i falsi e non sempre riescono
Dal punto di vista politico la Chiesa cattolica ( detentrice della cultura per lunghi tratti della storia ) ha realizzato molti falsi
Un documento che per secoli ha avuto un gran peso nella disputa tra il potere statale e il potere teologico e' la famosa donazione di Costantino che l'umanista Lorenzo Valla dimostro' falso nel 1440 ( Costantino 27 febbraio 274 – 22 maggio 337 : una menzogna utilizzata per oltre 1.100 anni )
La Chiesa cattolica e' stata una grande produtrice di documenti falsi sia a fini teologici , sia per dar valore all'amico , sia per denigrare il nemico
Vedi le interpolazioni false sui documenti addirittura di Giuseppe di Arimatea per arrivare a Federico II (lo stupor mundi ) il grande nemico della chiesa medioevale in cui la Chiesa tento' di far vedere l'Anticristo dell'Apocalisse
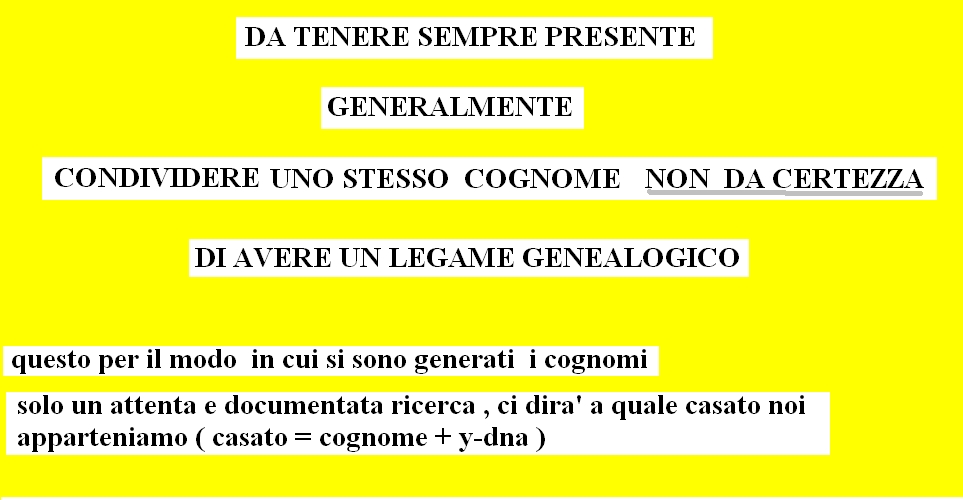
Una premessa :
COGNOMI false convinzioni che ancora persistono sulle origini dei cognomi fiorentini
Nell'ambito privato vi sono in circolazioni moltissimi falsi
In questo caso le falsificazioni sono falsificazioni che riguardano il prestigio della famiglia, con cui si crea una storia che ha radici piu' antiche e falsi legami con famiglie prestogiose dell'antichita' ( ma una qualunque alterazione della microstoria coinvolge in qualche modo la macrostoria )
Una delle piu' importante falsificazioni nella storia familiare riguarda la Famiglia Bonghi di Bergamo.
Produzione di documenti falsi talmente vasta e sofisticata da essere in grado di modificare la lettura della storia del Comune di Bergamo e disorientare gli storici per lunghissimo tempo
Saggio del dr Francois Menant
Alterazione della storia di Bergamo la famiglia Bonghi
Occhio quindi alle tante genealogie che trovate anche su siti in un certo modo ritenuti affidabili .Quando una genealogia scende sotto il XII secolo cominciate a sentire il bisogno di stare particolarmente all'erta
Nei secoli XVI , XVII , XVIII vi e' un proliferare di genealogisti senza scrupoli che giungono ad alterare e persino a distruggere documenti coevi per introdurre personaggi e inesistenti all'interno di elenchi per evitare che documenti rivelassero la falsificazione, utilizzando pergamente antiche opportunamente raschiate dal contenuto originario e inchiostri fabbricati col procedimento antico
Cosi compaiono pezze di appoggio false introdotte fraudolentemente all'interno degli archivi stessi, cosi compaiono diplomi di nobilta' mai concessi
Lo svilupparsi nel secolo XX del metodo prosopografico per lo studio dei "ceti dirigenti" ha portato alla scoperta di molti falsi documenti e alla revisione di molti alberi genealogici
Non buttate il Crollalanza.....falsificazione
Come Virgilio è la guida di Dante nel viaggio attraverso i nove cerchi infernali e nell'ascesa al monte del Purgatorio.Anche noi abbiamo bisogno di una guida nella nostra discesa alle origini
Introduciamo e impariamo a conoscere ora un concetto fondamentale : "il cognome moderno" cioe' il filo rosso ( la guida) di buona parte della ricerca genealogica e della ricostruzione di storia familiare che ci sara' possibile fare
Ci guidera' per buona parte del viaggio fino a giungere "all'eta' del patronimico" in cui ci lascera' in altre mani e dove iniziera' una parte diversa del viaggio
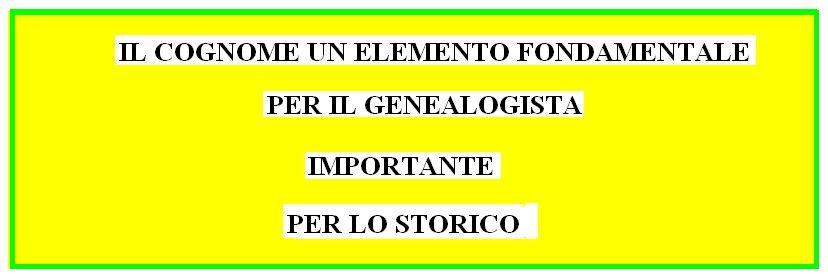
INDIVIDUAZIONE VERBALE E SCRITTA IN ASSENZA DI COGNOME
individuazione verbale in mancanza di nome familiare :
In una societa' poco numerosa o in una societa' poco diversificata inizialmente prevalse il nome unico ed al piu' la mansione o il lavoro
l'estensione demografica della comunita rende l'individuazione piu' difficile , per cui le parole utilizzate per esprimerla sono di necessita' piu' complesse
Antonio chi ? ...............Quale Antonio ? il fabbro .Ce ne sono diversi di Antonio che fanno i fabbri
Allora lo si lega a qualche particolare della memoria collettiva : quello che ........
dapprima si ricorre al rapporto parentale : figlio di .......nipote di .........fratello di .........
Cioe' il PATRONIMICO cioe' qualcosa legato al padre : nella forma X+Y+Z
Talvolta e' la madre a venire chiamata in causa : il figlio della Tosa , il figlio della Bella, ...........
A maggior chiarezza aiuta il mestiere praticato da lui o dal padre
poi alla toponomastica : quello che abita vicino a.................o colui che viene da ...........
per un proprietario si ci aiuta col nome delle terre che possiede
per altri ci si aiuta con un eventuale soprannome o al soprannome del padre o addirittura al soprannome del nonno
.......................................
QUINDI
Individuare vuol dire ricercare quella caratteristica che diversifica un elemento dagli altri dell'insieme
In un gruppo umano esaurito il nome si utilizza il nome del padre e talvolta il nome del nonno
poi tutta una serie di elementi ausiliari
in modo particolare il soprannome
l'individuazione notarile
richiede una precisione maggiore di quella verbale, una identificazione che tenti di resistere alle omonimie ed allo scorrere dei secoli per assegnare dei diritti all'individuo ed ai suoi eredi
Il NOME FAMILIARE O COGNOME in una societa' ancora chiusa alle grosse migrazioni e' un passo in avanti
riguarda un gruppo parentale ( quasi sempre patrilineare )
Intanti chiariamo : IL COGNOME CE LO DANNO GLI ALTRI ,NON SIAMO NOI A SCEGLIERCELO
Uno stesso cognome nasce in luoghi diversi ,con capostipiti diversi
Valentini come figlio di Valentino , puo' nascere come cognomizzazione , in quel luogo tende a rimanere unico o a venire sostituito con un cognome nuovoin molti luoghi , ma fino a che non siano presenti grosse migrazioni ed ognuno resta confinato in un luogo non si presta a generare omonimie
LE RAGIONI DELLA TRASMISSIONE EREDITARIA
Probabilmente il cognome italiano nasce a Venezia poco oltre la meta' del secolo XI ( ed e' legato alla tradizione bizantina ) e poi ha una lenta diffusione nel resto d'Italia dove comincia ad attestarsi in un periodo di poco precedente al 1150 o di poco successivo al 1150 , secondo le zone
COME PASSO IN AVANTI esprime UN CONCETTO SOCIALE NUOVO : l'importanza dell'appartenenza ad un gruppo di persone
La famiglia assume nella societa' un valore. Sempre piu' famiglie diventano importanti nella societa' . Quindi nella vita politica entrano dei fattori nuovi
E la politica subisce un cambiamento. Con un incremento di soggetti che intervengono a determinarla
Insomma, dobbiamo domandarci , perche' si sente il bisogno di inserire il nome familiare nei criteri d'individuazione ?
E perche' fino ad allora non se ne era sentito il bisogno ?
Ripetiamo :
Comincia a sentirsi l'aumento della pressione demografica: la popolazione inizia a crescere
Inoltre la mancanza di una identificazione precisa nei documenti puo' essere che voglia dire che non ne era sentito il bisogno in una societa' che si presentava immobile economicamente e socialmente
e puo' essere che voglia parlarci di una concezione della societa' che fino ad allora non aveva previsto e non faceva immaginare cambiamenti in futuro ma che ora cominciava a registrarne con una frequenza importante
E solo quando nella societa' comincia a prodursi un cambiamento ( aumenti di ricchezza e crescita sociale e forti divaricazioni ) che rende utile ( se non necessario ) far sapere che si e' figli o nipoti di qualcuno, che comincia quindi a comparire il nome familiare o cognome moderno
: La proprieta' di beni e di diritti in cui questi beni e questi diritti cominciano a trasferirsi
: Beni comuni ed in esclusiva a ben determinate famiglie
il passaggio tra l'identificazione di un individuo a l'identificazione di un individuo sia come singolo sia come facente parte di un gruppo familiare segna un cambio di qualcosa da definirsi all'interno della comunita' che ha fortieffetti politici
: Essere della consorteria degli Adimari o esserne riconosciuto come orbitante nella sfera sociale e politica
...." queste parentele di cognome alcune delle quali composte da molte decine di maschi adulti dominavano la vita della comunita' esprimendo prima di tutto una vera forza militare
...Ovvio che le parentele formassero il contestoe fornissero il linguaggio della lotta per la preminenza , della compensazione dei torti , dell'esercizio della vendetta..."
...nel clima in cui nascono i primi cognomi la solidarieta' tra coloro che portano unmedesimo cognome : prima di tutto tra i discendenti effettividi comuni antenati maschi, ma anche tra cognati.......................................... l'appartenenza ad una parentelapoteva certamente coinvolgere individui e nuclei familiari in origine estranei. A questo proposito l'osservazione di n tribunale genovese nel 1665 "quando uno d'una parentella o sia cognomee'inimico d'un altro sogliono le parentelle unirsi per quanto non sijano congiunti di sangue
...de cognomine et parentela......
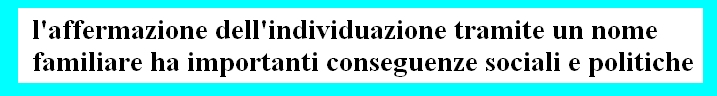
La ricerca genealogica ha come spirito guida il cognome "moderno"
Specifico cognome "moderno" perche' e' inutile confonderlo con il cognome romano o col sistema d'individuazione romano infatti per quanto riguarda il cognome la frattura col mondo romano e' abbastanza netta
SALTO SUBITO ALLA CONCLUSIONE LE PRIME COGNOMIZZAZIONI IN TOSCANA ( E RIGUARDANO SOLO FAMIGLIE DEL CETO DIRIGENTE DI QUEL MOMENTO ) AVVENGONO UN PERIODO COMPRESO TRA LA META' DEL XII SECOLO E LE PRIME DECADI DEL XIII
LO SVILUPPO SOCIO-POLITICO ERA DIVERSO NELLE VARIE CITTA' TOSCANE .
PISA E LUCCA ERANO COMUNITA' CON UNA RINASCITA STORICA E COMMERCIALE CHE SI SPINGEVA MOLTO INDIETRO ED ERA DI PARECCHIO ANTERIORE ALLA RINASCITA FIORENTINA MA IL FENOMENO COGNOMIZZAZIONE AVVIENE PER TUTTE NEI MEDESIMI ANNI
DOBBIAMO PORRE IN EVIDENZA COME IN TOSCANA TRA LA FINE DEL XI SECOLO E LA META' DEL XII SECOLO VENISSE INTRODOTTO L'USO DELL'ARALDICA
E L'ARALDICA TOSCANA AVESSE RISPETTO ALLA ARALDICA NORDEUROPEA LA TENDENZA A UN BLASONE FAMILIARE ( CIOE' NON INDIVIDUALE )
SI PUO' PENSARE CHE L'ARALDICA ABBIA SVOLTO UN RUOLO DI INCUBATORE E DI CATALIZZATORE PER I PRIMI COGNOMI
Avanti all'utilizzo dei cognomi vigeva il sistema patronimico nella forma X figlio di Y nipote di Z ( in forme piu' semplificate o in forme piu complesse : complesse cioe' che prevedevano l'uso di elementi aggiuntivi come soprannomi mestieri provenienze ecc...) che come spieghero' alla lunga si rivelava un sistema disgregante il gruppo parentale
La memoria dei legami parentali non superava il secolo ( come oggi dove si fa fatica a ricordare il bisnonno ) , dopo un secolo infatti difficilmente in mancanza di un sistema unificante si conservava memoria del legame parentale mentre nel frattempo operavano gli stessi fattori disgreganti odierni : liti ,interessi ereditari . convinzioni politiche , amicizie diverse , stato sociale e ricchezza che fanno si che anche oggi i membri di una stessa famiglia si sparentino ( e questo nonostante la presenza di un cognome )
Nei secoli intorno al 1000 il numero dei parenti e la loro capacita' di far gruppo coeso era segno di forza all'interno della comunita'
TUTTI I PRIMI COGNOMI RIGUARDANO GRUPPI PARENTALI CHE FANNO PARTE DEL CETO DIRIGENTE CHE SI IMPONE IN QUEL MOMENTO
drssa ENRICA SALVATORI -------- In sostanza fino alle soglie del Duecento a Pisa vige praticamente incontrastato e diffuso nei vari ceti sociali un unico sistema di denominazione degli individui, che si rispecchia nella formula X filius Y ; parallelamente, tuttavia, le famiglie socialmente e politicamente più importanti, che assumono una precisa strategia famigliare di coesione, di unità di interessi e di residenza, elaborano una formula di denominazione collettiva che li identifica chiaramente, nei confronti della società cittadina, come gruppo compatto. Tale 'coscienza di sé' è così forte e così poche sono le famiglie che possono vantarla, che l'uso di questa formula risulta fatalmente limitato ai casi in cui i membri del gruppo agiscono insieme, collettivamente, a difesa appunto degli interessi di famiglia.
QUASI TUTTI I PRIMI COGNOMI SI ORIGINANO DAL NOME DI UN ANTENATO PER CUI NEL MOMENTO IN CUI APPAIONO SI FATICA A DISTINGUERLI DA UN PATRONIMICO
POICHE' LA CARATTERISTICA FONDAMENTALE DEL COGNOME E' L'EREDITARIETA' TRA LE GENERAZIONI E' EVIDENTE CHE DI IMPRESCINDIBILE AIUTO E' LA RICOSTRUZIONE GENEALOGICA DELLA FAMIGLIA PER COMPRENDERE QUESTO FONDAMENTALE MOMENTO
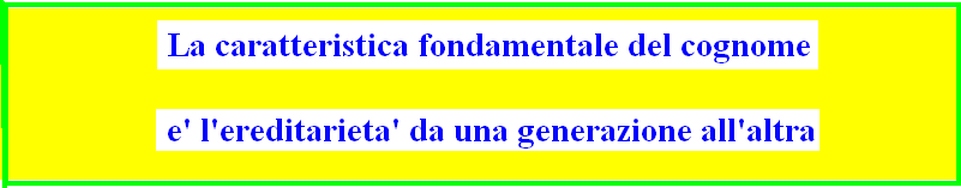
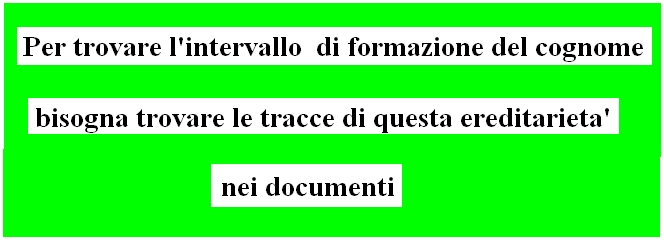
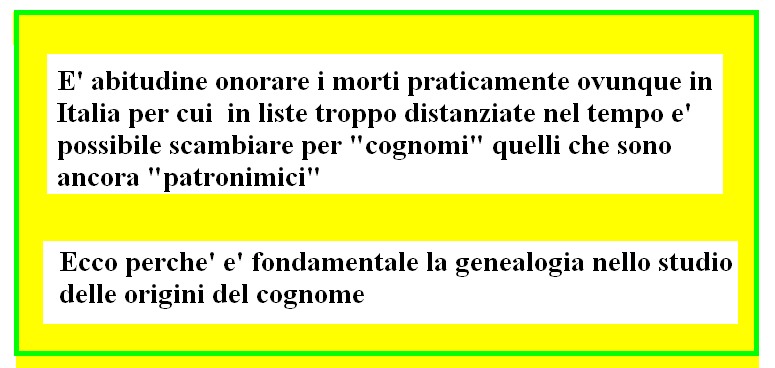
ANCHE PERCHE' IL NOME FAMILIARE NON GODE DI UN PRIVILEGIO DI UNICITA' ANCHE IN GEOMETRIE GEOGRAFICHE RISTRETTE . COSA EVIDENTE AD ESEMPIO PER I ROSSI, I LOMBARDO, I PIERI ...................
UNA FAMIGLIA CON UN CERTO NOME FAMILIARE NON E' DETTO ABBIA LEGAME GENEALOGICO CON UNA SUCCESSIVA COL MEDESIMO NOME FAMILIARE
Credo che la datazione della nascita del cognome fuor che dal dr Roberto Bizzocchi ( ed in parte dal dottor Michele Luzzati ) sia stato argomento di studio molto se non del tutto trascurato dagli storici italiani
Stranamente :
Questo fatto infatti porta a grande confusione quando gli storici o i genealogisti affrontano il tempo in cui il cognome di una famiglia non c'e' ancora ma si sta formando scambiando spesso per cognome quello che solo e' un patronimico o accettando come vere attestazioni infondate di cognomi quando ancora non potevano esistere
Noto le mie medesime considerazioni sull'individuazione familiare , in uno studio ormai un poco datato sull'onomastica pisana della drssa Enrica Salvatori
Enrica Salvatori----Una qualsiasi indagine sulla nascita e sulla diffusione del cognome entro le più importanti famiglie pisane è considerevolmente facilitata dal fatto che molte di queste sono state oggetto di studi prosopografici approfonditi, alcuni già pubblicati (40), altri ancora contenuti in tesi di laurea, conservate presso il Dipartimento di Medievistica dell'Università di Pisa . Si tratta nella grandissima maggioranza di famiglie del ceto consolare cittadino, importanti per agiatezza economica e coinvolgimento politico, per le quali si può risalire ad antenati di XI secolo. Tuttavia, al di là del ben giustificato ottimismo che tale abbondanza di lavori induce nello studioso di antroponimia, devo purtroppo notare che solo in poche di queste opere ho riscontrato una decisa sensibilità verso le questioni antroponimiche, che si esplica essenzialmente con l'attenzione al significato e all'uso dei patronimici e col rilevare tempi e modalità della prima comparsa del nome di famiglia. Nella maggior parte dei casi, invece, l'autore dello studio prosopografico non fornisce sistematicamente per ogni individuo la forma antroponimica con cui è espresso ma, una volta identificata la sua appartenenza a una determinata famiglia, lo nomina utilizzando un `cognome' che sovente compare più tardi o non è attestato in quella forma per quell'individuo. Nonostante questo 'vizio di forma' è tuttavia possibile ricavare diverse e interessanti considerazioni sugli usi antroponimici di queste famiglie, in gran parte già formulate dagli stessi autori degli studi prosopografici -----Enrica Salvatori
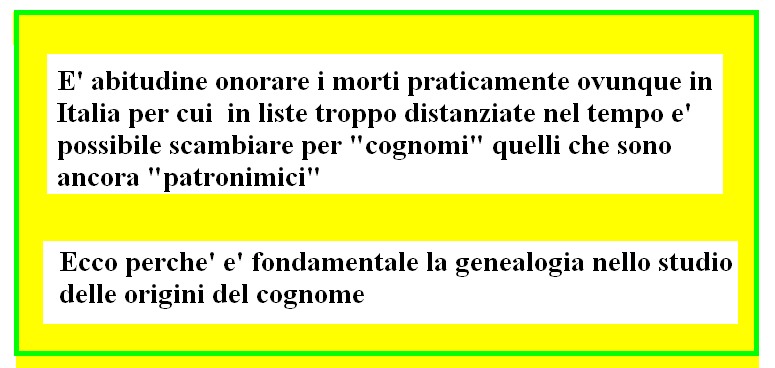
Invece e' molto utile capire quando un cognome nasce e sapere quando non lo si deve cercare nei documenti perche' non ancora esistente
porto esempi danteschi ( come piu' accessibili a tutti ) :
il Bellicione Berti Ravignani come Bellincione della famiglia dei Ravignani
il Cacciaguida dantesco proposto spesso con un inaccoglibile Cacciaguida della famiglia degli Elisei
Cacciaguida l'antenato di Dante non aveva un cognome : le varie enciclopedie che lo definiscono Cacciaguida degli Elisei sbagliano Uno perche' non e' provato da niente che tra gli antenati di Cacciaguida figurasse un Eliseo . Due perche' al tempo della nascita di Cacciaguida ( per il quale deduttivamente e convenzionalmente si considerano i seguenti dati anagrafici Firenze, 1091 circa – Palestina, 1148 circa ) a Firenze non esisteva l'uso del cognome
Eliseo fratello di Cacciaguida infatti non era uno degli Elisei era semplicemente l'eponimo degli Elisei cioe' l'antenato da cui prendono il cognome familiare
Quando si parla di Bellincione Berte dei Ravignani si parla di un personaggio che probabilmente era figlio di un Berto di un Ravignano ma non non si puo' parlare di un individuo appartenente ad una famiglia cognominata Ravignani di cui in quel tempo non esisteva il cognome a Firenze
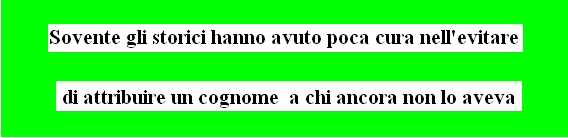
Capita anzi capitava negli anni passati che lo storico serissimo si lasciasse avviluppare nella trappola di dare a un gruppo parentale un cognome in tempi in cui non lo ha ancora (precorrendo il futuro)
Ho letto e riletto Enrico Fiumi nelle sue opere su Prato e San Gimignano e sempre una cosa mi ha dato una sensazione sgradevole
L'ottimo e acuto storico perde storicita' nel dare un cognome a individui che ancora non lo hanno , un cognome insomma che avranno solo i suoi discendenti
E mi pare che questo falsi e confonda il lettore e lo disorienti su un argomento cosi importante
A seminar confusione ha contribuito in modo massiccio la Nobilta' come classe sociale
Questa classe tento' per alcuni secoli una sorta di profondo restyiling delle proprie origini , cancellandone ogni traccia di fortuna mercantesca e sprofondandole nell'alto medioevo , con la creazione di una reticolo articolato di falsita'
Le famiglie nobili o che vantavano di esser tali ( come vedremo nella seconda parte ) infatti hanno sin dal XIV secolo costruito una falsa storia da cui ancor oggi facciamo fatica terribile a liberarci
Falsa storia con false leggende talvolta sopportate con falsi documenti ( talvolta si sono create addirittura false lapidi marmoree ) Falsate le loro origini documentabili spostandole indietro di secoli
Poiche' il concetto di nobilta' e' sempre stato uno dei piu' vaghi tra le invenzioni dell'uomo, i nostri antichi cercavano di retrodatare il piu' indietro nel tempo le origini familiari
Anche Dante Alighieri tentera' di dare antichita' alla sua famiglia e allacciarla ai primi abitatori romani di Firenze
Boccaccio con l'intento di incensare il sommo poeta inventera' Eliseo dei Frangipani venuto da Roma ad abitare in Firenze , inventando una sequenza genealogica infondata e che avvalorera' anche una famiglia Frangipani di antichita' romana e una famiglia Elisei di antichita' fiorentina con un'antichita' anteriore al mille
Praticamente ogni famiglia nobile o che aveva l'ambizione di farsi passare per tale ha creato su di se una falsa storia che ha pero' confuso , talvolta, anche molto profondamente la percezione reale della storia dei luoghi italiani ( grandi citta' e piccoli paesi ) , e che e' compito degli storici attuali cancellare via via per riportare il tutto al vero
E questo sin dai tempi piu' antichi. In ambito fiorentino e' infatti oramai prevalente la posizione di quanti ri tengono che la famosa cronaca del Malispini altro non sia che una copia tardo trecentesca di quella del Villani costruita per dare antichita' ad alcune famiglie in particolare quella dei Buonaguisi ( contiene ad esempio , la poco credibile creazione di cavalieri fatta da Carlo Magno a Firenze )
La falsificazione genealogica e' antica forse quanto il mondo
Oggi la cosa puo' apparire patetica . Poi pero' ( a riprova di quanto un simile costume abbia avuto un effetto negativo nella cultura della massa ) si leggono cose improponibili ancora oggi .Talvolta scritte in buona fede da parte di appassionati ingenui e ignoranti talaltra scritte nella piu' cosciente malafede. Spesso cassa di risonanza a invenzioni e fantasie del passato .Ho RECENTEMENTE letto su Internet di un libro pubblicato nel corrente 2020 relativo alla famiglia fiorentina degli Agli fiorentini , a cui si attribuisce ( nel 2020 ! ) l'origine da una Gens romana
E' una pazzia storico-genealogica una cosa del genere. Trionfo del kitsch : dell'ignoranza o della facciatosta . Non esiste nessuno studio storico in grado di documentare legami ( nemmeno sospetti ) tra famiglie "moderne" e gens romane ( la cesura col mondo romano e' netta segnata da una totale mancanza di patrimonio documentario ). Nemmeno le famiglie piu' importanti della Roma moderna possono superare con le loro radici il periodo medioevale. Anche tenendo conto che la citta' di Roma nel medioevo decade alle dimensioni di un paesotto di 30.000 abitanti : le possibilita' di dimostrare che una Gens romana sia sopravvissuta in mezzo ad uno spopolamento cosi massiccio ( dovuto ai lunghi periodi di pestilenze , carestie , saccheggi , uccisioni per guerre , mescolamenti razziali ) e sia riuscita a superare la decadenza economica che tende a rarefare i documenti, e ' folle
Quando qualcuno vi rimanda a personaggi del secolo XI diffidate . Ben poche famiglie sono in grado di documentare antenati nello XI secolo
VI RIMANDO AD ALCUNE CONSIDERAZIONI IMPORTANTI SUGLI ANNI DI NASCITA DEI PRIMI COGNOMI IN TOSCANA E FORSE IN BUONA PARTE DELL'ITALIA
E ALLA CONSIDERAZIONE CHE :
UNO STORICO NON DEVE IGNORARE A QUANDO DATANO I PRIMI COGNOMI NEI LUOGHI DI CUI STA RICOSTRUENDO LA STORIA; PERCHE' L'INIZIO DELLA COGNOMIZZAZIONE HA CONSEGUENZE POLITICHE E SOCIALI DA NON TRASCURARSI
E ATTIRO L'ATTENZIONE SULLA FUNZIONE DELL'ARALDICA NEL CONGELAMENTO E NELLA FISSAZIONE DEL NOME FAMILIARE
come nascono e quando i primi cognomi
B> Il cognome e lo stemma
OGGI TUTTI ABBIAMO UN COGNOME
MA OGNI FAMIGLIA ( GRUPPO PARENTALE ) HA UNA SUA STORIA
VI SONO FAMIGLIE CHE SI SONO COGNOMINATE PRIMA ED ALTRE CHE SI SONO COGNOMINATE DOPO : LA COGNOMIZZAZIONE DELLE FAMIGLIE ITALIANE E' UN PROCESSO MOLTO LUNGO CHE GIUNGE IN TALUNI LUOGHI FIN QUASI AL MILLEOTTOCENTO
CIOE' PER ALCUNE FAMIGLIE PERSISTE FIN QUASI AI GIORNI NOSTRI LA MANCANZA DI UN COGNOME STABILE
Molto interessante l'uso di un soprannome al cognome , comune a varie parti d'Italia
vedi questo saggio del dr Massimo Angelini
cultura_genealogica Soprannomi di famiglia e segmenti di parentela
Sul cognome un recente libro :
Porto l'attenzione sul dr Roberto Bizzocchi che ha pubblicato uno studio sui cognomi italiani con le edizioni Laterza
I COGNOMI DEGLI ITALIANI Una storia lunga 1000 anni
di cui consiglio vivamente la lettura
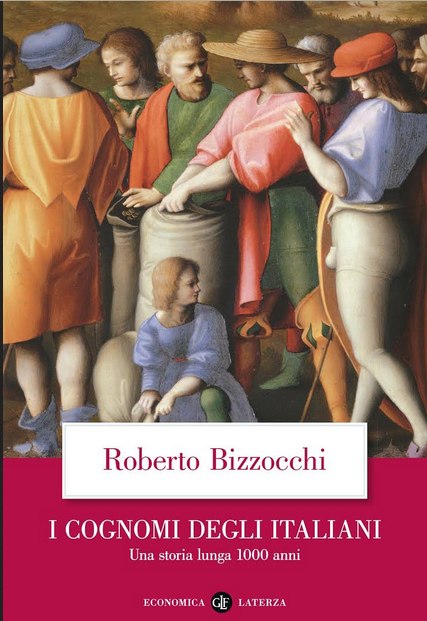
Studi di questo tipo sono rari e preziosi e con un minimo di documentazione rarissimi e' quindi un'opera utilissima che da notevoli spunti di riflessione e quindi da leggere senzaltro
Non condivido il modo di proporre alcune argomentazioni relative alla nascita del cognome , ma trovo l'opera valida e meticolosa nel mostrare il lungo percorso , non sempre senza ostacoli , che porta alla fissazione del nostro cognome cioe' del cognome nella forma che portiamo ai giorni nostri
ALBERI GENEALOGICI
L'IMPORTANTE CONCETTO DI " MRCA"
Alla base di albero genealogico globale vi e' l'importante concetto di MRCA
ALBERO GENEALOGICO PERSONALE O PLURICOGNOMINALE
E' un albero genealogico che considera solo e tutti gli ascendenti dell'individuo
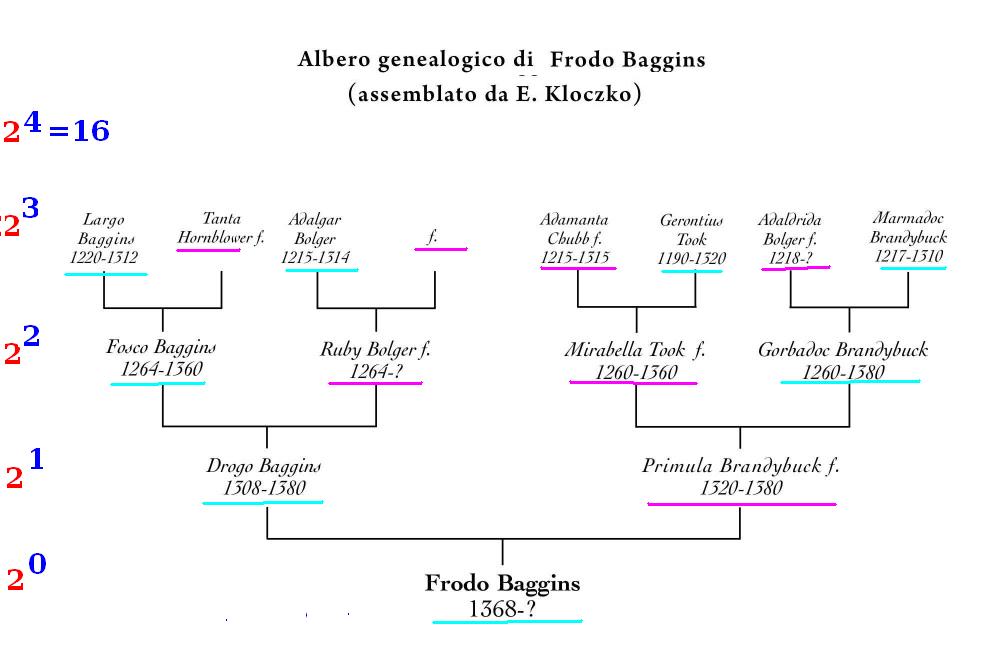
tratto da : Associazione italiana studi tolkieniani
ALBERO GENEALOGICO PATRILINEARE
che puo' essere
PARZIALE : comprende solamente il proprio padre il proprio nonno il proprio bisnonno e cosi via coinvolgendo i propri ascendenti in un filo diretto
TOTALE comprende tutti gli individui ascendenti di ugual Y-DNA ( casato = cognome + y-dna ) ,
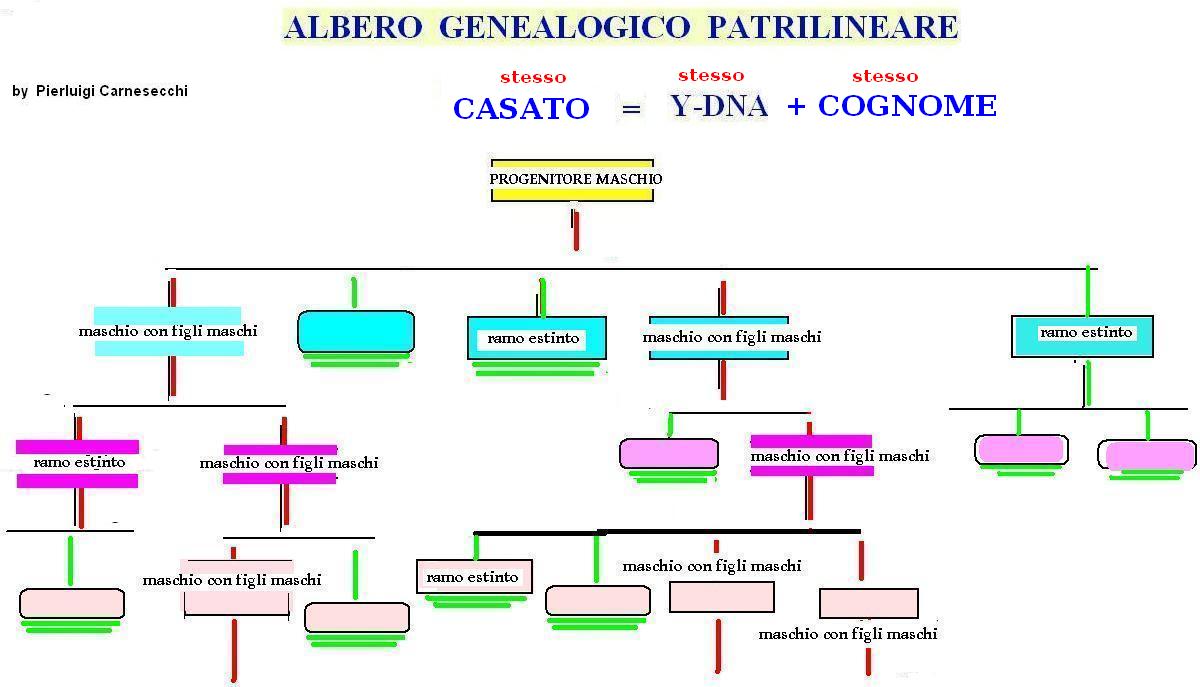
Come ho sottolineato vi e' una bella differenza , anche concettuale, tra l'albero genealogico individuale o pluricognominale ” e l'albero genealogico patrilineare”
L'albero genealogico patrilineare e' legato al CASATO ( cognome e Y-DNA) quindi l'unico con cui la genetica in futuro potra' formare un tuttuno
L'albero genealogico individuale di un individuo e' composto di un numero grandissimo di cognomi e di personaggi tanto che con le medesime parole del dr Degli Uberti possiamo mostrare l'illogicita' e , volendo, l’ingiustizia di estrapolare solo alcuni cognomi da unire al nostro tra i tanti cognomi che fanno parte del nostro passato
FONDAMENTALE e' che' :
Apparteniamo tutti ad un albero globale , di cui l'albero personale e parentale sono semplici estratti
Chiaramente considerando ascendenti e discendenti e ascendenti degli ascendenti e dei discendenti , e discendenti degli ascendenti e dei discendenti considerando i legami per via maschile e i legami per via femminile noi siamo evidentemente semplicemente :
“parenti di tutti, ....cugini di tutti insomma”
e non c'e' grande personaggio che non possiamo con un po' di pazienza ricollegare al nostro “albero genealogico individuale”
E' evidente come i fattori distintivi di ogni individuo siano legati al DNA della Eva primordiale ( qualunque cosa s’intenda ) e al DNA dell’Adamo primordiale ( qualunque cosa s’intenda ) e ad un infinita' di apporti cellulari casuali tra gli infiniti che si accalcano Il cognome convenzionalmente nella nostra societa' si trasmette per via maschile e si lega pertanto coerentemente al solo Y-DNA
E’ evidente che la scelta di legare il cognome allo Y-DNA indirizza l’individuazione e che l’aggiunta di cognomi di diverso Y-DNA e’ una forzatura manifesta del sistema
Cosi un Toscano odierno puo' con poco impegno trovarsi parente con i Medici o gli Albizi o i Buondelmonti ed anche con Napoleone Bonaparte senza voler scomodare Carlo o Nefertiti o Confucio
Io sostengo che gli studi sullo Y-DNA sono ancora oggi 2024 , in fase embrionale e lo saranno ancora per un certo lasso indefinito di tempo
Un giorno saranno invece sicuramente risolutivi e ci daranno risposte genealogiche che oggi non sappiamo comprendere.
viewtopic.php?f=46&t=25243
Non oggi quindi , ma in futura saremmo in grado di verificare gli alberi genealogici patrilineari mediante lo y-DNA degli individui viventi dell'albero
Conviene quindi ad una sorta di trasparenza e coerenza genealogica limitarci al cognome singolo ( ove non vi siano motivi reali di confusione) nell'identificazione conservando e trasmettendo con cura inalterata l'impronta dello Y-DNA ricevuto dagli antenati
Ho voluto mostrare come implicitamente quella da me esposta sui cognomi multipli non e' una posizione isolata ma anzi dal punto di vista “genetico” e' la posizione comune
L'adozione di cognomi multipli, dovrebbe dal cultore delle nostre materie essere quasi sempre evitata
Utilizzato spesso nell’ambito della genealogia umana, il termine MRCA è l’acronimo di Most Recent Common Ancestor, ed indica il progenitore da cui tutti gli organismi di una specie sono discendenti diretti.
Ecco come il dr Degli Uberti divulga al grosso pubblico la realta' dello "antenato comune piu' recente" ( e implicitamente da una risposta alla illogica dell'uso di cognomi multipli )
https://www.progetto-radici.it/2021/02/ ... a-pensare/
L’antenato comune di tutta l’umanità è molto più vicino di quanto si possa pensare
By Pier Felice degli Uberti 19 Febbraio 2021
Avete mai pensato quanto è lontano genealogicamente da noi l’antenato comune a tutta l’umanità? Vi sembra uno stacco genealogico lontanissimo? Non è così ! Ricordate che se la durata della nobiltà, come noi l’intendiamo oggi, la si può definire più corta di un battito d’occhi nella storia dell’umanità, parrebbe che tutti noi abbiamo fra gli antenati dei sovrani che hanno retto le sorti di molti popoli e Nazioni. Dobbiamo quindi porci il seguente interrogativo: quanti antenati abbiamo?
Non sembra una domanda difficile, ma gli studiosi di genealogia cercano da anni di dare una risposta certa senza risultato. Ad ogni generazione ascendente si raddoppia il numero degli antenati (due genitori, quattro nonni e così via) quindi abbiamo ben 1024 antenati in 10 generazioni. Se poi facciamo il conto utilizzando 40 o 50 generazioni, il risultato finale provoca più di un trilione di antenati, che è più del numero di persone che hanno mai vissuto sulla terra. Questo dimostrerebbe che saremmo difronte al collasso della genealogia, non è così? Purtroppo non avendo dati italiani perché non siamo ancora avanzati in questi studi, devo attenermi a quanto è stato pubblicato sinora negli USA o nel Regno Unito, facendo riferimento agli studi svolti nelle isole britanniche, che pur presentando caratteristiche specifiche che potrebbero risultare diverse nel caso del continente europeo, nonostante tale premessa ci possono aiutare a capire la problematica.
Se nel 1215 vi erano in Inghilterra circa 2,5 milioni di persone, ciascuno dei residenti dell’Inghilterra del 1300 è un antenato di quasi tutti i britannici di oggi. La ricerca scientifica lo supporta: infatti in un articolo di demografia genealogica del lontano 1980 “Gli antenati alla Conquista normanna”, il demografo Kenneth Wachter ha calcolato che da 1,11 milioni di abitanti dell’Inghilterra alla conquista normanna del 1066 circa l’86% sono gli antenati di tutti i residenti attuali dell’Inghilterra.
Robin Fox, professore dell’università di Rutgers, ha stimato che l’80% dei matrimoni genealogicamente arcaici avvengono per forza tra cugini secondari lontani genealogicamente, così le stesse persone sono più volte ascendenti diretti, pertanto vediamo che l’albero genealogico si restringe sempre di più andando indietro con le generazioni. Questa riduzione di numero di antenati comuni dimostra che siamo tutti cugini (ovviamente o per lato paterno o materno o per entrambi i lati). Brian Pears, genealogista inglese e fisico, nonché programmatore di computer afferma, riferendosi come esempio alla popolazione della Gran Bretagna, che se ogni singolo matrimonio è avvenuto fra lontani cugini, allora in 30 generazioni avremmo ben esattamente 4.356.616 antenati, che è più della popolazione britannica dell’epoca.
In un articolo del 1999 intitolato “Recenti antenati comuni di tutti gli individui di oggi” Joseph Chang, professore di statistica all’università di Yale, ha mostrato come si può riconciliare il numero potenzialmente enorme dei nostri antenati con i quantitativi di persone che in passato hanno vissuto.
Il suo modello è una prova matematica che si basa su astrazioni come le distribuzioni di Poisson e le catene di Markov, ma può essere facilmente applicata al mondo reale. Nelle condizioni descritte nel suo articolo, l’antenato comune più recente di ogni europeo oggi (tranne che per i recenti immigrati al continente) era qualcuno che viveva in Europa in un passato sorprendentemente recente, solo 600 anni fa. In altri termini, tutti gli europei viventi oggi avrebbero tra i loro antenati lo stesso uomo o donna che viveva intorno al 1400. Prima di quella data, secondo il modello di Chang, il numero degli antenati comuni a tutti gli europei di oggi andò aumentando finché, circa 1000 anni fa, sarebbe prevalsa una situazione peculiare.
..............
Così il 20% degli europei adulti non avrebbe avuto discendenti che sopravvivono alla nostra epoca, mentre ognuno dell’80% restante sarebbe certamente un antenato di tutti i viventi oggi in Europa. Ovviamente questo studio non si basa su documenti (impossibili da trovare), ma sul semplice calcolo delle probabilità matematiche, che avranno riscontro nei prossimi anni quando disporremo di una mappatura genetica che ci permetterà di fare seri confronti nella popolazione. Il modello di Chang comprende un presupposto cruciale: l’accoppiamento casuale nella parte del mondo in esame. Ad esempio, ogni persona in Europa avrebbe avuto la stessa possibilità di sposare ogni altro europeo del sesso opposto. Come Chang riconosce nel suo lavoro, l’accoppiamento casuale non si manifesta nella realtà; un inglese è molto più probabile che sposi una donna inglese che una donna italiana, e così pure una principessa è molto più probabile che sposi un principe che un povero.
Queste partenze dalla casualità devono modificare in qualche modo la data degli antenati comuni più recenti degli europei. A Dublino Mark Humphrys, uno scienziato informatico presso la University of Dublin City che ha iniziato i suoi studi genealogici prima e dopo internet, suggerisce nella sua pagina web che in molte generazioni i modelli di accoppiamento possono essere molto più casuali del previsto. La mobilità sociale rappresenta una parte della miscelazione: ciò che Voltaire chiamava i piedi pigiati che scendevano lungo le scale, mentre gli stivaletti a cavallo li salivano. Allo stesso tempo, le rivoluzioni rovesciano gli ordini stabiliti, i paesi invadono e colonizzano altri paesi, e le persone a volte scelgono compagni da lontano, piuttosto che dalla porta accanto. Anche i più isolati del mondo – gli isolani del Pacifico, ad esempio – continuano a scambiare potenziali compagni con i gruppi vicini. Questa costante perdita di persone permette di applicare l’analisi di Chang a tutto il mondo. Ad esempio, quasi tutti nel Nuovo Mondo devono discendere da inglesi, persino persone di origine africana o nativa americana, a causa della lunga storia del matrimonio tra le Americhe. Pensate a grandi personaggi della storia come Giulio Cesare o Cleopatra e a quale distanza genealogica potrebbero essere con noi. Dovete sapere che allo stesso modo, quanti nel mondo di origini europee devono discendere da Maometto, come del resto discendono oggi Elisabetta II e Filippo VI in quanto hanno come ascendente la figlia dell’emiro di Siviglia, che si era convertita dall’Islam al cattolicesimo. Il modello di Chang ha implicazioni ancora più drammatiche. Poiché le persone migrano sempre da un continente all’altro, le discendenze si collegano velocemente. Ciò significa che il più antico antenato comune di tutti i 6 miliardi di persone sulla terra viventi oggi, ha vissuto probabilmente solo un paio di migliaia di anni fa; quindi la maggior parte delle persone del pianeta erano gli antenati diretti di tutti noi.
Confucio, Nefertiti, e quasi ogni altra figura storica antica, anche moderatamente prolifica, deve essere contata tra gli antenati di tutti. Lo stesso processo lavora avanti nel tempo; in sostanza ognuno di noi che ha figli possiede una linea che non va estinta ed è sospesa al centro di un’immensa clessidra genetica. Proprio come siamo discesi dalla maggior parte delle persone viventi del pianeta poche migliaia di anni fa, così fra diverse migliaia di anni, ognuno di noi sarà un antenato dell’intera razza umana, o di nessuno.
La densità di interconnessioni della famiglia umana potrebbe sembrare assumere alcune emozioni dalla ricerca genealogica. Humphrys vuole dimostrare che le radici di tutti ritornano allo stesso albero genealogico, ma ogni percorso al nostro passato comune è diverso e ricostruire quel percorso, utilizzando qualsiasi registrazione, potrebbe essere fattibile. Così si può ipotizzare che tutto il mondo occidentale sia discendente da Carlo Magno, e parrebbe certo che siamo tutti discendenti da Carlo Magno. ..................................................
A quanto dicono gli studiosi parrebbe che solo 1400 anni fa avemmo almeno uno stesso antenato comune che potrebbe appartenere sia al ceto dominante che alla più bassa classe sociale. Quindi, se vogliamo fare le “prove genealogiche” per dimostrare una diversità, ben venga, ma facciamole per tutti, e chissà che non si arrivi a comprendere che ci sono famiglie storiche sia a livello europeo che a livello locale, che magari hanno avuto più peso nella società di una famiglia nobile che vi ha inciso una tantum per una sola generazione, avendo poi vissuto nei discendenti di inconsistente luce riflessa; .............................
https://www.progetto-radici.it/2021/02/ ... a-pensare/
Ritengo di scarso significato , ricostruire un albero pluricognominale , seguendo l'ascendenza di una molteplicita' di cognomi perche fondamentalmente risalendo le generazioni noi siamo parenti di tutti e di tutte le famiglie dovremmo ricostruire la storia
Ritengo abbia piu' significato per un maschio seguire le tracce del suo Y-DNA e poiche' per antica tradizione il cognome viene trasmesso per via mascolina , seguire le tracce del cognome paterno
Per una femmina avrebbe piu' logica seguire le tracce del DNA mitocondriale della madre , con maggiori difficolta' , seguendo un cambio di cognome generazione per generazione
Chi fa ricerca genealogica usa metodi misti seguendo
le ascendenze di uno o piu' cognomi dal punto in cui inizia la discendenza : ma gia' in quarta si trova alle prese generalmente con 16 cognomi
le ascendenze del proprio cognome seguendo il filo figlio--padre
le ascendenze del proprio cognome estesa a tutti i componenti di ugual cognome che compongono l'albero
Ognuna di queste ricerche ha la sue difficolta' specifiche
Qualunque tipo di ricerca si voglia fare pero' il metodo e' sempre il medesimo : seguire le tracce di quel cognome
Qualunque tipo di ricerca costruisce uno o piu' alberi ciascuno riguardante un cognome diverso
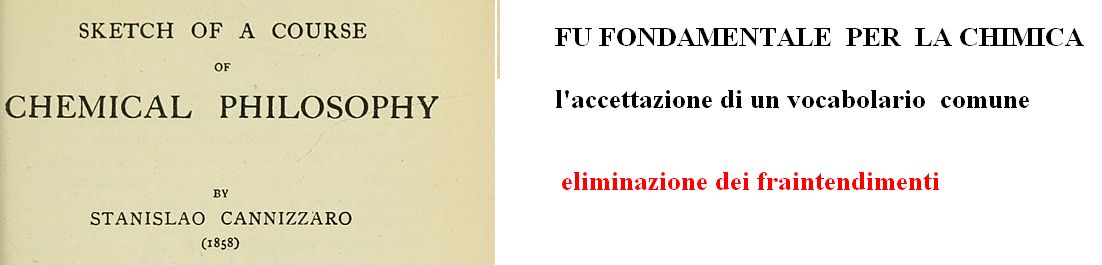
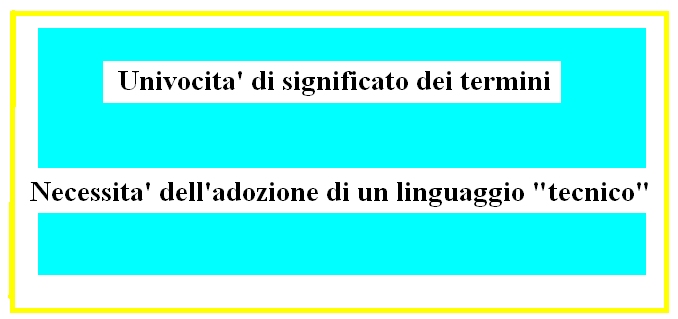
Utilizziamo pochi vocaboli per tentare di chiarire i concetti
CAPOSTIPITE, STIRPE , SANGUE , GENEALOGIA PATRILINEARE o ALBERO GENEALOGICO PATRILINEARE , e , COGNOME , CASATO o CASATA
la pur ricchissima lingua italiana e' di fatto ambigua
Questo perche' la STORIA di FAMIGLIA e la GENEALOGIA sono solo di recente acquisizione alla STORIA come SCIENZA AUSILIARIA e quindi mancano ancora di un linguaggio specifico ( direi tecnico ) che permetta precisione comunicativa e uniformita' di comprensione del significato
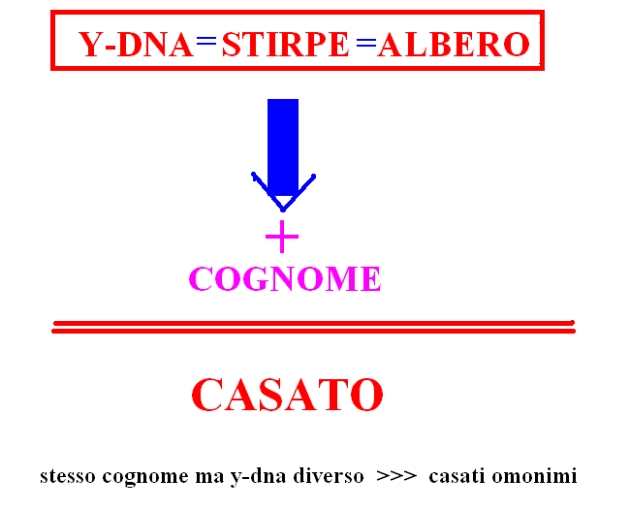
E' un errore diffusissimo il ritenere che individui con lo stesso cognome siano in qualche modo sempre sicuramente parenti tra loro : cioe' collocabili in uno stesso albero genealogico patrilineare
Nonostante la diffusione della convinzione non e' cosi

per definirsi parenti patrilinearmente dobbiamo stabilire l'appartenenza ad un unico albero genealogico patrilineare ( quindi ad un albero che parte da un medesimo stipite e comprende individui maschi con lo stesso Y-DNA, o che si presuppone lo stesso)
Ed eccoci all'importanza della ricostruzione genealogica
ALBERO GENEALOGICO = Stabilisce se esiste una parentela patrilineare tra individui del presente e individui del passato , e quindi presuppone aver ricavato tutte le linee genealogiche a partire da un'individuo (stipite, capostipite , talvolta eponimo ) comunque collocabile nel passato prima o dopo la formazione del cognome o dei cognomi
Per il meccanismo di formazione del cognome moderno e' successo anche questo
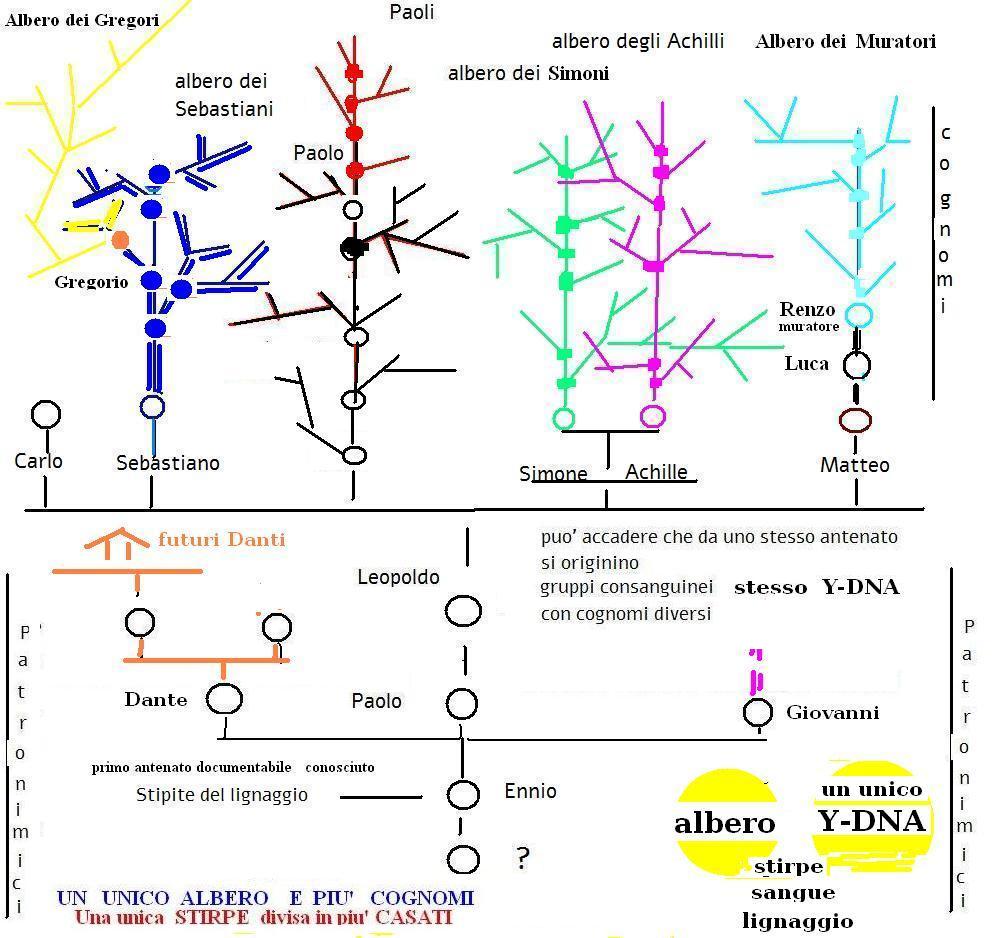
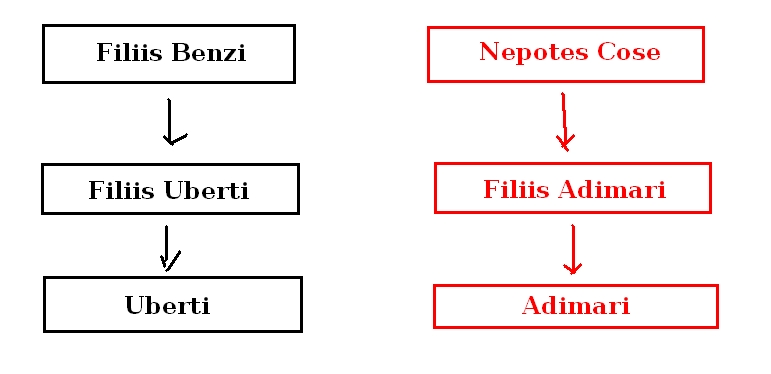
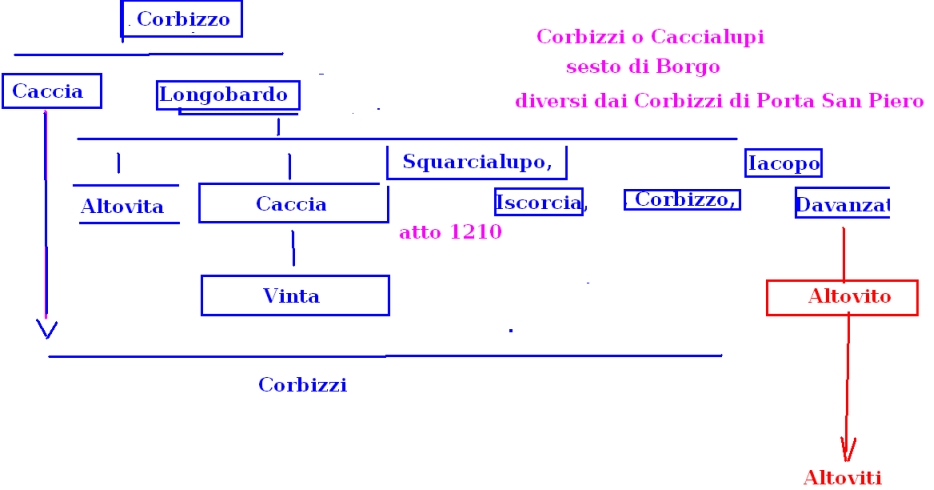
2,1 milioni di anni fa - Compare il genere umano, con la specie dell'Homo habilis. Aveva una scatola cranica più sviluppata degli ominidi che l’avevano preceduto, ma mascelle relativamente meno potenti, perché la sua dieta era diventata onnivora: comprendeva cioè una buona base di carne, che si procurava facendo lo “spazzino”, cioè scacciando iene e altri predatori dalle carcasse degli animali morti, spesso agendo in gruppo con altri simili. I suoi utensili di pietra servivano soprattutto a rompere le ossa per mangiare il midollo, un cibo molto nutriente.
Per arrivare alla meta' del XII secolo quando iniziano ad apparire, in modo percentualmente ridotto, i primi cognomi in tutta Italia si susseguono generazioni su generazioni. Quasi 80.000, Pensate quale ragnatele di legami parentali che non hanno trovato codificazione in un cognome unico e quale enorme albero genealogico patrilineare si potrebbe ricostruire collegando i figli ai padri in anni cosi lontani
Il cognome comincia a diffondersi nel XII secolo , e la sua diffusione e' lentissima
Bisogna arrivare al periodo posteriore al 1614 ( con l'imposizione della Chiesa cattolica , comunque non ovunque rispettata ) per arrivare a una diffusione generalizzata dell'uso del cognome
Laddove il cognome manca e' facile che la parentela si perda definitivamente
Poi alcuni prendono cognome altri no. Ed infine puo' essere che i parenti si ritrovino con molti cognomi diversi
L 'albero di una stirpe puo' , per il meccanismo di formazione del cognome moderno , generare quindi individui con cognome diverso
Un unico albero ,una medesima stirpe, da luogo a cognomi diversi
Questo ad esempio avveniva nel momento in cui la stirpe cominciava a cognominarsi ,quando fratelli davano origine a linee che venivano individuate dalla gente con identificativi diversi.
Questo ad esempio avveniva talvolta spostando il luogo di dimora Avveniva che la famiglia subisse la modifica del cognome da parte dei locali
MA IL PIU' DELLE VOLTE DOPO la meta' del secolo XII TROVIAMO UN ALBERO PATRILINEARE ASSOCIATO AD UN UNICO COGNOME ( SOTTOLINEO UNO STESSO COGNOME E' IN GENERE SEMPRE ASSOCIATO AD ALBERI PATRILINEARI DIVERSI)
E' FONDAMENTALE FAR DISTINZIONE TRA COGNOME E CASATO
Chiamiamo CASATO O CASATA = ALBERO (Y-DNA) + COGNOME
DISTINZIONE TRA COGNOME E CASATO
Un gruppo di individui che hanno la stessa genealogia , lo stesso albero genealogico PATRILINEARE e quindi si presippone abbiano lo stesso Y-DNA si dice ANCHE che sono della stessa STIRPE, SANGUE . Un gruppo d'individui che appartengono allo stesso albero patrilineare ed hanno lo stesso COGNOME si dice che sono dello stesso CASATO
Il cognome e' un identificativo ,e puo' appartenere a stirpi diverse .Quando due stirpi diverse hanno il medesimo cognome si dice che siamo in presenza di una semplice omonimia non di parentela
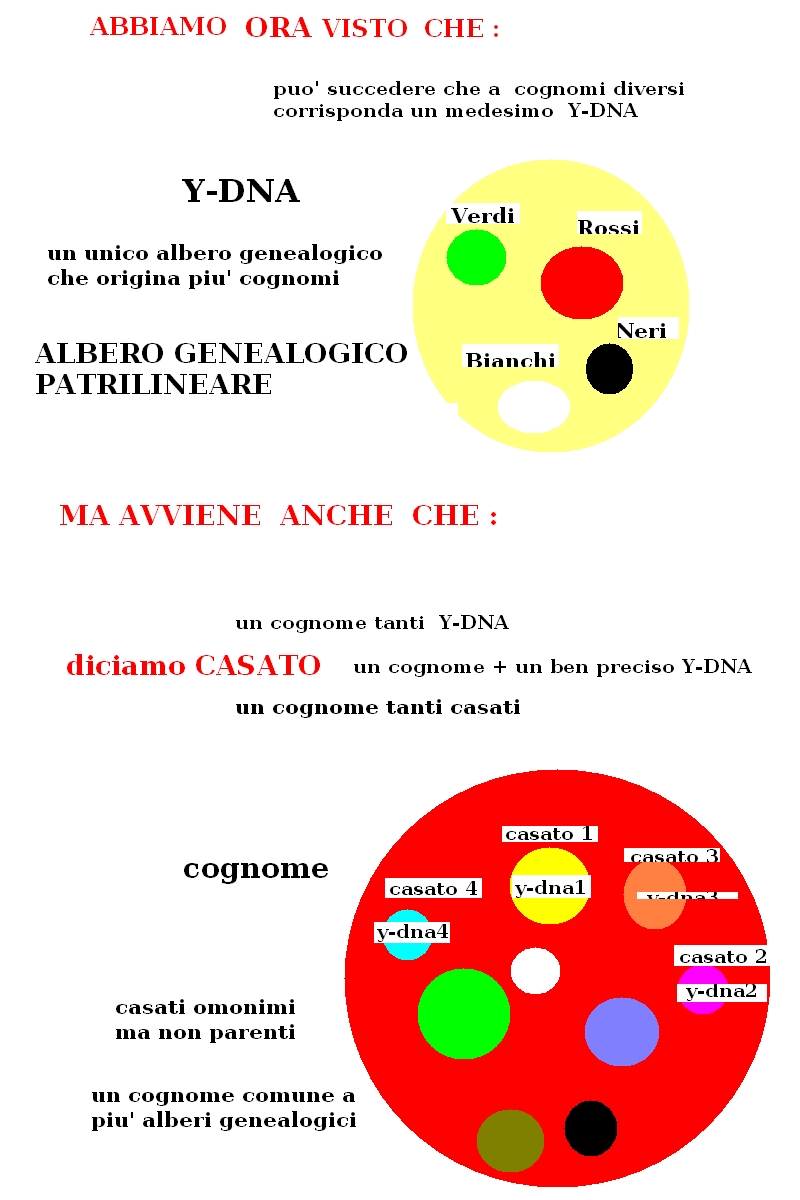

RIPETIAMO
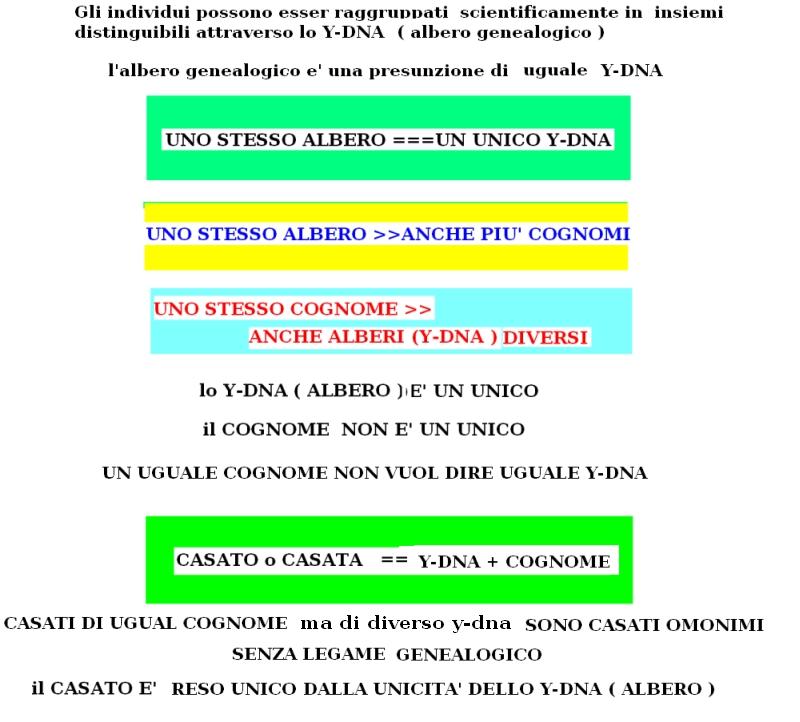
Testamenti, contratti, libri di ricordi, lettere testimoniano che, pur nell'oscillazione dei termini, i lucchesi del Quattro-Cinquecento, ma anche quelli dei secoli seguenti, distinguono una linea parentale stretta, che in genere chiamano famiglia (ma possono anche indicare con il termine di casa), dal più generale insieme della discendenza di sangue (i cognati), indicato o con casa, in contrapposizione a famiglia, oppure con casato, contrapposto a casa.
Solo due esempi, tra gli innumerevoli possibili, possono essere sufficienti. Al termine di una complessa trattativa per il rinnovo di una compagnia mercantile ad Anversa, che ha visto nell'estate 1540 liti sanguinose tra Vincenzo Guinigi ed i cugini Baldassarre e Bernardino, Vincenzo, importante e savio uomo politico oltre che grande mercante, dall'alto della sua vittoria contrattuale, ha parole di riconciliazione: « ragionevolmente habbiamo da restare una casa medexima, et questo è stato e sarà sempre »•
In questo contesto «casa», a cui si connette il senso della perpetuità, equivale a «casato».
Lo stesso Vincenzo, ormai debole e malato, nel maggio 1549 scrive a uno dei giovani figli che, inviato ad Anversa per il consueto periodo di apprendistato mercantile, fa di tutto tranne che imparare l'arte della mercatura, e soprattutto dilapida scudi su scudi.
Il vecchio padre è esasperato: « Mi sono resoluto che ti sia entrato del tutto il diavolo addosso, e che tu sia solo nato per l'infamia sola non solo di casa mia, ma di tutto il nostro casato.
È possibile sfacciato ribaldo ... » e giù una serie di improperi dettati dall'angoscia di non lasciare dietro di sé un valido sostegno per il mantenimento della famiglia .
Qui la distinzione tra « casa mia» e « nostro casato» è chiara e non richiede alcun commento. La percezione di queste due differenti entità, « la famiglia economica» e « la famiglia politica», era troppo concreta esperienza di vita privata e di logiche pubbliche nella Lucca moderna per aver bisogno di ulteriore sottolineatura.
Mi limito a richiamare la consacrazione che tale approccio ha trovato sia nei registri delle contribuzioni straordinarie, sia nelle compilazioni di carattere politico, si tratti di documenti ufficiali della Repubblica o dei (preziosi) centoni raccolti da privati eruditi settecenteschi.
Nei primi, le singole « famiglie economiche» cittadine venivano distintamente elencate,ma all'interno dell'imponibile complessivo di tutti coloro che portavano lo stesso cognome ; nelle seconde si rilevava con quale frequenza ciascun consortato avesse visto assurgere alle massime cariche della Repubblica propri esponenti, assommando i membri di tutti i rami, anche dei più marginali sia come status che come ricchezza.
l.'.espressione grafica di tale duplice appartenenza, alla famiglia e al casato, è naturalmente l'albero genealogico, nel quale i singoli rami assumono contorni via via più delineati, fin quasi (ma, con poche eccezioni, solo quasi) a prendere consistenza autonoma•
Un caso esemplare è quello dei Mansi, che nei primi decenni del Cinquecento si diversificano in almeno quattro rami principali che, dall'ubicazione del palazzo avito, prendono i nomi di Mansi di S. Pellegrino, Mansi di S. Pietro Somaldi, Mansi di S. Donnino, Mansi di S. Maria Bianca.
E tuttavia, ancora nel Settecento, quando le parentele di sangue si sono ancor più allentate, non è affatto raro trovare tra i tutori di un minore esponenti di un altro ramo del consortato.
Dal punto di vista giuridico-istituzionale, sia lo Statutum de regimine, del 1446-47, che gli statuti e le leggi successive, distinguono la parentela dal consortato, e definiscono quest'ultimo come l'insieme di tutti coloro che portano lo stesso cognome e, ancor più, si riconoscono nella stessa arma nobiliare.
Così quando, nel 1626, in Consiglio c'è del malumore per elezione di un Guinigi-Magrini in una congregazione che vedeva già la partecipazione del numero massimo di tre esponenti del consortato dei Guinigi, il Gonfaloniere può tacitare la protesta con questa considerazione: « esso non tiene più l'arme de i Guinigi, ma de Magrini» •
Mentre si dichiarerà non valida l'elezione nel 1704 di due Arnolfini, sia pure di terzieri diversi , come anziani nello stesso collegio in quanto « d'una medesima famiglia, che portino l'istessa arme ».
by Famiglie e potere nella Lucca moderna [article]di Renzo Sabbattini
https://www.persee.fr/doc/efr_0223-5099_2009_act_422_1_9885
DEL MODO DI FARE RICERCA GENEALOGICA
La mia ricerca sul mio cognome e' nata per caso , poi il piacere di conoscere meglio la STORIA ha preso il sopravvento ed ho cominciato a studiare ( o meglio a leggere di ) in particolare la storia fiorentina e del suo comitato , tentando di seguire la vita di gente che veniva identificata col mio stesso cognome
Quando sono partito ero molto ignorante
Quando ho iniziato a costruire questo sito ero fortunatamente ignorante e presuntuoso
L'ignoranza talvolta aiuta infatti e' come una nebbia che ti avvolge e ti impedisce di vedere le difficolta' e quindi ti impedisce di scoraggiarti
ho importunato coi molti con quesiti sciocchi e con le mie ipotesi strampalate
Oggi sono un po meno ignorante
ho costruito a pezzi e bocconi un piccolo manuale di ricerca genealogica che ho proposto sul sito , ed ho maturato una mia convizione su come si dovrebbe fare ricerca genealogica
A l'albero genalogico personale ( due genitori, quattro nonni , otto bisnonni, sedici avoli, ........)
B l'albero genealogico pluricognominale ( prendere in considerazione i parenti piu' prossimi ai nostri antenati )
C l'albero genealogico patrilineare (medesimo y-dna )
D l'albero genealogico di un cognome (y-dna diversi )
Io alla fine ho scelto la soluzione D
Dicono che i cognomi italiani siano circa 350.000 sarebbe interessante almeno a livello regionale fare uno studio sui vari cognomi,
Sarebbe interessante vedere lo sviluppo di cognomi omonimi nelle varie zone
RICERCA GENEALOGICA= In definitiva la ricerca genealogica consiste nello interrogare i documenti , seguendo un cognome e valutando se l'individuo trovato fa parte del casato cercato oppure e' solo un omonimo
|
Di un qualunque casato ( gruppo parentale col medesimo cognome ) a caso . possiamo dire che l'assunzione del cognome avviene tra il 1100 ed il 1800 Coesistono cosi in questo intervallo temporale gruppi parentali cognominati (casati ) e gruppi parentali privi di un cognome stabile Michele Luzzati esamina la situazione di Pisa nel quattrocento :
una ricerca del dr Michele Luzzati Prima del cognome
Memoria genealogica in assenza di cognome nella Pisa del Quattrocento studio di Michele Luzzati Publications de l'École Française de Rome Année 1986 90 pp. 87-100
Fino al 1200 in quasi tutti i luoghi italiani non esisteva il cognome come lo intendiamo noi ( questo salvo rarississimi casi : Veneto..... ) Le persone uscendo dall'eta' delle invasioni si distinguevano solo coi patronimici Nome con eventuale soprannome , nome del padre , nome del nonno eventualmente il mestiere , eventualmente un luogo di provenienza Qualcuno un cui antenato si era particolarmente distinto nell’immaginario collettivo godeva di una specie di cognome dei figli di Gioco , dei nipoti di Pesce , degli uomini detti Capoinsacchi , ……. Quando lo scambio della proprieta’ immobiliare si fa piu’ vivace si avverte la necessita di un identificazione piu’ sicura dell’individuo negli atti notarili , identificazione che superi il filtro del tempo che renda semplice agli eredi nel futuro il dimostrare la legittimita’ di una proprieta’
Uno studio di molta importanza di ricostruzione delle genealogie delle famiglie fiorentine nello XII secolo del dr Enrico Faini Genealogie fiorentine ...........................GENEALOGIE FIORENTINE secolo XII by DR ENRICO FAINI
Nasce il cognome ( questo legato comunque all’identificazione che gli altri davano all’individuo ) alcuni gruppi parentali si cognominano gia’ nelle prime decadi del millecento per moltissimi altri il processo sara’ di stabilizzazione in un cognome sara' assai piu' tardo Dal 1560 il concilio di Trento obblighera’ ad avere un'individuazione, dovendo i parroci istituire i registri dei battezzati ( per evitare matrimoni tra consanguinei ), dal 1614 si chiedere' ai parrocci di utilizzare per tutti una cognomizzazione, ma non dovunque la disposizione sara’ rispettata Si arrivera’ anche al 1700 e persino al 1800 senza una cognomizzazione o senza una cognomizzazione stabile in taluni piccoli luoghi dove compaiono ancora famiglie senza cognome E’ evidente che per quanto indietro si possa risalire quando dal sistema cognominale si passa al sistema patronimico le difficolta’ di riconoscimento dei nostri antenati diventano grandissime Penetrare sotto l’anno 1150 e’ un eccezione Mi pare evidente che il sistema patronimico favorisca la disgregazione familiare ( individui di una stessa famiglia dopo alcune generazioni sono disgregati e con grosse difficolta' a stabilirne origini comuni ) le attestazioni Alberto di Guido di Alberico e Rosso di Guido di Alberico fanno pensare alla possibilita' di trovarci di fronte a due fratelli Luigi di Alberto di Guido e Iacopo di Rosso di Guido cominciano a perdere l'evidenza della paentela Giacomo di Luigi di Alberto e Enrico di Iacopo di Rosso paiono aver perso gli elementi distintivi della parentela
Il sistema a cognome aggiunge sicuramente qualcosa Fatte salve le omonimie , che possono verificarsi per la presenza d'identificazioni uguali in luoghi diversi (Fabbri : i figli del fabbro a Pisa e i figli del fabbro a Pistoia;i figlio del Rosso di capelli...................... inserisce nell'identificazione un elemento che puo' essere ereditato e quindi trasmissibile che da un'evidenza di parentela anche dopo molte generazioni
|
|
considerazionigenealogiche Il cognome quasi sempre ( ci sono eccezioni particolari ) sono stati gli altri a darcelo In Italia, l'uso di una specie di cognome è, inizialmente, una prerogativa delle famiglie feudali. Nel senso che vengono individuati dagli altri o per un nome che si ripete nella genealogia o per un luogo su cui esercitano il potere feudale o per il luogo di un loro castello Il cognome vero e proprio credo che esclusa l'area veneta si diffonda quasi ovunque in Italia tra il 1150 e il 1200 ( probabilmente catalizzato dalla diffusione dell'araldica ) ed il fenomeno riguarda prima il ceto dirigente per poi estendersi lentissimamente agli altri soppiantando il sistema patronimico ( in alcuni luoghi alla fine del settecento non esistono ancora cognomi stabili ) il ceto dirigente e' qualcosa di mobile per cui tendono ad emergere sempre nuove famiglie ed altre ad uscirne , per cui vi e' un continuo fissarsi di nuovi cognomi Poi il cognome ,come detto, si estende anche fuori dai ceti dirigenti Fare considerazioni sulla diffusione del cognome all'interno dei vari strati della societa' non credo sia sempre facile A Firenze si riesce a fare questo calcolo per mezzo del çatasto ( misura fiscale ) istituito nel 1427 il 36% delle dichiarazioni cittadine appartiene a individui ( capofamiglia) cognominati il 64 % e' ancora legato al sistema patronimico ( ovviamente la parte del leone tra i cognominati e' fatta dalle famiglie del ceto dirigente ) . Infatti a seguito della grande crescita demografica
avvenuta in Europa tra il X secolo e l'XI secolo, divenne sempre più complicato
distinguere un individuo da un altro usando il solo nome personale ( o un
soprannome ) ed il nome del padre. L’aumentata circolazione delle merci e
l’aumentata circolazione di denaro e di trasferimenti mobiliari ed immobiliari
rende necessario indicare negli atti di compravendita o di affitto o di
prestito , ecc…, con precisione i
contraenti . La voce popolare identifica ogni
individuo , e quando le persone cominciano ad essere tante , adotta
degli stratagemmi per non confondere individui con lo stesso nome , in modo che
ogni singolo sia facilmente e senza equivoco riconosciuto da tutti. Il nome insieme al nome
del padre e del nonno ( meno frequentemente quello della madre ) sono
l’indicazione piu’ comune, ma spesso compare anche il mestiere o il luogo di provenienza ( nel caso di persone
provenienti da altri luoghi ) oppure un soprannome ( vocato ,detto, chiamato ….
) Cosi oppure l'indicazione del padre e della madre (es. Petrus Leonis
equivaleva a Pietro figlio di Leone) o spesso il riferimento ad un membro della
famiglia molto conosciuto (eponimo)oppure
la provenienza (Montanaro, Dal Bosco, ecc.) oppure un nomignolo
originato da un pregio o difetto fisico (Gobbo, Rosso, Mancino, ecc.), oppure
dal mestiere (Sella, Ferraro, Marangon, ecc.) Il notaio cerca d’identificare con la maggior accuratezza
possibile i contraenti di un atto
perche’ si possa risalire ai contraenti anche nel futuro. Adotta cosi quasi le medesime convenzioni A lungo andare si fissa un mezzo di riconoscimento che
vale a distinguere i componenti di una famiglia e viene a valere per tutti i discendenti Uno studioso di genealogia dovrebbe iniziare i suoi studi PRIMA dalla cognomastica ) come diceva Giovanni Grimaldi nel forum IAGI ) Infatti l’etimologia del cognome puo’ dare indicazioni preziose su fatti
riguardanti la famiglia avvenuti in passato
Nell'analisi di un cognome si dovrà tenere dunque presente l'epoca di formazione della forma originaria e la zona di attestazione, perchè un cognome potrà risentire della lingua (e/o dialetto locale), successive trasformazioni fonetiche ecc. ( Grimaldi nel forum IAGI ) Da notare che per circostanze diverse , ma spesso per una
migrazione , una famiglia puo’ modificare il cognome perche’ la gente del posto
gli impone una nuova identificazione oppure talvolta l’imporsi di un uomo
particolarmente in vista puo’ dar vita ad un nuovo ramo che da quest’uomo
prende il nome ). E questo fatto puo’ anche ripetersi A volte e' la prolificita' della famiglia ad ostacolare l'individuazione dei singoli , specie in aree non molto estese , nel qual caso i soprannomi divengono spesso un secondo cognome che alla lunga finisce per sostituire il primo E questo cambiamento di cognome puo’ anche ripetersi
Un cognome gia' stabilizzato puo' quindi mutare Cambiando il luogo di residenza Per un fatto od un personaggio che mutano la fama del gruppo parentale per una questione di prolificita' (soprannome)
Il Concilio di Trento terminato nel 1563 sancisce l'obbligo per i
parroci di gestire un registro dei battesimi con nome e cognome, al fine di
evitare matrimoni tra consanguinei e finisce per rendere obbligatorio a tutti
l’uso del cognome
|
|
RICERCA GENEALOGICA
La ricerca genealogica si fa metodologicamente scendendo documento dopo documento da noi di figlio in padre , di padre in nonno, di nonno in avo , di avo in avo , di luogo in luogo, utilizzando documentazione degna di fede utile allo scopo ( documenti anagrafici o documenti sostitutivi di quelli anagrafici ) ricavandone appunto i relativi dati anagrafici Una sorta di ricerca scendendo nel passato col filo a piombo, da un antenato a quello precedente , desumendo via via la posizione nell'albero genealogico e l'ordine cronologico dei vari individui
Giu' giu' fino agli anni intorno al 1600 ( anni in cui i dettami del Concilio di Trento vengono rispettati quasi ovunque dai parroci ) la ricerca a ritroso e' abbastanza agevole perche' gli archivi civili e religiosi sono pieni di dati su ogni famiglia italiana ed ogni gruppo parentale viene identificato dai parroci con un medesimo cognome per evitare matrimoni tra consanguinei L'abbastanza agevole e' legato alla perdita di documenti per incurie o disgrazie e alla forte mobilita' delle famiglie di luogo in luogo , che rende il filo genealogico come il percorso di un fiume carsico che ogni tanto scompare per ricomparire poi in un altro luogo talvolta con un cognome diverso
Ove non si faccia una ricerca allargata da subito ,occorre sempre dubitare che l'albero ricostruito sia al sicuro dal rischio di omonimia Le famiglie italiane hanno sempre utilizzato uno stock ristretto di nomi Ripetendosi nei vari rami il nome del nonno del padre dei fratelli. ......... In Toscana si diceva "rifare i morti" cioe' una sorta di onore reso ai defunti dando alle nuove generazioni nomi cari alla tradizione di affetti familiari
METODI DI RICERCA ..............................Riflessioni sulla ricerca genealogica
FRAINTENDIMENTI e TERMINOLOGIA ..............................Riflessioni sullo studio del cognome
Molto spesso la ricerca genealogica riguarda la famiglia del padre e la famiglia della madre ,talvolta si allarga ulteriormente e tende a ricercare notizie su tutte le famiglie che compongono l'albero Ognuno ha un suo modo
Io ho preferito la ricerca sul cognome che ritengo piu' "storica" e molto piu' utile nei suoi aspetti politici, sociali ,economici, storici (cioe' ritengo il campione preso in esame (che ha come indice comune il cognome ) di molto maggior interesse di un campione privo di un elemento unificante di un certo valore ) : La casuale parentela non puo' dare valore particolare al campione , perche' in definitiva siamo tutti parenti. E neppure la storia di un singolo ramo familiare Ho quindi svolto una ricerca su tutte le persone che portano il cognome Carnesecchi legati o meno a me da un rapporto di parentela Come detto un cognome uguale non vuol dire sempre uno stipita comune
Dicono gli esperti che i cognomi italiani sono oltre 360.000. Quindi si dovrebbero avere oltre 360.000 ricerche ognuna delle quali comprendente piu' gruppi parentali ( casati ) omonimi Disegnando cosi una grandissima storia del cognome
vale sempre e comunque : ed il rischio di errori per omonimia
E' evidente che fatta una ricerca genealogica cosi come enunciata e cosi come proposta in questo sito ( su tutto il cognome ) ha aspetti di difficolta' particolari La ricerca genealogica fatta su questo sito e riguardante tutte le persone con un medesimo cognome parte dall'individuazione dei luoghi dove il cognome era presente e in quei luoghi tenta di ricostruire la storia e la genealogia di quegli individui Cerca di scoprire se il cognome e' nato in quel luogo (autoctono ) oppure se il gruppo e' collegabile ad altri gruppi in luoghi diversi da cui si e' separato precedentemente Io non mettero' in luce lo sforzo della ricerca eseguita secondo i canoni canonici ma daro' solo i dati risultanti Quindi in questo sito si descrivera' l'albero genealogico e la storia familiare dal nonno al nipote ,dal piu' antico al piu' recente, dando cioe' per fatta la ricerca genealogica a ritroso citando sempre comunque le fonti documentarie , denunciando eventuali interrogativi e dubbi dovuti ad omonimie o a incertezze sui dati Questo lavoro e' assomigliato al collocare le tessere di un puzzle avendo solo un'idea molto vaga del disegno d'insieme Denuncio che la lettura di questo sito non e' agevole complice la difficolta' della materia e l'insufficienza del redattore E' un sito realizzato in modo elementare con l'uso del linguaggio HTML4 , quindi senza grosse pretese di grafica puntando piu' che all'effetto estetico all'attendibilita' delle informazioni trasmesse ; sempre ho cercato di dare per quanto possibile le informazioni che ritenevo vere citando le fonti per permettere il controllo Ho quindi evitato menu a tendine ( forse piu' gradevoli esteticamente ) perche' mi sembrava si perdesse una visione d'insieme che invece ho ottenuto disponendo i fatti cronologicamente Per rendere un poco piu' semplice la consultazione ho usato sfondi diversi per i differenti argomenti
E’ ovvio che avere uno stesso cognome non vuole sempre dire avere antenati in comune (omonimia )
|
come nascono e quando i primi cognomi Il cognome e lo stemma
METODI DI RICERCA ..............................Riflessioni sulla ricerca genealogica
FRAINTENDIMENTI e TERMINOLOGIA ..............................Riflessioni sullo studio del cognome
|
albero genealogico patrilineare
Quando ho iniziato la mia ricerca ho scelto di fare una ricerca che previlegiasse il solo elemento maschile Poi ho cercato di fare una ricerca non solo verticale ma anche orizzontale Ad ogni livello tenendo conto di fratelli e cugini ( e ovviamente della loro discendenza e ascendenza ) Ed infine ho esteso la ricerca a chiunque portasse il cognome in qualunque luogo lo trovassi Ho cosi individuato una serie di possibili stipiti del cognome o in uno stesso luogo e o in luoghi diversi Questa scelta teoricamente permetterebbe di confrontare i vari Y-DNA e fissare i legami genetici tra i possibili stipiti prima determinati Quindi cognome e Y DNA si aiutano vicendevolmente Anche dal punto di vista storico mi pare una scelta estremamente utile seguire le vicende seguire le scelte di vita, in reazione agli stimoli sociali seguire le condizioni economiche . le condizioni sociali nello snodarsi delle generazioni .................ci permette di scoprire cose che sarebbero rimaste nascoste.
Verifica coincidenza stipiti con Y DNA
COGNOMI PARENTI
ALBERO GENEALOGICO PLURICOGNOMINALE
tratto da : Associazione italiana studi tolkieniani
L'albero genealogico pluricognominale io ritengo ha un' utilita' limitata dal punto di vista della ricerca Trovo la ricerca genealogica pluricognominale abbastanza dispersiva dovendo seguire una serie di cognomi grandissima mentre una ricerca per cognome ha una valenza capace di apportare elementi nel seguire l'evoluzione sociale dei vari rami di gente partita dal medesimo punto di partenza Forse non riflettiamo abbastanza ( come lo sceicco della favola coi chicchi di grano ) sul fatto che : considerata ipoteticamente una generazione ogni 25 anni In quattro secoli si succedono 16 generazioni che ci permettono di scendere al 1600 (anagrafe religiosa : primi effetti del concilio di Trento e diffusione generalizzata del cognome ) In otto secoli si succedono 32 generazioni che ci permettono di scendere al 1200 ( eta' in cui possiamo ipotizzare una iniziale ( scarsissima ) diffusione del cognome su scala nazionale)
Quindi in quattro secoli all'interno del nostro albero possiamo trovare un massimo di circa 65.536 cognomi Quindi in otto secoli all'interno del nostro albero possiamo trovare un massimo di circa 4.294.967.292
Ovviamente questo non e' possibile : infatti nel nostro albero abbiamo moltissime parentele multiple cioe' nel nostro albero uno stesso cognome compare piu' e piu' volte riducendo drasticamente il numero di cognomi che vi compaiono . Quanto piu' la famiglia era stanziale quanti minore e' il numero dei cognomi diversi che compaiono nell'albero
Questi semplici calcoli mostrano una cosa elementare : NOI SIAMO PARENTI PRATICAMENTE DI TUTTI
Memore della sua promessa, chiese all'inventore di tale sublime gioco quale ricompensa desiderasse. Il mercante, con aria dimessa, chiese un chicco di grano per la prima casella della scacchiera, due chicchi per la seconda, quattro chicchi per la terza, e via a raddoppiare fino all'ultima casella. Stupito da tanta modestia, il Principe diede ordine affinché la richiesta del mercante venisse subito esaudita. Gli scribi di corte si apprestarono a fare i conti, ma dopo qualche calcolo la meraviglia si stampò sui loro volti. Il mercante infatti stava chiedendo 18.446.744.073.709.551.615 chicchi di grano, una quantità che avrebbe richiesto secoli di produzione.
Pensate quale sarebbe il nostro albero genealogico se fossimo in grado di ricostruirlo per intero Alla folla di antenati che tutti noi abbiamo e che bene o male fanno udire la loro voce dentro di noi Di quante donne e uomini siamo il frutto ( o meglio di quante femmine e maschi di animali scomparsi o quante interazioni tra cellule elementari ) Pensate all'immensita' delle storie che ci precedono e al brevissimo spazio temporale che siamo in grado di ricostruire con enormi lacune
L'UOMO DISCENDE DALLA SCIMMIA ? NO ! O ALMENO NO IN PARTE L'UOMO DISCENDA DA UN VERMETTO MARINO EVOLUTOSI POI MOLTO TEMPO DOPO IN UN PESCE POI DA QUEL PESCE ,TUTTA UNA SERIE DI VERTEBRATI CHE VIA VIA SI ADATTAVANO ALL'AMBIENTE LA SCIMMIA VIEN MOLTO TEMPO DOPO INSOMMA TUTTI NOI ABBIAMO UNO ZOO NELL'ALBERO GENEALOGICO
Il Big Bang ( il grande scoppio ) è un modello cosmologico secondo cui l'universo iniziò a espandersi a velocità elevatissima in un tempo finito nel passato a partire da una condizione di curvatura, temperatura e densità estreme e questo processo continua tuttora Questo si ipotizza sia iniziato circa 14 miliardi di anni fa ed e' in corso
Il termine "brodo primordiale", riferito all'insieme di elementi chimici da cui ebbe origine la vita terrestre, è stato coniato un secolo fa. Da allora, come si fa con le migliori ricette, gli scienziati tentano di replicarne la formula in laboratorio per cercare di capire come RNA e DNA si siano in primo luogo formati, 4 miliardi di anni fa. Un altro punto da chiarire è come questo materiale genetico sia riuscito a replicarsi in mancanza di enzimi, le proteine specializzate che, attualmente, nelle cellule tengono separate le doppie eliche del DNA, permettendone la duplicazione. Il brodo primordiale, noto anche come brodo prebiotico, è un ipotetico ambiente ancestrale in cui si pensa possano essere avvenuti gli eventi chimico-fisici che avrebbero poi dato origine alla vita sulla terra[2]. Dal punto di vista chimico il brodo primordiale è una miscela acquosa di sali inorganici e vari composti chimici semplici a base di carbonio, idrogeno, ossigeno e azoto, sia di natura organica (idrocarburi, amminoacidi, acidi carbossilici, brevi polimeri) sia di natura inorganica (ammoniaca, anidride carbonica). Questo circa 4 miliardi di anni fa.
Quindi la vita nasce nel brodo oceanico o negli stagni di brodi primordiali , come organismi elementarissimi similacquatici
Dal punto di vista scientifico, la spiegazione dell'origine della vita parte dal presupposto fondamentale e imprescindibile che le prime forme viventi si originarono da materiale non vivente.
ORIGINE DELLA VITA SULLA TERRA ................................da WIKIPEDIA
L'abiogenesi è studiata combinando conoscenze di biologia molecolare, paleontologia, astrobiologia e biochimica per determinare come l'organizzazione crescente di reazioni chimiche abiotiche in sistemi non viventi abbia portato all'origine della vita sia sulla Terra che in altri luoghi dell'universo, dopo un po' di tempo dalla sua nascita (che si fa risalire ad un evento colossale noto con il nome di Big Bang, che si stima sia avvenuto circa 13,8 miliardi di anni fa) fino ai giorni nostri
I principi della teoria dell’evoluzione scoperti da Charles Darwin sono chiari. Le specie viventi si modificano nel tempo, quando la selezione naturale agisce sulle popolazioni, costituite da individui tutti diversi. Le conseguenze di questa e altre teorie devono essere ancora comprese dalla società.
L'interrogativo su come si originò la vita sulla Terra si pose soprattutto in seguito allo sviluppo della teoria della evoluzione per selezione naturale, elaborata in modo indipendente da A.R. Wallace e da C.R. Darwin nel 1858, la quale suggeriva che tutte le forme di vita sono legate da relazioni di discendenza comune attraverso ramificati alberi filogenetici che riconducono ad un unico progenitore, estremamente semplice dal punto di vista biologico. Il problema era capire come si originò questa semplice forma primordiale, presumibilmente una cellula molto simile ai moderni procarioti e contenente l'informazione genetica, conservata negli acidi nucleici, oltre a proteine e altre biomolecole indispensabili alla propria sopravvivenza e riproduzione. Il processo evolutivo che ha portato alla formazione di un sistema complesso e organizzato (ovvero il primo essere vivente) a partire dal mondo prebiotico è durato centinaia di milioni d'anni ed è avvenuto attraverso tappe successive di eventi, che dopo un numero elevato di tentativi hanno portato a sistemi progressivamente più complessi.
La prima tappa fondamentale è stata la produzione di semplici molecole organiche, come amminoacidi e nucleotidi, che costituiscono i mattoni della vita. Gli esperimenti di Stanley Miller e altri hanno dimostrato che quest'evento era realizzabile nelle condizioni chimico-fisiche della Terra primordiale, caratterizzata da un'atmosfera riducente. Inoltre il ritrovamento di molecole organiche nello spazio, all'interno di nebulose e meteoriti ha dimostrato che queste reazioni sono avvenute anche in altri luoghi dell'universo, tanto che alcuni scienziati ritengono che le prime biomolecole siano state trasportate sulla Terra per mezzo di meteoriti
L'origine della vita sulla Terra è databile entro un periodo compreso tra i 4,4 miliardi di anni fa quando l'acqua allo stato liquido comparve sulla superficie terrestre e i 2,7 miliardi di anni fa quando la prima incontrovertibile evidenza della vita è verificata da isotopi stabili e biomarcatori molecolari che mostrano l'attività di fotosintesi. Si ritiene comunque che la vita abbia avuto origine intorno ai 3,9 miliardi di anni fa, quando la Terra iniziò a raffreddarsi fino ad una temperatura alla quale l'acqua poté trovarsi diffusamente allo stato liquido; lo avvalorano le scoperte di strutture microbiche risalenti a 3,7 miliardi di anni fa nelle rocce verdi di Isua, in Groenlandia. Inoltre varie campagne di ricerca hanno attestato la presenza di cianobatteri fossili racchiusi in rocce stromatolitiche dell'Australia occidentale dell'età di circa 3,5 miliardi di anni. Uno studio recente ha analizzato possibili microfossili, individuati come filamenti di ematite presenti in campioni prelevati dal Nuvvuagittuq Supracrustal Belt, datandoli tra i 3,75 miliardi di anni fa e i 4,28 miliardi di anni fa. Se lo studio venisse confermato sarebbe la prova che la formazione della vita sulla Terra sia avvenuta in tempi molto rapidi dopo la sua formazione. Il concetto di origine della vita è stato trattato fin dall'antichità nell'ambito di diverse religioni e nella filosofia: con lo svilupparsi di modelli scientifici spesso in contrasto con quanto letteralmente affermato nei testi sacri delle religioni, l'origine della vita è diventato tema di dibattito tra scienza e fede. Questo ha portato a una lettura meno letterale e più metaforica di alcuni testi sacri, il cui obiettivo comunque non era dare spiegazioni scientifiche su come la vita fosse nata, ma piuttosto fornire un senso e uno scopo alla nascita della vita. Dal punto di vista scientifico, la spiegazione dell'origine della vita parte dal presupposto fondamentale che le prime forme viventi si originarono da materiale non vivente.
( In realta' i preti delle varie religioni sono semplicemente passati sulla difensiva e giustificano le loro balle con un'uso di metafore nei "sacri" testi
Le tracce più antiche della presenza di vita fino ad ora trovate risalgono a 3,7 miliardi di anni fa. Ma l'età del progenitore di tutte le cellule moderne è stata stimata a 4,29 miliardi di anni fa.
Avevo insegnato a mio figlio, nato nel 2000, che noi esseri umani avevamo come antenati i pesci e che quindi i suoi nonni molto lontani erano pesci Le maestre dell'asilo , avevano riso di quella strana idea Preferivano credere ad Adamo ed Eva !!! gente che aveva studiato ma che voleva continuare a credere le favole e derideva la scienza dall'alto della propria ignoranza
Non credo ovviamente nella semplificazione di in un solo Adamo ed in una sola Eva primordiali, ritengo vi siano diversi stipiti primordiali fortunati, in forma cellulare che insieme hanno iniziato una evoluzione simile o uguale nei ristagni del bagno primordiale
Le cellule alla base di ogni forma di vita complessa, le cosiddette cellule eucariote, si sarebbero evolute da cellule più semplici, le cosiddette cellule procariote, in modo ben diverso rispetto a quanto afferma la teoria attualmente più accreditata. Avanzata nelle sue linee essenziali da Lynn Margulis nel 1967, questa teoria afferma che le cellule eucariote, composte da numerosi organelli e da un nucleo dotato di una propria membrana interna, si siano sviluppate in seguito a un processo di endosimbiosi, cioè all'adattamento alla vita all'interno di una cellula procariote, come un batterio (o più probabilmente di un archeobatterio), di altri organismi unicellulari. (Gli archeobatteri si differenziano dai batteri per un meccanismo di trascrizione dei geni leggermente diverso e per il loro metabolismo.)
EVOLUZIONE CELLULA
Degan Shu, della Northwest University, aggiunge: “Il nostro team conta già diverse scoperte importanti in passato, tra cui il pesce più antico e una varietà di altri deuterostomi primitivi, ma il Saccorhytus rappresenta un notevole aiuto per comprendere le prime fasi dell’evoluzione del gruppo che ha portato fino ai pesci e, passo dopo passo, agli esseri umani”.
DA PESCE A UOMO Il proverbiale "pesce fuor d'acqua", i tetrapodi furono i primi animali vertebrati a uscire dal mare e colonizzare la terra secca (o almeno paludosa), una transizione evolutiva chiave avvenuta tra 400 e 350 milioni di anni fa, durante il Devoniano. Fondamentalmente, i primi tetrapodi discendevano da pesci con pinne lobate, piuttosto che con pinne raggiate, che possedevano la caratteristica struttura scheletrica che si trasformava nelle dita, negli artigli e nelle zampe dei vertebrati successivi. Stranamente, alcuni dei primi tetrapodi avevano sette o otto dita sulle mani e sui piedi invece delle solite cinque, e quindi finirono come "vicoli ciechi" evolutivi.
300 milioni di anni fa viveva nelle profondità dei nostri oceani l’ultimo antenato comune agli esseri umani e ai pesci; il suo nome è Acanthodes bronni. In quel periodo ebbe inizio la separazione di quella parte dei vertebrati che avrebbero poi conquistato la terra (i tetrapodi) e di un altro gruppo che, invece, avrebbe dato origine ai pesci moderni. L’evoluzione dell’uomo comincia dall’oceano con i neoceratodo. Questo pesce dotato di polmoni poteva vivere al di fuori dell’acqua per periodi anche estesi. Unica creatura che è sopravvissuta nei secoli, lo studio di questo pesce potrà rivelare come l’antenato dell’uomo ha abbandonato gli oceani per colonizzare la terraferma. Gli avi di questa specie di pesci si evolvero molto probabilmente nei tetrapodi, creature con quattro zampe che segnarono la transizione dalla vita nell’oceano a quella sulla terra. Dimostrare questa relazione evolutiva non è stato semplice, perché i fossili a disposizione dei ricercatori non conservano i tessuti molli, dunque non è stato ad oggi possibile studiare l’evoluzione muscolare delle gambe “primitive”. Uno strumento nelle mani dei ricercatori è costituito dallo studio delle differenze tra i muscoli delle gambe dei neoceratodi e dei pesci cartilaginei, che sono primitivi ma decisamente più ai primi neoceratodi che presentavano una struttura ossea. Analizzando il codice genetico di tali pesci con polmoni, dei veri e propri fossili viventi, è stato possibile tracciare la migrazione dei precursori di muscoli durante lo sviluppo dell’animale e determinare come si sviluppano determinati distretti muscolari specifici. Lo studio ha mostrato come la pinna pelvica si modifichi permettendo un movimento sia nelle acque degli oceani che sulla terraferma. Peter Currie ha spiegato che “Gli uomini sono solo dei pesci modificati. Il genoma dei pesci non differisce molto dal nostro. Abbiamo mostrato il meccanismo di formazione del muscolo pelvico i pesci con scheletro osseo che sono l’anello mancante nella catena evolutiva tra i primitivi squali e i nostri antenati tetropodi”.
Prima che questi due gruppi prendessero strade distinte, però, tutti gli gnatostomi, cioè i vertebrati dotati di mascelle, pare, somigliassero molto ai moderni squali. Lo ha stabilito uno studio condotto sulla scatola cranica di un fossile di A. bronni risalente a 290 milioni di anni fa, fossile che aveva a lungo lasciato perplessi i paleontologi. Il lavoro di Michael Coates, dell’Università di Chicago, è stato pubblicato la scorsa settimana su Nature. Le analisi del misterioso pesce del Paleozoico hanno permesso di definire meglio i rapporti di parentela tra i pesci cartilaginei (e quindi gli squali) e i pesci ossei (i pesci cosiddetti moderni). “Il nostro lavoro – ha dichiarato Michael – suggerisce che erano i primi pesci ossei a somigliare agli squali, e non viceversa”, cioè che i cambiamenti nella struttura del cranio dei vertebrati si sono verificati non solo prima della comparsa delle mascelle, ma anche dopo. Il gruppo degli gnatostomi comprende decine di migliaia di specie di vertebrati viventi, che vanno dai pesci ai mammiferi. I pesci cartilaginei, che oggi includono solo squali e razze, si sono separati dai pesci ossei più di 420 milioni di anni fa ma sin ora non si sapeva nulla dell’aspetto degli antenati comuni. Per la prima volta in assoluto, invece che studiare solo denti e pinne, gli scienziati sono riusciti a fare un modello in lattice dell’interno e dell’esterno del cranio e la sua analisi ha dato nuove e importanti informazioni sulla nostra stessa evoluzione. Questo campione è stato quindi scansionato e messo in relazioni con le immagini tomografiche di crani fossili di antichi squali. Prendendo in considerazione ben 100 caratteristiche morfologiche, l’analisi ha mostrato una fortissima somiglianza tra il campione in esame e gli squali antichi; una somiglianza tale da rendere molto difficile collocare questo gruppo nella storia evolutiva dei vertebrati. Questo studio mette ancora più in evidenza come l’evoluzione spinga in maniera difforme gli esseri viventi; agendo debolmente ha permesso a forme antiche come quelle degli squali di arrivare quasi inalterate ai nostri giorni mentre è stata decisiva nello stravolgere l’anatomia di un pesce che in 300 milioni di anni si è trasformato in un uomo.
L'analisi di un pesce fossile scoperto in Canada e risalente a circa 360.000 milioni di anni fa ha individuato nella pinna pettorale lo scheletro completo di un arto dotato di falangi: è il primo abbozzo dello schema anatomico della mano umana. La nuova struttura serviva all'animale per sostenersi nelle acque poco profonde o in brevi incursioni sulla terraferma
UN LUNGHISSIMO CAMMINO DA UN' ORGANISMO CELLULARE DA UN PICCOLO VERME DA QUEL PESCE CHE POI HA SVILUPPATO UNA COLONNA VERTEBRALE, UN SISTEMA PER RESPIRARE FUORI DALL' ACQUA E PINNE FORTI PER CAMMINARE SULLA TERRAFERMA , SIMILE AD UN ODIERNO PESCE SALTAFANGO
LENTAMENTE QUELLE PINNE DIVENIRE ARTI A SEGUIRE IL PASSAGGIO DA OVIPARO A MAMMIFERO A SEGUIRE UN SISTEMA PERCHE' QUEGLI ARTI DIVENGANO PRENSILI CON POLLICE OPPONIBILE A SEGUIRE TENERSI SU DUE ARTI E CAMMINARE ED UTILIZZARE GLI ALTRI DUE PER LA PRESA
E FINALMENTE IN MILIONI DI ANNI DOPO UNA LOTTA ACCANITA PER LA SOPRAVVIVENZA :
Homo sapiens (Linnaeus, 1758), (dal latino «uomo sapiente») è la definizione tassonomica dell'essere umano moderno. Appartiene al genere Homo, di cui è l'unica specie vivente, alla famiglia degli ominidi e all'ordine dei primati.
La precisa datazione dei primi esemplari definibili sapiens, tradizionalmente posta a circa 130 000 anni fa, è stata spostata dalle scienze paleontologiche più indietro nel tempo, grazie a ritrovamenti nei tufi vulcanici della valle del fiume Omo in Etiopia. Per mezzo di tecniche basate sui rapporti fra gli isotopi dell'argon, alcuni reperti anatomicamente simili all'uomo moderno sono stati datati a 195 000 anni fa, con un'incertezza di ±5 000 anni. Nuove datazioni del 2017 su reperti rinvenuti nel 1961 nel sito archeologico di Jebel Irhoud, in Marocco, sposterebbero l'origine dell'Homo sapiens a circa 300 000 anni fa.
L'epoca che va dal periodo interglaciale medio, circa 300 000 anni fa, all'epoca odierna, vede la comparsa in Africa orientale e la diversificazione della specie Homo sapiens. Secondo le teorie prevalenti, dal continente africano, circa 65-75 000 anni fa (o secondo altre evidenze alcune decine di migliaia di anni prima), in stretta coincidenza con un evento di fortissima riduzione della popolazione globale, tuttora in fase di definizione, parte della specie iniziò un percorso migratorio che attraverso un corridoio mediorientale la portò a diventare una specie invasiva e poi ubiquitaria colonizzando l'intero pianeta, con importanti impatti fisici e biologici su tutti gli ambienti, clima compreso.
L'uomo di Neanderthal deve il suo nome alla località in cui furono rinvenuti i primi resti, la valle del Neander presso Düsseldorf, in Germania, nel 1856. Apparve circa 350.000 anni fa e si estinse circa 30.000 anni fa, con una massima diffusione in Europa, Italia compresa, tra gli 80 e i 40.000 anni fa.
La teoria della catastrofe di Toba sostiene che tra 75 000 e 70 000 anni fa l'esplosione di un supervulcano al di sotto del lago Toba, probabilmente il più grande evento eruttivo negli ultimi 25 milioni di anni, rese ancora più rigido il clima del pianeta che già stava attraversando una glaciazione. Studi filogenetici sul cromosoma Y umano suggeriscono che circa 75 000 anni or sono la specie umana fu ridotta a poche migliaia di individui. Questo collo di bottiglia nella numerosità della popolazione umana spiega in parte la scarsa variabilità genetica nella nostra specie[. Alcuni ricercatori fanno risalire all'eruzione di Toba la causa di quella drastica riduzione. La teoria per ora non appare in contraddizione con le datazioni matrilineari dell'Eva mitocondriale e patrilineari dell'Adamo Y-cromosomiale. Secondo questa teoria, un evento simile lasciò conseguenze molto gravi in tutto l'ecosistema mondiale del tempo, portando molti organismi sull'orlo dell'estinzione.
Questa teoria è stata proposta nel 1998 da Stanley H. Ambrose dell'Università dell'Illinois a Urbana-Champaign. L'effetto collo di bottiglia dovuto all'eruzione di Toba si troverebbe anche per altre specie di mammiferi. Le popolazioni di scimpanzé dell'Est africano, degli orangutan del Borneo, dei macachi dell'India, dei ghepardi e delle tigri hanno tutte recuperato a partire da un numero molto basso di esemplari circa 70 000–55 000 anni fa.
Nella genetica umana, l'Adamo cromosomiale-Y o Adamo cromosomico è l'ultimo antenato comune dal quale tutti gli uomini viventi discendono in linea paterna. L'Adamo cromosomiale-Y probabilmente è vissuto circa 75 000 anni fa in Africa ed è la controparte dell'Eva mitocondriale.
poi il Cro-Magnon, uòmo di Homo sapiens anatomicamente moderno, vissuto nel Paleolitico superiore, risalente a ca. 30.000 anni fa, il più antico finora rinvenuto.
> INSOMMA UNA LENTISSIMA MATURAZIONE 55 milioni di anni fa - Compaiono i primi primati. evoluzione di chissa' quale minuscolo vertebrato 8-6 milioni di anni fa - I primi gorilla si evolvono. Più tardi, gli antenati degli scimpanzè e quelli dell'uomo divergono. 7 milioni di anni fa - Sahelanthropus tchadensis, scoperto in Ciad. Sebbene sia antecedente alla separazione della linea evolutiva dell’uomo (circa 6 milioni di anni fa), rappresenta la prima testimonianza di un ominide in grado di camminare su due gambe. 5,8 milioni di anni fa - Orrorin tugenensis, il più antico antenato dell'uomo che camminava abitualmente sulle gambe. I suoi resti trovati in Kenia, e in particolare un femore, hanno una struttura che ha fatto ipotizzare agli scienziati che fosse abituato a muoversi su due gambe, anche se era in grado di arrampicarsi. 5,5 milioni di anni fa - Compare il genere Ardipithecus. Condivide alcuni tratti con gli scimpanzé e i gorilla, vive nella foresta. Usava 2 zampe sul terreno e tutte e 4 quando si muoveva sui rami. Il ritrovamento più importante è quello di Ardi, un esemplare femmina di Ardipithecus ramidus vissuto 4,4 milioni di anni fa. 4 milioni di anni fa - Fanno la loro comparsa gli australopitechi. Il loro cervello è già più grande di quello di uno scimpanzé - con un volume di 400/500 cm3. Sono i primi antenati a vivere nella savana. Se, come sostengono le più attuali teorie paleoantropologiche, lo sviluppo del cervello iniziò “dai piedi”, ossia dal modo di camminare, le orme fossili trovate provano che già circa 3,6 milioni di anni or sono i piedi degli ominidi (forse quelli della specie Australopithecus afarensis) erano più simili a quelli dell’uomo attualedi quelli di Ardipithecus. 3,2 milioni di anni fa - È l'epoca in cui vive Lucy, la celebre donna scimmia (A. afarensis) scoperta in Etiopia dal paleoantropologo americano Donald Johanson. Manca delle estremità inferiori, ma le ossa delle gambe e il bacino dimostrano che la stazione eretta fa era acquisita: gli ominidi si muovevano quasi sempre in quella posizione, non solo per alcuni tratti. 2,9 milioni di anni fa - Secondo le teorie più accreditate, l’albero dell’evoluzione a quell’epoca si divise in due rami principali. Nel primo fanno parte alcune specie di ominidi - come Paranthropus aethiopicus (vissuto nelle attuali Etiopia e Tanzania), muniti di mascelle possenti per triturare cibi vegetali coriacei, come le noci e le radici per esempio. Vivono nei boschi e nelle praterie. E si estinguono 1,2 milioni di anni fa. Negli ominidi appartenenti al secondo ramo, come Australopithecus africanus, la dentatura e le mascelle rimasero invece leggere, ma si sviluppò la scatola cranica. Gli scienziati concordano nel riconoscere a questo secondo ramo il ruolo di progenitore del genere Homo, cioè quello cui apparteniamo noi. 2,1 milioni di anni fa - Compare il genere umano, con la specie dell'Homo habilis. Aveva una scatola cranica più sviluppata degli ominidi che l’avevano preceduto, ma mascelle relativamente meno potenti, perché la sua dieta era diventata onnivora: comprendeva cioè una buona base di carne, che si procurava facendo lo “spazzino”, cioè scacciando iene e altri predatori dalle carcasse degli animali morti, spesso agendo in gruppo con altri simili. I suoi utensili di pietra servivano soprattutto a rompere le ossa per mangiare il midollo, un cibo molto nutriente. H. habilis è stato a lungo considerato il primo membro della linea evolutiva di Homo, ma una serie di nuovi ritrovamenti ha cambiato le carte in tavola. 2 milioni di anni fa - Prime evidenze di Homo ergaster, in Africa, con un volume del cervello di 850 cm3. 1,8-1,5 milioni di anni fa - Homo erectus si trova in Asia. È il primo vero cacciatore-raccoglitore, e anche il primo ad aver migrato dall'Africa in gran numero. Aveva una dimensione del cervello di circa 1000 cm3. 1,6 milioni di anni fa - Primo uso sporadico del fuoco. È ancora un'ipotesi, suggerita da sedimenti scoloriti trovati in Kenya. Prove più convincenti di strumenti di legno e pietra carbonizzati si trovano in Israele e risalgono però a 780.000 anni fa.
UN POCO PIU' SIMILE
Con l’inizio della cultura acheuleana, si iniziò a lavorare simmetricamente i ciottoli su entrambe le facce e a sagomarli con maggior precisione con l’ausilio di strumenti di legno o di osso. 600.000 anni fa - Homo heidelbergensis vive in Africa e in Europa. Ha una capacità cranica simile a quella degli esseri umani moderni. 500.000 anni fa - Risalgono a quel periodo i resti più antichi e conosciuti di rifugi costruiti appositamente. Sono capanne di legno ritrovate vicino a Chichibu, Giappone. 400.000 anni fa - I primi esseri umani cominciano a cacciare con lance. 500.000 anni fa - Compaiono i Neanderthal (Homo neanderthalensis). Alcuni articoli scientifici affermano che la separazione tra uomo di Neanderthal e la nostra specie risalga a circa 800.000 anni fa. Li ritroviamo in tutta Europa dalla Gran Bretagna ad ovest all'Iran, a est. Si estingueranno - non è chiara la responsabilità della nostra specie, Homo sapiens - 40.000 anni fa circa. 400.000 anni fa - In Asia si diffondono alcune specie di Homo, come l'uomo di Denisova (non ha ancora un nome scientifico) in Asia centrale e - per ora - due specie di piccole dimensioni nel sud est asiatico: Homo floresiensis e Homo luzonesis, rispettivamente sull'isola di Flores (Indonesia) e Luzon (Filippine). 200.000 anni fa - La nostra specie Homo sapiens appare sulla scena - e poco dopo inizia a espandersi in Africa. Un ritrovamento in Marocco farebbe risalire le prime forme umane a 300.000 anni fa. I più antichi resti umani moderni sono due crani trovati in Etiopia che risalgono a questo periodo.Il volume medio del cervello umano è di 1.350 cm3. 170.000 anni fa - Risale a questo periodo la “Eva mitocondriale”, l’antenato comune femminile determinato dalla comparazione del Dna mitocondriale, trasmesso sempre dalla madre, di individui di varie etnie o regioni. 150.000 anni fa - Probabilmente gli uomini parlano. Alcune conchiglie usate come gioielli e risalenti a 100.000 anni fa potrebbero essere un segnale che gli esseri umani fossero in grado di sviluppare discorsi complessi e ricorrere al simbolismo. 140.000 di anni fa - Prime prove di commercio a lunga distanza. 110.000 anni fa - Prime perle - a base di gusci d'uovo di struzzo - e gioielli. 70.000 DI ANNI FA - L'uomo anatomicamente moderno esce dall'Africa e inizia la sua espansione in tutto il mondo. Prima in Asia-Australia (dove giunge 50.000 anni fa), poi in Europa, dove arriva circa 45.000 anni fa.
50.000 anni fa - È l'epoca del "Grande balzo in avanti": la cultura umana comincia a cambiare molto più rapidamente rispetto a prima; si seppelliscono i morti ritualmente; si creano abiti da pelli di animali; e si sviluppano tecniche di caccia complesse. 35.000 anni fa - In base ad alcuni ritrovamenti, risale a questo periodo la domesticazione dei cani. In passato si riteneva che l'amicizia tra cani e uomo fosse iniziata solo 10.000 anni fa. 33.000 anni fa - Risale a questo perioso la più antica arte rupestre. Gli artisti dell'età della pietra creano murales spettacolari a Chauvet in Francia, poi in altre grotte in Francia e in Spagna. Ci sono esempi anteriori meno complessi in Asia. Homo erectus si estingue in Asia - sostituito dall'uomo moderno. 15.000 anni fa - L'uomo moderno raggiungere le Americhe. 11.000 anni fa - L'agricoltura si sviluppa e diffonde. Nascono i primi villaggi. 5.500 anni fa - Finisce l'età della Pietra e inizia quella del Bronzo: gli uomini cominciano a fondere e lavorare rame e stagno, e li usano al posto degli strumenti di pietra. 5.000 anni fa - Primo scritto conosciuto. by FOCUS https://www.focus.it/scienza/scienze/la-timeline-dellevoluzione-delluomo
QUELLO CHE SI AFFERMA OGGI L'Adamo cromosomiale-Y riceve il suo nome dal personaggio biblico Adamo raccontato nel libro della Genesi. Questo mero accostamento non vuole ipotizzare che l'Adamo ancestrale sia stato l'unico uomo maschio del suo tempo, ma semplicemente colui che produsse una linea completa di figli maschi fino ad oggi: è, cioè, l'antenato a cui converge tutta la popolazione attuale o, in particolar modo, il cromosoma Y dal quale discendono tutti i cromosomi Y umani attualmente diffusi nel mondo.
Uno studio biologico dell'Università di Stanford sopra 93 polimorfismi genetici umani scoperti in questo cromosoma, in 1000 individui di 21 regioni del mondo, calcolò che un progenitore o gruppo di antenati maschili comuni a tutti gli uomini attuali visse in Africa . Studi successivi del cromosoma Y hanno stimato per l'antenato maschile comune una data tra i 100 000 e i 200 000 anni fa.
Si crede che l'apparizione dell'Adamo cromosomiale-Y sia da relazionarsi alla "Teoria della catastrofe di Toba". Questa catastrofe avrebbe provocato un restringimento del pool genetico della specie umana in modo tale da potenziarne l'unità genetica, la quale si presume fosse ridotta a solo 1000 individui intorno all'anno 70 000 a.C.
Così come i cromosomi-Y si ereditano per via paterna, i mitocondri si ereditano per via materna. Pertanto è valido applicare gli stessi principi. Il progenitore comune più vicino per via materna è stato soprannominata Eva mitocondriale.
by www.gobbatofranco.it Secondo la teoria dell’Out of Africa, l’umanità avrebbe avuto inizio in Africa. Da lì l’Homo erectus si sarebbe messo in cammino almeno 1,75 milioni di anni fa ed avrebbe popolato l’Asia e l’Europa. Da lui si sono poi sviluppate le diverse forme umane locali come l’Uomo di Neandertal. Al massimo 100.000 anni fa si mise in marcia un altro nuovo essere umano, per farsi suddito del mondo: l’Homo sapiens sapiens evolutosi in Africa circa 200.000 anni fa. Lì ebbe inizio la storia dell’uomo moderno. Il gruppo di cacciatori e raccoglitori emigranti constava in tutto di solo un paio di centinaia di uomini, da cui però 200.000 anni più tardi sono provenuti oltre 6,5 miliardi di predecessori: quelli che attualmente popolano la terra. Sia scoperte archeologiche, sia esami antropologici sul cranio nonché le più recenti informazioni scaturite dalla ricerca del DNA confermano la teoria dell'Out of Africa. L’originario Homo sapiens sapiens e l’attuale uomo moderno sono divisi da secoli di lotte per la sopravvivenza, migrazioni, isolamento e conquiste. I maggiori dettagli sono però ad oggi sconosciuti. Quel che è certo è che questi uomini si sono allontanati dal loro continente, al fine di popolare il mondo intero. Cosa li ha spinti 50.000, 70.000 anni fa, ad emigrare dall’Africa?
Prime migrazioni presapiens
L'ipotesi Out of Africa I è l'ipotesi paleoantropologica dominante tra le teorie che tendono a descrivere le prime migrazioni umane avvenute, ad opera dell'Homo erectus, da 1,8 a 1,3 milioni di anni fa.
Due milioni e seicentomila anni fa l'uomo esce dalla nicchia ecologica principale dei primati, prevalentemente tropicale. Il fatto che una specie di scimmia catarrina (di preferenza erbivora) entri in competizione coi carnivori sembra in prima ipotesi esclusivamente associabile allo sviluppo di una cultura, ossia di un insieme di conoscenze acquisite e condivise dalla comunità e trasmesse sistematicamente alla progenie. Il comportamento carnivoro pone le basi per una diffusione della specie sul territorio e quindi per una serie di migrazioni successive. La prima evidenza sicura di una migrazione fuori dall'Africa di H.erectus risale a 1,7 milioni di anni fa. Si ipotizza che i primi membri del genere Homo, cioè Homo ergaster, Homo erectus e Homo heidelbergensis, circa 2 milioni di anni fa, migrarono dall'Africa durante il Pleistocene inferiore, probabilmente a causa del funzionamento della pompa sahariana, e si dispersero per la maggior parte del vecchio mondo, arrivando fino a sud-est asiatico. La teoria della pompa del Sahara è un'ipotesi che spiega come la flora e la fauna migrarono tra Eurasia e Africa, attraverso un ponte di terra levantina. La teoria osserva che lunghi periodi di piogge abbondanti, periodi pluviali della durata di molte migliaia di anni, in Africa sono associati ad una fase "Sahara umido" durante la quale grandi laghi e fiumi poterono esistere con conseguenti cambiamenti faunistici nella zona. Indipendentemente dalla aridità del Sahara, la migrazione lungo il corridoio fluviale s'interruppe quando, durante una fase desertica, 1,8-0,8 milioni d'anni fa, il Nilo cessò di scorrere completamente, limitandosi a scorrere solo temporaneamente in altri periodi, causa sollevamento geologico (Swell nubiano) della regione.
In dettaglio si ipotizzano due periodizzazioni:
un primo periodo umido, restringendo le latitudini del deserto, ha consentito la colonizzazione dei territori orientali del Sahara e del Nordafrica; un successivo periodo più secco ha indotto la colonizzazione del resto dell'Africa subsahariana. Se la colonizzazione dell'Asia ha seguito presumibilmente le direttrici del Sinai e dello Yemen, per quanto riguarda la colonizzazione dell'Europa i dati probabilmente non sono ancora sufficienti. Tra 1,8 e 1,6 milioni di anni fa non ci furono periodi nei quali il livello del mare si abbassò talmente da formare un passaggio nello Stretto di Gibilterra o nel Canale di Sicilia, ma, in particolare, non si rilevano inoltre fossili in Spagna o Italia da riferire a tale epoca. La data di dispersione originaria oltre l'Africa coincide praticamente con la comparsa di Homo ergaster nei reperti fossili, e la comparsa degli strumenti litici olduvaiani. Siti chiave per questa prima migrazione fuori dell'Africa sono Riwat, in Pakistan (1,9 Ma), Ubeidiya nel Levante (1,5 Ma) e Dmanisi nel Caucaso (1,7 Ma). La Cina è stata popolata più di un milione di anni fa; manufatti in pietra di 1,66 Ma son stati rinvenuti nel bacino del Nihewan. Utensili di pietra trovati presso il sito di Xiaochangliang sono stati datati a 1,36 milioni di anni fa. I reperti archeologici del sito di Xihoudu nella provincia dello Shanxi datano la prima utilizzazione del fuoco di Homo erectus a 1,27 Ma. Il Sud-Est asiatico (Giava) è stato raggiunto circa 1,7 milioni di anni fa (Meganthropus). L'Europa occidentale è stata per la prima volta popolata circa 1,2 milioni di anni fa (Sierra de Atapuerca, in Spagna). Si è suggerito che l’Homo erectus possa avere costruito zattere e navigato oceani, una teoria che ha sollevato dubbi e polemiche. Le diverse ondate migratorie di H. erectus ebbero esiti differenti, potendo determinare sia l'occupazione effimera del nuovo territorio che una colonizzazione stabile. Questo condiziona un quadro archeologico che si presenta di complessa lettura: per tal motivo vi sono diverse tesi con differenti gradi di verosimiglianza, su quale e quante specie ominine abbiano migrato, nonché sul quando e sul dove. La teoria attualmente riconosciuta e accettata dagli antropologi, paleontologi e biologi stima che la famiglia Hominidae si sia evoluta a partire da protoprimati, ramo comune dal quale discendono anche le scimmie africane circa 5-6 milioni di anni fa e che fra i 2,3 ed i 2,4 milioni di anni fa il genere Homo si sia differenziato dall'Australopithecus. Circa sette milioni di anni fa l'assestamento della crosta terrestre produsse la formazione della Rift Valley, che attraversa gli stati attuali: Etiopia, Kenya e Tanzania. I venti carichi di piogge provenienti da ovest furono intrappolati dal sollevamento del Rift e di conseguenza avvenne l'inaridimento della parte orientale dell'Africa, con progressiva formazione dall'attuale savana in sostituzione alla foresta. La popolazione dei proto-ominidi africani si ritrovò ad essere geograficamente separata dal Rift in due ambienti ecologicamente differenti: il versante ovest rimase lussureggiante e i protoprimati su questo lato si evolvettero in un ambiente boscoso, differenziandosi verso la linea delle attuali scimmie antropomorfe non umane, mentre altre rimaste sull'altopiano orientale si adattarono a condizioni ambientali differenti quali la scomparsa della foresta sostituita dalla savana africana. In questo ambiente avvenne l'evoluzione e l'affermazione della linea afferente agli Hominina, di cui Homo sapiens è l'unico vivente ( wikipedia )
by www.gobbatofranco.it A metà degli anni ottanta il genetista Allan Wilson dell’università della California è riuscito a stabilire, con l’ausilio del DNA mitocondriale, da dove provenivano i primi esseri umani sulla terra. Il confronto di tali segmenti di patrimonio genetico ha portato alla luce il fatto che donne di origine africana presentano una varietà di varianti di DNA il doppio più vasta rispetto alle donne di altra origine. Poiché le mutazioni sopraggiungono in circostanze regolari, egli dedusse che l’Homo sapiens sapiens visse in Africa il doppio del tempo rispetto ad altre parti del mondo. I ricercatori partono oggi dal presupposto che tutti gli esseri umani siano imparentati con un’unica donna: con l’”Eva mitocondriale”. Ha vissuto in Africa circa 150.000 anni fa e non era all’epoca l’unica femmina umana. Ma l’analisi dei nostri geni mostra che l’intera umanità deriva da una catena ininterrotta di madri di questa femmina umana. Oltre all’Eva mitocondriale esiste analogamente l’“Adamo del cromosoma Y”, il nostro progenitore, anche lui proveniente dall’Africa. Test del DNA sempre più precisi hanno ulteriormente confermato lo stesso capitolo iniziale della nostra storia ovvero tutti gli esseri umani sulla terra, di qualsiasi colore di pelle, trovano le loro origini nei cacciatori e raccoglitori africani. Sono gli errori di copiatura a determinare le diversità Ognuna delle cellule del nostro corpo contiene una copia del nostro DNA. Quando una cellula si divide, deve sempre copiare il DNA che contiene, in modo che ogni ce llula figlia possa contenere il DNA completo. Questo processo avviene con estrema precisione. Ciò nondimeno non è perfetto. Quando ad esempio viene copiato il DNA mitocondriale e viene impacchettato in una cellula uovo, la sequenza nucleotidica mitocondriale nell’ovulo corrisponde quasi sempre perfettamente a quella delle altre cellule della madre. Può occasionalmente può capitare un errore. Un segmento di DNA (nucleotide) viene ad esempio scambiato ed al posto di una A troviamo una G. Ciascuno di questi errori di copiature è conosciuto come mutazione. Tali mutazioni rappresentano la chiave per la ricostruzione della nostra storia genetica. Supponiamo che l’Eva mitocondriale avesse avuto due figlie, di cui una presentava un’unica mutazione casuale nel suo DNA mitocondriale. Tutte le femmine umane oggi viventi, che trovano la loro origine in questa figlia, presenterebbero questo tipo di mutazione, mentre tutte le donne or iginarie geneticamente dall’altra figlia, non presenterebbero tale mutazione. L’Eva mitocondriale avrebbe dunque prodotto due diverse linee di discendenza mitocondriale (aplogruppi). Le due diverse sequenze di DNA mitocondriale sono conosciute come aplotipo. Gli aplotipi e gli aplogruppi sono come delle tavole corrispondenti ai nostri avi che fanno riconoscere ai genetisti chi è parente di chi. L’anello di DNA contenuto nei mitocondri è talmente piccolo che raramente ricorrono delle mutazioni . Le sequenze di DNA dei nostri cromosomi sono 40.000 volte più lunghe rispetto a quelle dei nos tri mitocondri. Quando gli esseri umani crescono, si riproducono le mutazioni che hanno ereditato dai loro genitori, nelle loro cellule uovo o spermatozoi, insieme a nuove mutazioni, che stabiliscono le peculiarità delle generazioni future. Ogni generazione “conia” dunque il DNA, che ha ereditato tramite nuove mutazioni. Il risultato è una genealogia complessa, un albero genealogico intricato e ramificato di variazioni genetiche.
Pensate quale sarebbe il nostro albero genealogico se fossimo in grado di ricostruirlo per intero: L'UMANITA' Alla folla di antenati che tutti noi abbiamo e che bene o male fanno udire la loro voce dentro di noi Di quanti uomini e donne siamo il frutto Pensiamo al numero immenso delle storie che precedono lo VIII secolo dopo Cristo e il brevissimo spazio temporale IX--XXI che siamo in grado di ricostruire e anche questo con enormi lacune Quasi nessuno e' in grado di ricostruire il proprio albero fino al 1150 ( rarissimi e quasi inesistenti i casi di chi puo' arrivare a documentare il IX--X secolo muovendosi nella boscaglia del patronimico ) quando cominciano ad apparire i primissimi cognomi moderni Cioe' una goccia di quell'oceano genealogico Probabilmente in questo lunghissimo cammino genealogico molti e molte tra i nostri padri e madri sono stati e state ai vertici della societa' e molti e molte ai margini e questo infinite volte Chissa' di quali storie meravigliose e di quali tragedie non saremo mai a conoscenza Storie che hanno segnato il passato dei nostri avi di gioia e di dolore
ABBIAMO VISTO CHE IN ITALIA ,MEDIAMENTE ; POSSIAMO PARLARE DI COGNOME MODERNO SOLO DAL 1150 E PRIMA DI ESSERE NELL'EPOCA IN CUI L'INDIVIDUAZIONE E' AFFIDATA AL PATRONIMICO Quasi nessuno e' in grado di ricostruire il proprio albero fino al 1150 ( rarissimi o quasi inesistenti i casi di chi puo' arrivare a documentare il IX--X secolo muovendosi nella boscaglia del patronimico ) fino a quando cominciano ad apparire i primissimi cognomi moderni Cioe' una goccia nell'oceano genealogico di 300.000--200.000 anni
E' la consapevolezza di quanto poco sappiamo del nostro passato che ci deve rendere restii a moti di vano orgoglio gia' alla fine del 700 Diderot e D'Alembert indicavano questo concetto nella Encyclopedie
"Se si disponesse della genealogia autentica ed esatta di ciascuna famiglia, e' piu' che verosimile che nessun uomo sarebbe stimato o disprezzato in virtu' della sua nascita. Infatti, non v'e' mendicante per le vie che non risulterebbe discendente diretto di qualche uomo illustre, ne' un solo nobile elevato alle piu' alte dignita' dello Stato, degli ordini e dei capitoli, che non scoprirebbe tra i suoi antenati una quantita' di gente oscura. Supponiamo che un gentiluomo d'alto rango, tutto gonfio d'orgoglio per la sua alta nascita, si vedesse passare in rivista sotto gli occhi l'intera serie dei suoi avi, un po' come Virgilio fa contemplare a Enea tutti i suoi discendenti. Da quali contrastanti passioni non sarebbe agitato, vedendo, nello spazio di quattro millenni, un alternarsi continuo, magari a brevi intervalli, di condottieri e di pastori, di ministri di Stato e di artigiani, di principi e di bifolchi?! Da quale tristezza o da quale gioia non si sentirebbe prendere alla vista di tutti gli scherzi della sorte: di fronte a uno spettacolo cosi variopinto, fatto di cenci e di porpore, di strumenti di lavoro e di scettri, di insegne di onore e di marchi d'obbrobrio?! Quale flusso e riflusso di speranze e di timori, di trasporti di gioia e di mortificazione non verrebbe a patire, via via che la sua genealogia gli apparisse brillante o tenebrosa?! Ma se il nostro gentiluomo, gia' cosi fiero dei suoi avi, riuscisse a rientrare in se', considerando con occhi di filosofo tutte queste vicissitudini, non ne sarebbe piu' affatto turbato. Le generazioni dei mortali, alternativamente illustri e abiette, si cancellano, si confondono e si perdono come le onde di un rapido fiume: nulla puo' arrestare la corsa del tempo, che trascina seco cio' che sembrerebbe piu' fermo e imperituro, e lo inghiotte per sempre nella notte eterna". ( voce Genealogia di De Jancourt )
|
Si parla spesso della tutela del titolo nobiliare , della tutela dello stemma familiare
Non si parla mai della tutela del cognome
Gia' attaccato dalle omonimie dei fantagenealogisti il cognome viene talvolta squassato dai problemi che nascono dai cognomi multipli
I cognomi doppi tripli o peggio sono un'invenzione che comincia mi pare nel xvi secolo, allora non sempre per scopi nobili ( talvolta un trucco per tagliar fuori dai fidecommesso i parenti poveri ) che chiedevano , mi pare, la rinuncia al cognome e allo stemma originario ( cosa mai avvenuta in pratica )
A Lucca si pose il problema per la partecipazione contemporanea ai Consigli dei Guinigi e dei Guinigi Magrini che essendo un unicum sollevava un giusto malumore ma che fu risolta a favore dei Guinigi adduccendo che non usavano uno stesso stemma
Questa situazione e' emblematica dei problemi derivanti dai cognomi multipli alla genealogia-
E di quando lo Stato ( ???) si sostituisce alla genealogia ( con quali mezzi , e con quale diritto ? vedi esemplarmente la vicenda Toto' De Curtis) imporre per legge un secondo cognome dovrebbe richiedere il consenso di chi ha gia' quel cognome non la presunzione immotivata dell'estinzione del casato
Per via femminile noi siamo parenti di tutti
vale ampiamente il concetto cristiano : siamo tutti fratelli e sorelle
Da inizio 800 ci siamo accompagnati a 256 cognomi e da inizio 1600 ci siamo accompagnati teoricamente a oltre 65,000 cognomi ( secondo la potenza del due )
Come premessa quindi
La nostra storia e' storia patrilineare . Il cognome si trasmette attraverso il padre ( anche se oggi le cose stanno cambiando )
Per la genetica in un albero patrilineare lo mt-dna varia da generazione a generazione ( con la moglie )
Per la genetica in un albero patrilineare lo y-dna e' lo stesso ( o meglio e' collegabile ) generazione dopo generazione
|
I cognomi italiani si dice siano circa 350.000 ( come abbiamo visto poi ciascuno puo' contenere piu' casati ) Se venisse privilegiata solo la ricerca sul cognome paterno o al piu' materno sarebbe possibile , io credo una raccolta molto piu' razionale di microstorie e di dati Cosi gli scarsi cultori della genealogia in realta' producono un lavoro fortemente disperso Esaminano decine di famiglie E sara' molto difficile in futuro ( anche disponendo di computer piu' potenti ) utilizzare i dati raccogliendoli a fattor comune
|
|
Un altro modo molto utile di far ricerca genealogica e' la ricerca sulle famiglie di un territorio
studi di questo tipo si possono trovare sul forum IAGI relativamente alla Sardegna Genealogie famiglie della Sardegna E sul forum Tuttogenealogia sulle famiglie del Friuli Genealogie famiglie del Friuli
|
|
considerazionigenealogiche
La ricerca genealogica pare prendere slancio quando i ceti dirigenti perdono slancio , quando cioe' la societa' tende a ripiegarsi verso il passato e perdere la fiducia verso il futuro Fosse cosi questo sarebbe un malinteso E' dal passato , dagli esempi di quell'eroismo quotidiano dei nostri antenati in tempi sicuramente molto piu' difficili che dovremmo trarre la volonta' di aggredire il futuro per creare una societa' migliore e far emergere la nostra forza ed il nostro carattere
Nella ricerca genealogica e nella ricostruzione della storia di famiglia occorre aver ben chiari alcuni concetti Occorre premettere che le varie famiglie italiane prendono il cognome moderno in un lungo lasso di tempo , chi prima chi dopo ,in un lungo spazio di tempo che va dal 1150 al 1563 ( chiusura del concilio di Trento ) ed in alcune piccole localita' anche molto oltre il concilio di Trento ( si sfiora addirittura il 1800 ) Prima del cognome esisteva il sistema patronimico , talvolta in piccolissimi borghi solo un soprannome E' evidente come la presnza del cognome renda piu' facile la ricerca genealogica , perche' se e' sempre vero che un medesimo cognome non e' garanzia di un medesimo stipite , nello stesso luogo un ugual cognome rende piu' probabile la parentela
AAA ( fatte salve come vedremo le prime cognomizzazioni ) Il nostro cognome non ce lo siamo scelti noi . Il cognome , salvo rare eccezioni nel passato erano gli altri a darcelo e non noi a scegliercelo. Come detto mutando il luogo di residenza poteva accadere ci fosse cambiato il cognome ( questo e' meno facile dopo il 1560 quando il cognome comincia a diventare piu' stabile ) il cognome era un modo con cui gli altri ci collocavano , ci identificavano nella loro mappa mentale e nei loro discorsi Un intero gruppo parentale puo' essere soggetto alla stessa identificazione ma questo non e' regola. Dopo alcune generazioni un medesimo gruppo parentale puo' spezzarsi in identificazioni diverse
il cognome ce lo danno gli altri Molti cognomi ricordano qualche caratteristica o da qualche difetto fisico I venti cognomi più portati in Italia : Rossi, Russo, Ferrari, Esposito, Bianchi, Romano, Colombo, Ricci, Marino, Greco, Bruno, Gallo, Conti, De Luca, Costa, Giordano, Mancini, Rizzo, Lombardi, Moretti. Ad esempio l'aspetto della capigliatura, ( Rossi e le sua varianti, Bianchi , Bruno , Ricci e Rizzo Biondi Calvi ) Qualcuno ricorda una caratteristica caratteriale Fracassi, , Tranquilli. Gentili Colombo , Gallo o Leone Molti ricordano un mestiere esercitato Alcuni la provenienza Alcuni una nascita sfortunata e l'abbandono …molte volte gli individui venivano riconosciuti non per il nome ma per un soprannome con il quale magari era noto il padre o il nonno, Ecco il nascere di tutta una serie vastissima di cognomi che si riferiscono appunto ad un soprannome,
il cognome col tempo diventa uno strumento : si rivela utile nelle transazioni commerciali dove era necessario l'identificazione sicura delle proprieta', per cui Arturo di Osvaldo Casabianca che prima era costretto a dare di se una moltiplicita' d'informazioni nell'atto notarile : Arturo detto Volpino figlio di Osvaldo nipote di Alberto , fabbro di mestiere , proveniente da Lodi , qui abitante vicino alla casa bianca ; puo' finalmente tirare un bel sospiro di sollievo Quindi il cognome si diffonde con il diffondersi della ricchezza individuale (gestione delle proprieta' ) e con l'aumento della popolazione locale (che rende piu' difficile identificare con certezza le persone e piu' facile scambiarle tra di loro) . Nei discorsi della gente si diffonde con il riconoscimento della notorieta' o della potenza della famiglia all'interno della societa' che definisce quel gruppo di persone come un unicum Spesso Bernardo di Quinto di Lupo di Alberto di Abbondio di Claudio con un Abbondio ben noto a tutti finisce ad essere chiamato dagli altri come Bernardo ABBONDI se pero' Bernardo di mestiere fabbro sposta il luogo di residenza puo' finire che la sua discendenza sia identificata come FABBRI ( i figli del fabbro )
Solo dopo il Concilio di Trento in Italia il cognome diventa abbastanza stabile ,grazie a una sorta di anagrafe religiosa e grazie ai sacerdoti che tentavano di prendere informazioni avanti ai matrimoni
Nel caso particolare del cognome Carnesecchi esiste una sorta osmosi tra il cognome Carnesecchi e il cognome Carnesecca e talvolta col soprannome Carnesecca Per i Carnesecchi/Carnesecca di Badi poi come vedremo il cognome oscilla spesso tra l'uno e l'altro ed e' l'uno o l'altro a seconda del tempo e a seconda del luogo Quando un Carnesecchi si sposta di luogo succede spesso che diventi "il Carnesecca"
Nel passato quando non esistevano anagrafi ,fotografie ,impronte digitali , ne si sospettava del DNA Non esistevano telefoni o fax e le comunicazioni tra Stato e Stato erano pressoche' inesistenti il cognome poteva essere molto ballerino Anche se uno il suo cognome non aveva motivo di cambiarlo , c'era sempre il rischio che andando ad abitare in un altro luogo la gente locale te lo cambiasse a forza Perche' in assenza di anagrafe il cognome dipendeva dalla identificazione della gente del posto Avevi un bel chiamarti Paoli se la gente del posto diceva che tu eri quello che abitava la casa bianca divenivi un Casabianca
Carnesecchi e' pero' un cognome forte cioe' dotato di per se stesso di una forte connotazione . Colpisce l'immaginario Difficile che venga toccato in maniera radicale Fuori Toscana non viene praticamente concepito fuori Toscana CARNESECCHI e' quasi inimmaginabile come cognome ( quindi mai autoctono in altre regioni ) Viene quindi sovente trasformato in CARNESECCA Perche' CARNESECCHI resista fuori Toscana occorre che la famiglia sia forte economicamente e culturalmente
Normalmente la presenza contemporanea dei cognomi CARNESECCA e CARNESECCHI in un luogo del Sud nasconde la trasformazione Carnesecchi in Carnesecca sui rami piu' deboli E induce a pensare in una modificazione di CARNESECCHI in CARNESECCA come avviene spesso fuori Toscana ( A Palermo attira la mia attenzione trovare i Carnesecchi e i CARNESICCA o i CARNISICCA )
Vi e' insomma quasi sempre, fuori Toscana, un tentativo di rendere CARNESECCHI piu' familiare trasformandolo in CARNESECCA
BBB Avere un cognome uguale non vuol sempre dire provenire da uno stesso ceppo familiare ( omonimia ) Questo e' presumibilmente vero anche per il cognome Carnesecchi per quanto appaia essere cosi poco diffuso Tutta la vicenda dei Carnesecchi di Prato mi e' ancora poco chiara e non so includere o escludere legami coi Carnesecchi fiorentini lo stesso per quello striminzito ramo senese forse condannato all'estinzione ma che pare essere ben diversificato dai fiorentini
Come vedremo inoltrandoci nel sito incontreremo prima del Concilio di Trento diversi individui ,specie in Toscana , col soprannome di CARNESECCA il soprannome Carnesecca non vuol certo dire che i figli di questo individuo abbiano avuto il cognome Carnesecchi ma non lo esclude Una sorta di processo osmotico che come abbiamo fatto notare coinvolge il soprannome , il cognome Carnesecchi e il cognome Carnesecca. Ecco perche spesso parleremo degli individui identificati come Carnesecca
CCC Quando gli eruditi del passato parlano di famiglie estinte ( spente ) va inteso solo che le linee aristocratiche di quella famiglia si sono estinte : nessuno di loro ha mai spinto i suoi studi cosi a fondo da poter prendere in considerazione tutti i rami familiari e conoscerne il destino I genealogisti del passato sono stati estremamente ingiusti coi rami poveri di una stessa famiglia e come severi giardinieri hanno cesoiato drasticamente i rami piu' deboli Quindi occorre prestare molta attenzione nella ricostruzione genealogica evitando di prestare eccessiva fiducia nelle considerazioni degli eruditi
DDD Nello studio genealogico e' difficile fare previsioni A Siena ad esempio ho incontrato nove fratelli maschi ,il che lasciava intravvedere una esplosione dell'albero genealogico , invece nel giro di due sole generazioni quella linea si e' quasi estinta Insomma uno striminzito ramoscello puo' dar vita ad un albero vigoroso e un albero vigoroso seccare
EEE La ricostruzione genealogica non puo' andare disgiunta dalla ricostruzione della storia familiare Un albero genealogico non puo' essere solo un elencazione di nomi e date ma deve dare carne agli scheletri , deve restituire le loro vicende umane Questo concetto cosi basilare ( e cosi estremamente trascurato da molti ) lo appresi nei miei inizi dall'amico avv. Roberto Celentano ed ho sempre tentato di applicarlo
un buon genealogista non puo' esimersi dallo studiare la storia dei luoghi scenario delle vite degli uomini e delle donne investigate Un modo di dare una consistenza corporea ed intellettuale alla sequenza dei nomi di un albero genealogico
Anche sul sito Antenati dei Beni culturali : La ricerca delle proprie origini e la ricostruzione della propria storia familiare mira, in primo luogo, a rintracciare le affinità e relazioni parentali. Ma la ricostruzione del filo genealogico, della tavola degli ascendenti per quarti e dell’albero genealogico di una famiglia, non rappresenta che il primo passo per avanzare nella conoscenza dei propri antenati, che diventa più profonda e ravvicinata attraverso la ricerca di documenti che ne testimoniano i modi di vita, il grado di istruzione, i luoghi dove essi hanno abitato e hanno trascorso la loro esistenza, le professioni e i mestieri che hanno esercitato, etc. Dalle loro storie particolari può scaturire un quadro complesso e articolato della società italiana attraverso le generazioni.; dal sito considerazioni dal portale ANTENATI
LA STORIA EDUCHI ALLA PACE , ALLA GIUSTIZIA SOCIALE , ALLA TOLLERANZA :
Non si deve mai dimenticare che la Storia dovrebbe esser ben conosciuta e dovrebbe essere maestra di vita, rappresentando in senso collettivo l'ESPERIENZA che ci evita di rifare i medesimi errori nel futuro Cosi non si deve dimenticare che tante sofferenze e ingiustizie che hanno patito i nostri antenati sono legate a strutture sociali ingiustificabili ed arcaiche avvallate da una Chiesa cattolica che e' stata per lunghi secoli ( XVI XVII XVIII ) stampella di queste strutture e strumento di obnubilazione delle menti I ritardi culturali della nostra Nazione vengono da lontano . Dal mix esplosivo di dominio spagnolo e Chiesa cattolica Un mix di intolleranza e di superstizione , di potere nobiliare e pretesco , che cercava disperatamente di ancorare al passato mentre un'altra parte del mondo correva verso il futuro Con mille e mille intelligenze condannate alla persecuzione e costrette ad aver paura della propria intelligenza Con uomini ipocriti e stupidi che soffocarono Galileo e tanti come lui per secoli , ed asservirono lo splendida intelligenza italica al rosario e al servilismo Con uomini ipocriti e stupidi che inventarono l'inferno in terra ed in cielo
|
Da notare che il concetto di nobilta' nato a dividere gli uomini e a giustificare potere ed ineguaglianze sociali si e' basato per molto tempo:
sull'antichita' della propria genealogia
sui meriti e sulla notorieta' dei propri antenati
condito il tutto da presunti valori morali piu' di fantasia e piu' inventati o ingigantiti che veri , perche' per mantenersi al vertice e' piu' utile il cinismo che la virtu'
Il vanto di un nano e' di sputar lontano ( proverbio spagnolo )...................quindi tutti con i piedi ben piantati per terra , attenti a non rendersi ridicoli
IL CONCETTO DI COGNOME si generalizza in Italia intoro alla meta' del secolo XI
IL CONCERRO DI ARALDICA si generalizza nel medesimo periodo ed aiuta la fissazione dei primi cognomi
IL CONCETTO DI NOBILTA' come verra' poi inteso come INEGUAGLIANZA si generalizza con e dopo Carlo magno.
Questo concetto era estraneo alla cultura italiana
un concetto fortemente corruttivo che travolgera' la Chiesa cattolica , rassegnata a farsi stampella del potere
|
considerazionigenealogiche
Non so perche' si faccia la ricerca genealogica Si dicono molte cose : nessuna convincente Pare a me che ad un certo punto della nostra vita , con una carriera , una famiglia , dei figli , ci si renda conto di essere solo in transito , una presa di coscienza della nostra caducita' e allora venga normale porsi le domande di sempre della razza umana ad alcune e' impossibile dare risposta ad altre puo' dare risposta il passato E allora ci sovvengono domande piu' vicine a noi Con i nostri genitori invecchiati o morti ci vengono alla mente domande a cui nessuno dei vivi puo' piu' dare risposte compiute e che ci spingono a frugare nei ricordi e nei documenti
UN BISOGNO INCONSCIO……………………
Perche’ ricercare le nostre radici ? Perche' fare una ricerca storico genealogica ? I morti sono morti , le loro vicende non interessano piu’ a nessuno Conta solo cio’ che siamo noi………i nostri antenati non cambiano cio’ che siamo ………...Una briccone rimane un briccone anche se aveva il nonno santo…………….. ………………………………………………………………………………… In realta’ noi siamo anche il nostro passato Non ci e’ certo possibile dimenticare nostro padre o nostra madre che sono le persone che piu’ ci hanno amato , che tutto ci hanno perdonato Gli episodi della nostra fanciullezza riempiono ancora le nostre menti ,vivono in noi ,inteneriscono il nostro cuore , fanno comunque parte del nostro modo di essere. Ed anche i racconti delle vicende dei nostri genitori fanno parte della nostra vita E cosi quelle dei nonni e ci viene da chiederci delle vicende dei loro genitori dei loro nonni e sentiamo che anche quelle vicende , anche quegli uomini ,anche quelle donne ci appartengono ……………………………………. indietro sempre piu' indietro nel tempo piu' indietro ancora Fino a quell'essere mezzo scimmione e mezzo uomo che parti un giorno dall'Africa un essere che e' nostro perche' qualcosa di lui vive ancora in noi ……………………………………. Vorremmo sederci con lui intorno ad un fuoco ; vorremmo sentirgli raccontare le sue gioie, i suoi dolori ridere fragorosamente la dove c'e' da ridere nei suoi racconti , condolerci con lui dove c'e' da piangere Vorremmo sentirlo vantarsi ; vorremmo sentirlo confidarci i segreti familiari ; vorremo sentire i suoi consigli di padre al figlio
Noi siamo atavicamente programmati con un bisogno di amore Noi siamo atavicamente programmati per non vivere da soli per avere una famiglia , per avere un villaggio Io credo sia nei meccanismi di questa nostra programmazione che risieda il nostro interesse alle vicende delle persone da cui discendiamo Noi siamo programmati non solo per guardare avanti ma anche per ricordare Buona parte della nostra vita emotiva e’ legata ai ricordi……………………………………………….
Quindi tutti noi abbiamo bisogno di ritrovare il nostro passato Senza la conoscenza del passato una parte di noi non esiste
Cercate le vostre radici ! Se vostro nonno era un pescatore , un macellaio , …… , siatene fieri . Perche’ era vostro nonno e sicuramente nella sua vita troverete mille atti di quell’eroismo quotidiano che sempre e’ necessario per vivere ………………………………… …………………………………… Il mio bisnonno era un contadino e sicuramente passo’ dei momenti difficili ma mise al mondo dei figli li amo’ li crebbe , insegno’ loro ………e non fu meno degno di altri Carnesecchi che vissero in condizioni sociali piu’ vantaggiose …….e comunque , con la sua vita , anche lui partecipo’ a scrivere la storia ……….e principalmente anche lui fu amato dai suoi figli che erano i miei nonni ………..che io a mia volta amai…………………….
l'albero genealogico esprime bene la cosa :una famiglia e' come una grande pianta che comprende stati temporali diversi e dove i ramoscelli sono alimentati da rami del passato in un angolo di noi ci sono ancora idee e sofferenze antiche che non sono nostre ma che ci sono state tramandate
|
esprimono meglio il concetto le parole di un Oriana Fallaci morente
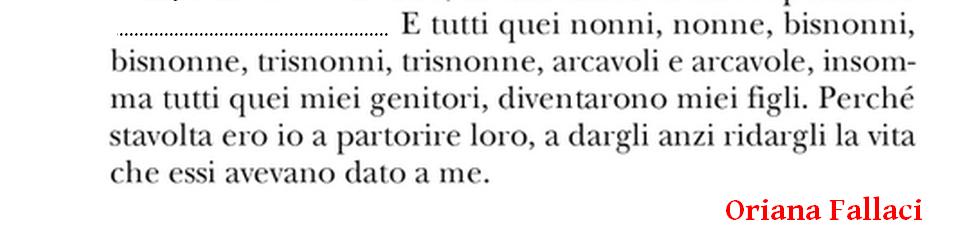
Ma forse e' solo lo storico che si nasconde in ciascun genealogista che prende il sopravvento
e la cosa piu' vicina su cui indagare e' la propria famiglia e/o il proprio cognome
|
considerazionigenealogiche
FFF
Un ultima cosa non annoiate gli estranei raccontando la storia della vostra famiglia. Vi ascolteranno solamente per compiacenza Tenete il racconto per voi e per i vostri figli . Perche' e' il passato che dovrebbe creare il cemento tra la generazione futura e la generazione presente . io credo che lasciare in eredita' ai propri figli anche la memoria, l'esempio e l'orgoglio dei propri antenati sia una cosa non del tutto inutile. Ma con giusta attenzione, evitando un orgoglio sterile e privo di senso La vera bellezza morale dell'uomo e' la voglia di fare : la voglia di costruire qualcosa che non c'era, di modificare e far diventare piu' bello quello che c'era
E le cose fatte dai propri antenati in questo senso dovrebbero esser visti come un incitamento all'emulazione E le cose non fatte dovrebbero essere uno stimolo a farle per la prima volta
GGG
GENEALOGIA COME FIERA DELLE VANITA'
Molti ancora oggi si avvicinano alla propria storia familiare e alla propria genealogia con l'intento di trovare parentele titolate Ai giorni nostri non dovrebbe essere piu' cosi' ma dovrebbe essere un amorevole cammino di ricostruzione Iscrivendo la propria famiglia tra quelle di cui si conosce la storia Che comporta : Scoprire come e quando e dove la famiglia ha preso quel cognome Il significato del cognome Scoprire l'antenato che per primo ha portato quel cognome Nel caso il cognome derivi dal nome o dal soprannome di un antenato ,cercare di scoprire cosa avesse di speciale questo antenato per dare il proprio nome alla sua discendenza Seguire poi tutta la trama delle vicende vissute dai nostri antenati Ricostruirne gli ambienti, gli stili di vita ; Il vanto di una famiglia dovrebbe essere quello di aver fatto qualcosa nell'interesse della propria patria ed un semplice bracciante puo' averlo fatto Un titolo di demerito dovrebbe esser quello di aver sfruttato gli altri per mantenere la propria opulenza Alcuni baroni meridionali o nobili settentrionali che hanno alle spalle i patimenti di tanta povera gente che si e' spaccata la schiena per permettere loro una vita di agi non mi sono simpatici Parteggio per quel cafone ignorante stracciato e senza cultura e con la pancia sempre vuota che permetteva al gentiluomo di essere colto educato e con la pancia sempre piena Quando si dice di un nobile che viveva dei frutti della terra ci si dimentica spesso cosa vi era dietro questo dar frutti della terra
|
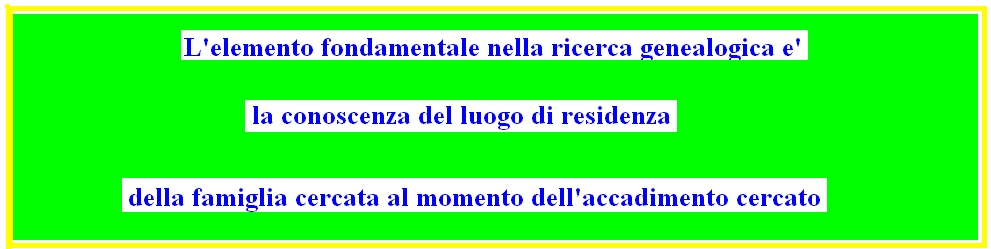
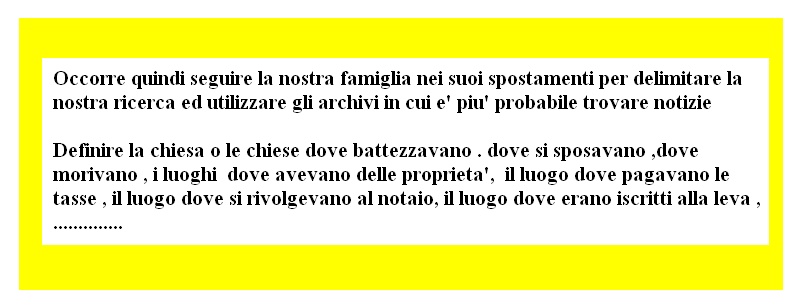
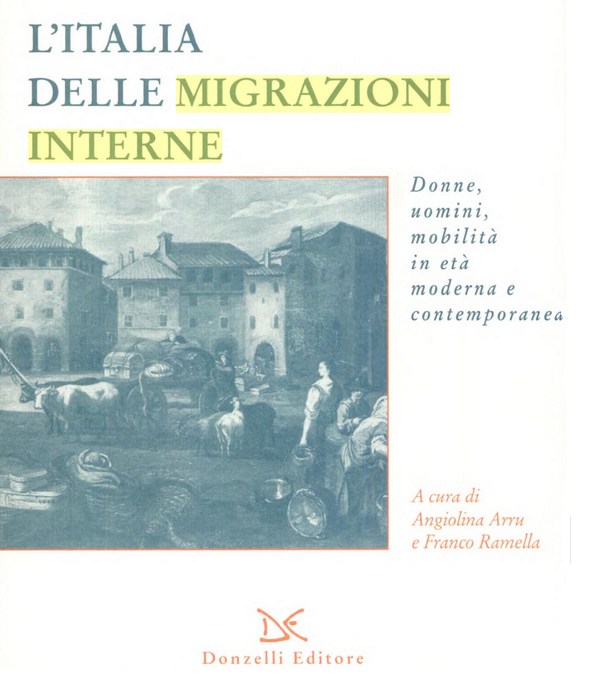
CAMBIO DI LUOGO >>>>>>>>CAMBIO DI COGNOME >>>>>>>>>>>>>ACCADE
estratto
Nel passato mancando l' anagrafe civile non era impossibile un cambio di cognome cambiando di luogo di residenza
Nel passato quando non esistevano anagrafi ,fotografie ,impronte digitali , ne si sospettava del DNA
Non esistevano telefoni o fax e le comunicazioni tra Stato e Stato erano pressoche' inesistenti
il cognome poteva essere molto ballerino
Anche se uno il suo cognome non aveva motivo di cambiarlo , c'era sempre il rischio che andando ad abitare in un altro luogo la gente locale te lo cambiasse a forza
Perche' in assenza di anagrafe il cognome dipendeva dalla identificazione della gente del posto
Avevi un bel chiamarti Paoli se la gente del posto diceva che tu eri quello che abitava la casa bianca divenivi un Casabianca
Il cognome strumento per meglio individuarci ce lo danno in pratica quasi sempre gli altri
e' molto facile collegare il nuovo arrivato col luogo di provenienza una delle prime cose che si di lui
e questo ( in tempi di mancanza di anagrafe civile ) anche se ha gia' un cognome
Veneziani, Lombardo, Piacentini ,Parmigiani, .......
Per il prete veniva poi facile seguire l'indicazione della nuova individuazione e imbussolare una famiglia nel nuovo cognome
Carnesecchi e' pero' un cognome forte cioe' dotato di per se stesso di una forte connotazione . Colpisce l'immaginario
Difficile che venga toccato in maniera radicale
Fuori Toscana non viene praticamente concepito
fuori Toscana CARNESECCHI e' quasi inimmaginabile come cognome ( quindi mai autoctono in altre regioni )
Viene quindi sovente trasformato in CARNESECCA
Perche' CARNESECCHI resista fuori Toscana occorre che la famiglia sia forte economicamente e culturalmente
Normalmente la presenza contemporanea dei cognomi CARNESECCA e CARNESECCHI in un luogo del Sud nasconde la trasformazione Carnesecchi in Carnesecca sui rami piu' deboli
E induce a pensare in una modificazione di CARNESECCHI in CARNESECCA come avviene spesso fuori Toscana
( A Palermo attira la mia attenzione trovare i Carnesecchi e i CARNESICCA o i CARNISICCA )
TRE ESEMPI
Vi e' insomma quasi sempre, fuori Toscana, un tentativo di rendere CARNESECCHI piu' familiare trasformandolo in CARNESECCA
Esmpio palermitano
A Palermo , troviamo sia il cognome Carnisicca sia il cognome Carnesecchi spesso riletto in Carnisicchi
Io credo che un Carnesecchi fiorentino che aveva quel cognome almeno dall'ultimo quarto del trecento tendesse a fare resistenza ad un cambio di cognome operato nella nuova comunita'
Che questa resistenza avesse differenti probabilita' di successo
maggiori probabilita' di successo per un notaio che firmando gli atti impone il suo cognome
molto minori per un artigiano o un mercante che e' infine costretto ad accettare di essere chiamato come vuole la gente
Direi quindi che possano coesistere i due cognomi originati dal cognome Carnesecchi
Ecco che Nicola che e' un artigiano forse anche mercante puo' diventare Carnesecca e Simone che e' notaio puo' continuare a imporre alla gente il suo cognome originario
Non possiamo comunque escludere che Carnisicca sia un cognome autoctono
Qualora pero' Nicola Carnesecca sia di famiglia fiorentina e' anche possibile che il radicamento a Palermo della sua famiglia sia di molto anteriore
A FRASCATI
Per la competenza e la gentilezza del dr Valentino Marcon : UN PASSO AVANTI il 21 aprile 2024
L'archivio storico diocesano di Frascati
Per la storia della chiesa tuscolana. La diocesi di Frascati
Storia del movimento lavoratori di Azione Cattolica
ilmamilio.it - 20 Novembre 2023 -contenuto esclusivo Valentino Marcon, storico cattolico tuscolano, è tra gli studiosi più appassionati ed attenti che il nostro territorio possa vantare. In queste ultime settimane, Marcon ha dato alle stampe un nuovo testo, incentrato sulla storia della diocesi tuscolana.........................
https://www.ilmamilio.it/c/news/58470-duemila-anni-di-chiesa-tuscolana-nell-ultimo-libro-di-valentino-marcon.html
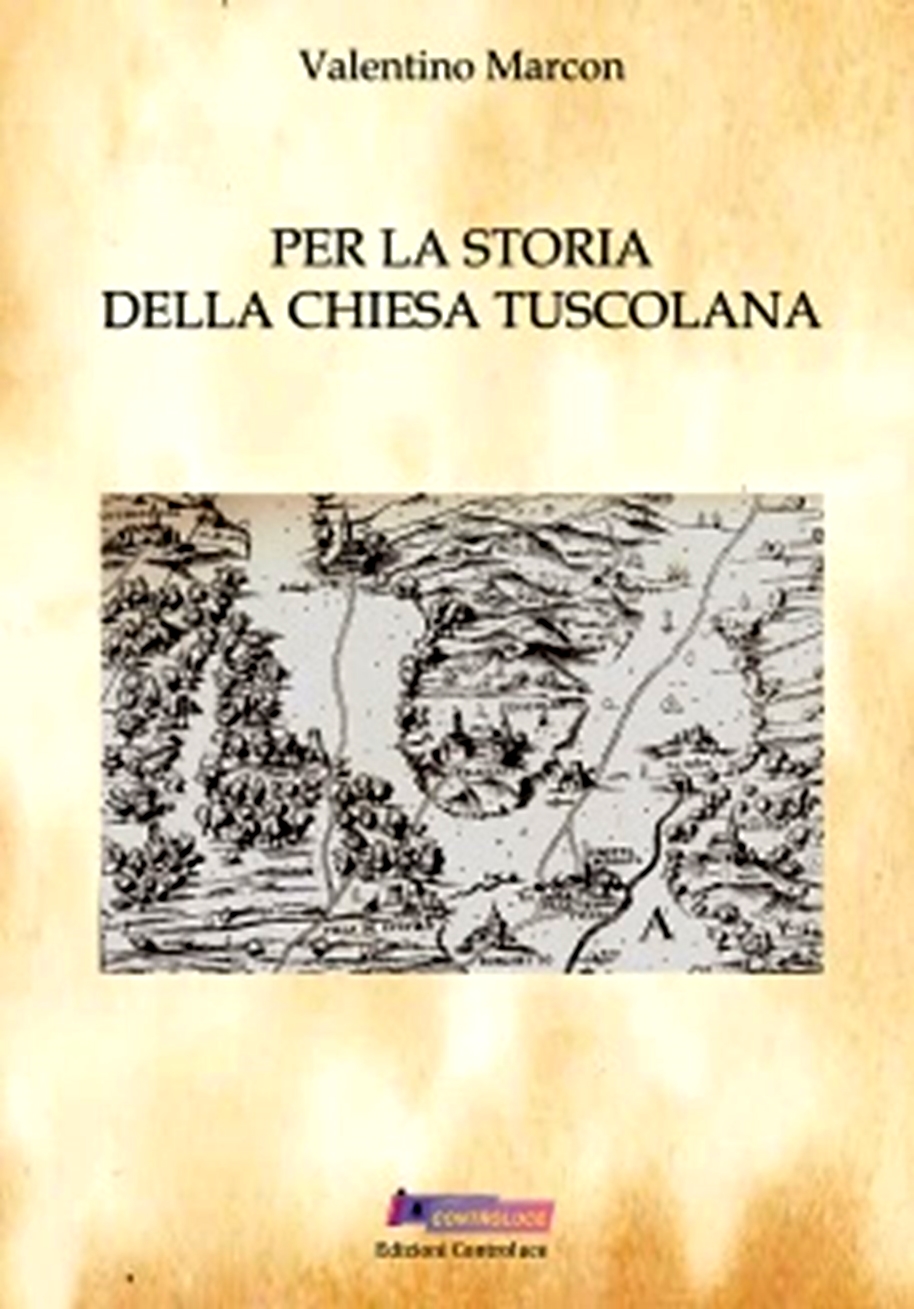
facendo seguito al battesimo di Mario nel 1752
Nell’Archivio storico Diocesano di Frascati. (a cura di V.MARCON)
Il dottore mi dice : con una più approfondita ricerca, sono riuscito a trovare altri riferimenti ai Carnesecchi.
La famiglia Carnesecca/Carnesecchi, secondo lo ‘status animarum’, risulta abitare in Frascati dal 1752 al 1754 e, anche se nell’atto di battesimo di Anna Maddalena Carnesecca, risulta la data del 1755, nello status animarum di quell’anno non risulta più la famiglia residente a Frascati Abitava nella ‘Villa dell’Eccellentissimo principe de Comitibus, quasi certamente la Villa Boncompagni, che erano duchi di Sora. Infatti la Villa in seguito verrà denominata ‘Villa Sora’ e poi acquistata dai salesiani nel 1900. In questa Villa probabilmente i Carnesecchi vi lavoravano (inizialmente con un’altra famiglia che risulta abitarvi). Forse erano inservienti, giardinieri o cosa(?). Questa la sequenza delle presenze:
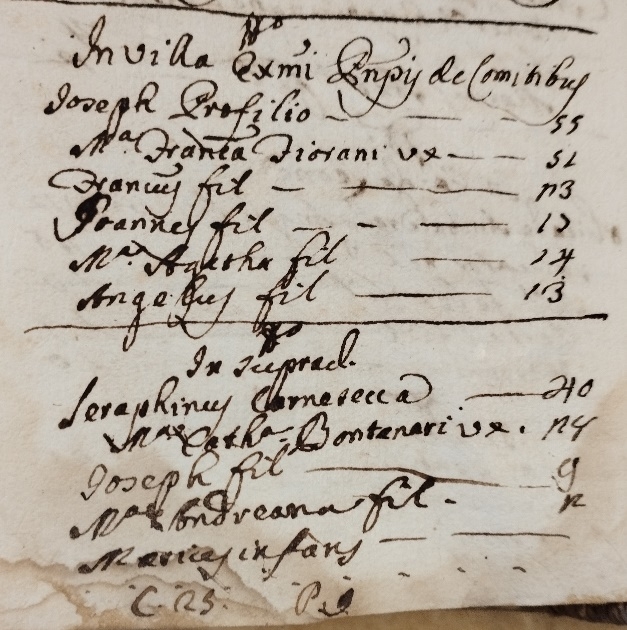
1752 Serafino ha 40 anni, la moglie 28, il figlio Giuseppe 9, la figlia Andreana 2, e l’altro figlio Mario, ‘infans’, perché nato da poco).
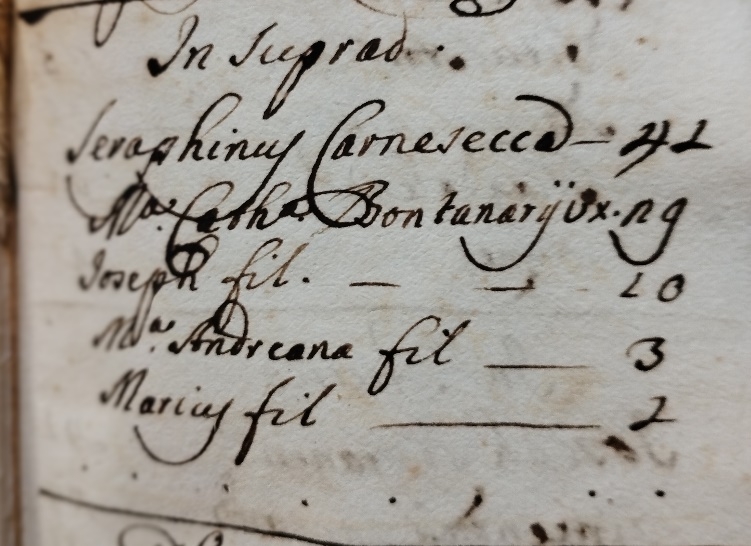
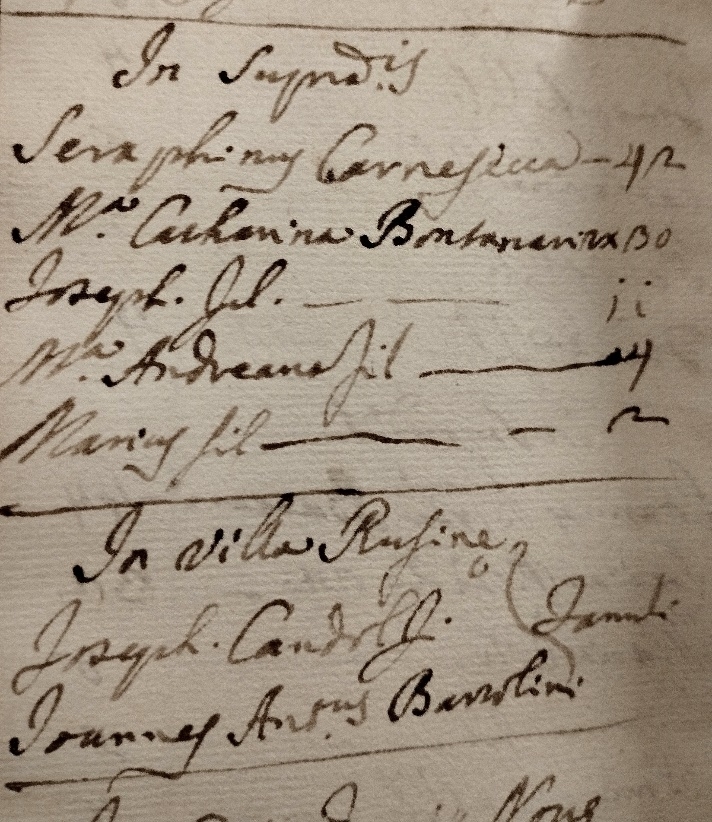
N.B. Dal 1755, non risultano più abitare in Frascati, anche se in questo anno risulta il battesimo di Anna Maddalena Rosa.
Tuscolo (Frascati). (Liber Baptizatorum 1746-1756 p.163).
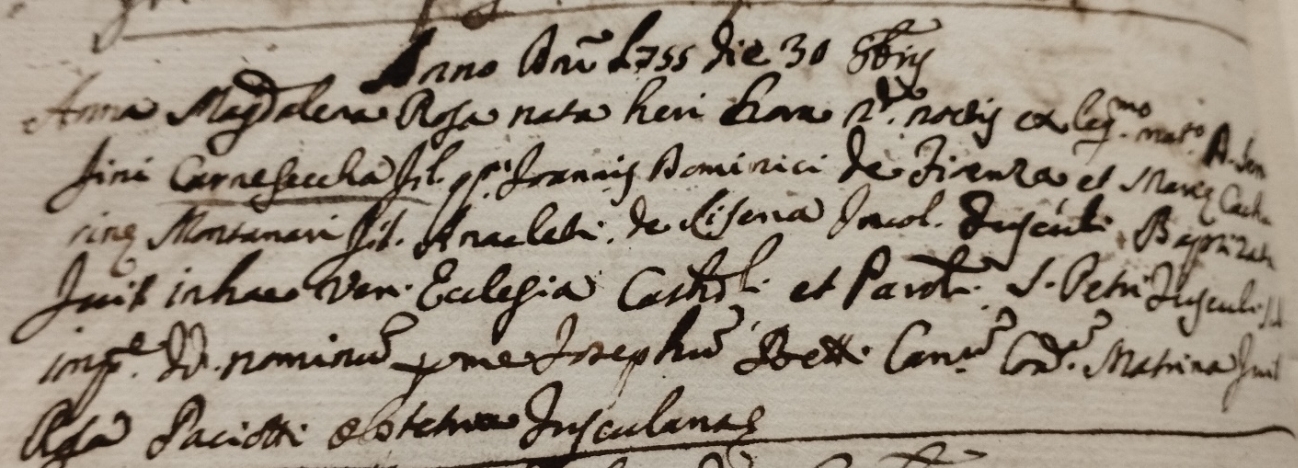
Anna Rosa Maddalena, nata il 29 ottobre del 1755 e battezzata il 30. Figlia di Serafino Carneseccha (figlio del fu Giovanni Domenico da Firenze, e Maria Caterina Montanari figlia di Anacleto da Cesena, incolae (abitanti) a Tuscolo (Frascati).
Si noti come le registrazioni dei parroci (registri e status animarum) non sempre risultino precisi e si trasformino nel passare del tempo. Ad esempio la moglie di Carnesecchi, di cognome Montanari, poi si scriverà ‘Bontanari’! La famiglia di Carnesecchi era composta dal marito Serafino, dalla moglie M. Caterina Montanari (o Bontanari), il figlio Giuseppe, la figlia Andreana, l’altro figlio Mario, quindi nascerà Anna Maddalena Rosa.
by dr VALENTINO MARCON
dr Valentino Marcon , grande esperto della Diocesi tuscolana , autore anche di :
A GIOIA DEL COLLE
Qui arriviamo al paradossale all'anagrafe civile figli fratelli con lo stesso padre e la stessa madre si ritrovano con due cognomi diersi CARNESECCHI E CARNESECCA !!!!!!!!
A BARI
La prima generazioni ee' CARNESECCHI
Tutta la seconda generazione anagraficamente e' CARNESECCA
Con la terza generazione si riprende il cognome CARNESECCHI
Dovendo intraprendere una ricerca anagrafica e genealogica, occorre innanzitutto rivolgersi agli uffici dello Stato Civile, istituiti in forma obbligatoria a partire dal 1871, per ritrovare le registrazioni di nascite, morti e matrimoni, e agli uffici dell’Anagrafe per conoscere i movimenti della popolazione, le residenze, i censimenti, le immigrazioni e le emigrazioni.
Per il periodo antecedente, spesso ci si puo' rivolgere solamente alle parrocchie di nascita e a quelle di residenza del proprio antenato, in cui sono conservati i registri parrocchiali con le registrazioni dei battesimi, matrimoni e morti. Va tenuto conto che, in alcune diocesi, gli archivi parrocchiali più antichi sono stati concentrati presso l’archivio storico diocesano o presso le parrocchie maggiori
PASSAGGIO DALLA LINGUA ITALIANA AL LATINO E NUOVAMENTE ALLA LINGUA ITALIANA (OSCILLAZIONI E INCERTEZZE )
MOLTA CONFUSIONE NASCE DALL'INESISTENZA IN iTALIA FINO AI PRIMI DELL'OTTOCENTO DI UN ANAGRAFE CIVILE , CHE NASCE SOLO CON L'OCCUPAZIONE FRANCESE DI NAPOLEONE
Fino all'ottocento dobbiamo far riferimento solo ad un'anagrafe religiosa che si esprime in un latino non sempre grammaticalmente corretto
Ad un latino che sulla parte cognominale ha molte incertezze , e raramente produce qualcosa di uniforme
Messaggioda Marie Peracchi » lun feb 03, 2025 10:09 pm
Significazione di : Martino detto Ratti de Bollis o Bolis? Famiglia Lombardia
Grazie
con questi dati striminziti
non conoscendo contesto , periodo, luogo......
si possono dire solo cose generiche
Martino ( cosi battezzato ) e' chiamato abitualmente e familiarmente Ratti
Martino appartiene alla famiglia Bolis o Bollis oppure Bolli o Boli
prenderei il "de" come espressione di appartenenza che dovrebbe essere in seguito caduto quasi generalmente
Ricordo che l'anagrafe religiosa utilizzava il cognome in latino , e in modo talvolta variabile da prete a prete da atto a atto. di tempo in tempo
Piccole variazioni ma tali da non avere un prodotto univoco
Tenendo sempre presente che per la maggior parte delle persone questo non significava molto
IL PARROCO DOPO LA META' DEL CINQUECENTO FA UNA SORTA DI TRASPOSIZIONE PERSONALE DELLA FORMA COGNOMINALE USATA NELLA LINGUA VOLGARE IN LATINO , LINGUA IN CUI REDIGE L'ATTO
Forse solo in Toscana si usava la lingua volgare negli atti religiosi in quasi tutti gli atti ( comunque con diverse eccezioni)
Nel resto d'Italia i cognomi registrati in latino rendono difficile la loro stabilizzazione in una forma unica
Cosi e' possibile (ma non e' detto senza analisi genealogica ) che gente col medesimo Y-DNA assuma poi cognomi diversi
QUANDO FINALMENTE DALLA FORMA LATINA DEL BATTESIMO SI RIPORTA IL COGNOME NELLA LINGUA ITALIANA CREANDO UN ANAGRAFE STATALE
E qui uno stesso casato ( cognome e y-dna ) puo' scontrarsi con gli errori burocratici che lo condannano al frazionamento
http://www.gens.info/italia/it/turismo-viaggi-e-tradizioni-italia?t=cognomi&cognome=bolis&x=42&y=15
http://www.gens.info/italia/it/turismo-viaggi-e-tradizioni-italia?t=cognomi&cognome=bollis&x=43&y=13
http://www.gens.info/italia/it/turismo-viaggi-e-tradizioni-italia?cognome=boli&x=45&y=14
http://www.gens.info/italia/it/turismo-viaggi-e-tradizioni-italia?t=cognomi&cognome=bolli&x=31&y=10
http://www.gens.info/italia/it/turismo-viaggi-e-tradizioni-italia?t=cognomi&cognome=de+bolis&x=49&y=11
http://www.gens.info/italia/it/turismo-viaggi-e-tradizioni-italia?t=cognomi&cognome=de+bollis&x=43&y=16
http://www.gens.info/italia/it/turismo-viaggi-e-tradizioni-italia?t=cognomi&cognome=de+boli&x=40&y=9
http://www.gens.info/italia/it/turismo-viaggi-e-tradizioni-italia?t=cognomi&cognome=de+bolli&x=35&y=7
come sempre senza analisi genealogica e' impossibile stabilire o escludere parentele
Claudio De Dominicis nel suo manuale :
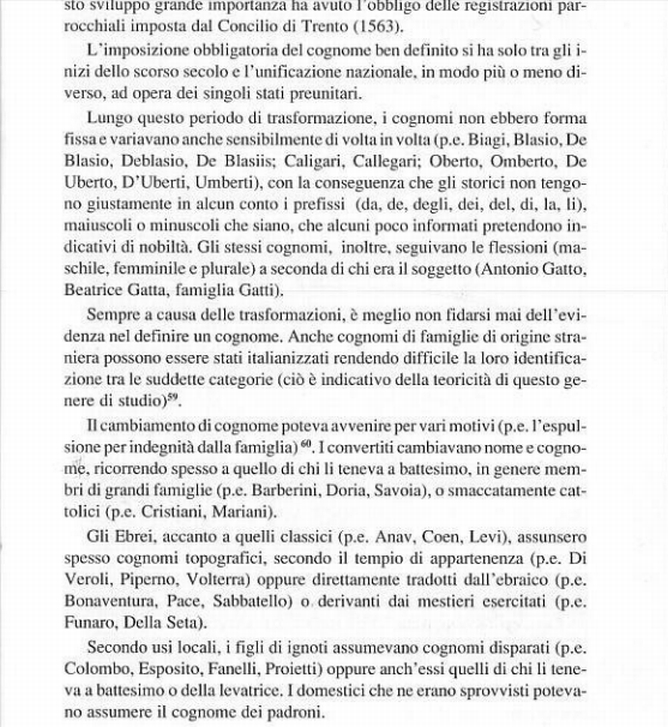
Pier Felice Degli Uberti in questa intervista :
Il forte desiderio di nobiltà si traduce pure in piccoli trucchi. C'è chi adotta il doppio cognome, aggiungendo quello materno, perché fa effetto. E chi sfrutta il cognome che inizia con De, staccandolo e adottando la minuscola. «Queste cose colpiscono chi non sa - continua degli Uberti - de, di, degli, davanti al cognome, sono impropriamente definiti particella nobiliare ma specificano solo una discendenza. Purtroppo ci sono tanti poco seri che garantiscono di saper fare ricerche. Meglio fare da soli. Tutti sappiamo leggere e scrivere, dunque tutti siamo in grado di condurre una ricerca genealogica, peraltro è bellissimo».
by https://www.ilmessaggero.it/mondo/come_diventare_nobile_conte_marchese_duca_titolo_nobiliare_da_comprare_come_si_fa_news_oggi-6192146.html?refresh_ce
Le preposizioni genitive "degli", "dei", "da", anche con la prima lettera segnata in minuscolo, ebbero larga diffusione in passato
In certi ceti erano la norma , Si diceva che al momento delle presentazione occorreva dire Mario Rossi intndendo Mario dei Rossi
Quindi le preposizioni indicano semplicemente appartenenza . Uno che porta un certo cognome : indica essere uno dei Rossi
Chi ha cognome che ingloba il DEGLI , DEI, ( DE ) cambia il cognome anche dal punto linguistico costringe infatti a dire : dei DEGLI ALBERTI , dei DE ROSSI
non cambia nulla che siano scritte in minuscolo
È solo un modo di scrittura scorretto e pretenzioso del proprio cognome
Pretenzioso perche' si e' diffusa la convinzione ignorante di origini nobili
Chiunque puo' scrivere di se di essere uno di quel cognome
Io ho cognome Rossi ,sono dunque dei Rossi E' sempre sottinteso Io appartengo alla casa , o al casato dei Rossi
L'unico modo per scoprire origini nobili è una ricerca storico-genealogica
|
considerazionigenealogiche Guida ai registri della Diocesi di San Miniato (Pi) .............Cosa domandare. come fare...............
La strada piu' sicura e meno complicata per una ricerca genealogica in Italia e' rappresentata dalla consultazione dei registri della Chiesa cattolica Cominciamo col dire che non e'mai esistita una ANAGRAFE CIVILE negli Stati italiani e mai esistera' fino all'occupazione francese post rivoluzionaria Di tanto in tanto negli stati si faceva un CENSIMENTO parzialmente nominativo
E' importante per un ricercatore genealogista conoscere le decisioni prese alla fine del Concilio di Trento nel 1563 e quanto avvenne nel 1614 l'intenzione della Chiesa cattolica era di combattere le eresie e le cattive abitudini religiose , a questo fine la chiesa cattolica creo' una gabbia che imprigionava l'intera comunita' cattolica in un sistema unico di sorveglianza Iniziato nel 1563 il sistema si perfeziono' nel 1614 e si trasmise fino ai nostri giorni A vigilare sul sistema furono delegati i parroci , a vigilare sui parroci i Vescovi Purtroppo ( sempre per il genealogista ) i parroci non sempre e non in ogni luogo furono solerti ad applicare le disposizioni e puo' succedere che i registri in certi luoghi non ci fossero o non fossero formulati secondo le disposizioni Purtroppo per il genealogista non sempre e non dovunque i registri religiosi sono sopravvissuti all'incuria e ai disastri Ma vediamo che cosa cosa accade nel 1563 e nel 1614 di tanto utile al genealogista Noi siamo abituati ad identificare la nostra famiglia con un cognome ma esiste un periodo molto lungo in cui gli individui della nostra famiglia non sono stati individuati attraverso un cognome ma attraverso un patronimico
Generalmente i primi cognomi moderni iniziano ad apparire in Italia tra il 1100 ed il 1200 cioe'nel XII secolo Ed abbiamo visto che non tutte le famiglie si cognomizzano .Che la cognomizzazione si estende lentamente nelle varie famiglie e che inizialmente la cognomizzazione riguarda solo le famiglie del ceto dirigente Se dopo la fine del concilio di Trento era imposta solo l'individuazione delle persone negli atti religiosi , dal 1614 questa individuazione si fa piu' stringente e secondo le intenzioni della Chiesa cattolica ciascuna famiglia avrebbe dovuto essere identificata con un cognome Di fatto siamo in presenza dell'istituzione di un ANAGRAFE RELIGIOSA Contemporaneamente continua a non esistere un'ANAGRAFE CIVILE Nasce di fatto una collaborazione tra il prete e lo Stato , per cui il prete ed i registri religiosi adempiono a questa nuova funzione burocratica , fino allora inesistente E con i registri religiosi che possiamo iniziare a parlare di schedatura e di conoscenza di tutti gli abitanti di un Principato
ANAGRAFE RELIGIOSA che viene costantemente aggiornata con quello strumentoimportante che sono gli STATI DELLE ANIME
Essendo lo spirito guida della ricerca genealogica il cognome ecco che i registri religiosi diventano fondamentali per la ricerca genealogica dal 1614 ai giorni nostri Ed inoltre fornendo i battesimi non molto dopo il 1563 permettono di spingere la ricerca fino a questa data Normalmente si arriva nella ricerca genealogica intorno a questa data senza eccessive difficolta'
L'ANNO 1563 : TERMINA IL CONCILIO DI TRENTO E' L'ANNO DECISIVO PER LA GENEALOGIA ITALIANA ( registri di battesimo e di matrimonio )
L'ANNO 1614 : E' L'ANNO DECISIVO PER L'AFFERMAZIONE DEL COGNOME ITALIANO ( obbligo di individuare il fedele tramite un cognome )
E' possibile che la Chiesa cattolica ad inizio 1600 colga la tendenza delle societa' a cognominarsi (individuare tramite un cognome ) e l'adotti contribuendo al definitivo successo del cognome sulla forma patronimica ma l'esigenza fondamentale e' il controllo della consanguineita' nei matrimoni . Come abbiamo detto non dovunque i parroci sono solerti nell'ottemperare alle indicazioni di dare un cognome , e neppure i Vescovi nel controllare Pero' abbastanza generalmente si trovano i registri e abbastanza abitualmente si comincia a vedere il medesimo cognome passare da una generazione a quella successiva
Il concilio di Trento nato per imporre l'ortodossia della religione cattolica e responsabile della definitiva rottura con le chiese protestanti, istitui un sistema di controllo sulla popolazione attraverso la registrazione cartacea in appositi registri di alcuni avvenimenti della vita religiosa del fedele
Il concilio di Trento e' quindi una tappa fondamentale per tante cose Anche per i genealogisti e' una tappa fondamentale. tra le risoluzioni del concilio l'obbligo per i parroci di istituire una serie di registri che ci permettono da allora in poi di avere un quadro anagrafico delle singole comunita' Lo scopo era di evitare i matrimoni tra consanguinei e di determinare la cura delle anime e molto probabilmente aumentare il contatto e la vigilanza del parroco nei confronti dei parrocchiani L'obbligo di registrare le nascite , e di individuare i legami di parentela con la massima chiarezza porta a una generalizzazione dell'uso del cognome L'istituzione obbligatoria di documenti religiosi quali il libro dei battesimi , lo stato delle anime, il libro delle morti , i libri dei cresimati , il libro dei matrimoni permettono spesso di seguire le linee genealogiche lndietro nel tempo fino alla seconda meta' 500
Questi registri religiosi risolvono evidentemente molti problemi al genealogista , anzi risolvono problemi talvolta altrimenti insuperabili perche' l'anagrafe civile ( autonoma da quella religiosa ) del Regno d'Italia risale solo agli anni subito successivi al 1860 e prima , in molti luoghi , vi e' molto poco Il granducato di Toscana ha tutta una serie di documenti che partono dall'occupazione francese e vanno sino all'unita' Ed inoltre troviamo un censimento nel 1841
Nonostante , gli sforzi non dovunque il cognome si impose E troviamo ancora ai primi dell'ottocento luoghi in cui nonaveva attecchito ( normalmente piccole comunita') .
Decreto emanato da Eugenio Napoleone in data 11 giugno 1813 un decreto che imponeva ad ogni cittadino residente l’assunzione del cognome. Era un segno tangibile di voler porre fine all’oscillazione linguistica che aveva caratterizzato tutto il periodo dell’Antico Regime, ed una stretta burocratica dello Stato sul cittadino
Insomma arrivati alla seconda meta' del cinquecento coi registri ecclesiastici istituiti dovunque col concilio di Trento ATTENZIONE : in alcuni luoghi fortunati si trovano registri dei battesimi che scendono fino al 1300 e anche libri dei morti
in genere pero' per risalire indietro nel tempo occorre poi affidarsi ai documenti fiscali e notarili gabelle e tasse hanno sempre accompagnato la vita di ogni individuo come tanti angeli custodi In Toscana troviamo conservati documenti fiscali gia' dal trecento e documenti notarili anche di molto precedenti ed anche molti archivi storici che contengono documenti sugli abitanti fino a tempi remotissimi In Sicilia sono utilissimi i Riveli di beni e di anime che coprono un periodo che va dal 1500 al 1800 Nel Regno di Napoli i Catasti onciari ( meglio il catasto onciario ) coprono un periodo limitatatissimo a fine settecento ........................................
Purtroppo non tutto si e' conservato e quindi l'arma essenziale del genealogista e' la pazienza e la fortuna
|
LE FONTI E LA LORO CLASSIFICAZIONE
interessante messaggio da sul forum IAGI del dr Alessio Bruno Bedini » domenica 25 giugno 2006, 12:48
Tempo ci fu una interessantissima discussione portata avanti in specie da me e da Grimaldi sulle fonti storiche. Questo è un argomento di primaria importanza sia per lo storico che per il genealogista. Ci terrei particolarmente che fosse chiaro una volta per tutti in modo da stabilire una piattaforma comune e tenere lontano i fantagenealogisti.
Sul tema lessi
1. Paolo Delogu, Introduzione alla storia medievale, Il Mulino, 2003
2. Marc Bloch, Apologia della storia, Einaudi, 2005
Analizziamo ora alcune questioni fondamentali:
Cos'è una fonte storica? Marc Bloch risponde: "La varietà delle testimonianze storiche è pressochè infinita. Tutto ciò che l'uomo dice o scrive, tutto ciò che costruisce, tutto ciò che sfiora, può e deve fornire informazioni su di lui".
Dunque tutto può essere una fonte. Dalla testimonianza orale alla lapide del cimitero, dal documento ufficiale al famoso diario di zio pippo.
Ma tutte le fonti hanno lo stesso valore? Ovviamente no! E per questo motivo le fonti una volta raccolte vanno classificate e analizzate.
Per la classificazione si seguono in genere diveri criteri. Il più importante è la distinzione tra:
a) Fonti primarie. Le fonti coeve che risalgono al periodo che lo storico intende studiare;
b) Fonti secondarie. Sono piuttosto studi, interpretazioni, ricerche, ricostruzioni effettuate in epoca successiva al periodo che si intende studiare.
Un altra distinzione importante è tra:
1) Fonti volontarie. Sono quelle che sono state create allo scopo deliberato di lasciare un ricordo, una testimonianza per i posteri e in tali fonti l'autore era consapevole dell'importanza che avrebbe avuto la sua opera e quindi a volte non sono complete poichè l'autore trasmette solo quello che vuole trasmettere.
2) Fonti involontarie. Le fonti involontarie sono costituite da quasi tutto ciò che il passato ci ha lasciato, ma non intenzionalmente, sono paragonabili ad indizi che trasmettono o suggeriscono informazioni, magari incomplete e frammentarie, come sono appunto gli indizi.
Per quanto riguarda l'analisi delle fonti invece i criteri di maggior importanza sono il grado di:
x) Autenticità (per le fonti primarie). Ad esempio tutte le lettere pubblicate a firma di Maria Antonietta non furono scritte da lei: alcune furono compilate nel secolo XIX
y) Credibilità (per le fonti secondarie). Riguarda la credibilità dell'informazione o dell'informatore.
La ricerca genealogica si fa metodologicamente scendendo documento dopo documento da noi di figlio in padre , di padre in nonno, di nonno in avo , di avo in avo , di luogo in luogo, utilizzando documentazione degna di fede utile allo scopo ( documenti anagrafici o documenti sostitutivi di quelli anagrafici ) ricavandone appunto i relativi dati anagrafici
Una sorta di ricerca scendendo nel passato col filo a piombo, da un antenato a quello precedente , desumendo via via la posizione nell'albero genealogico e l'ordine cronologico dei vari individui
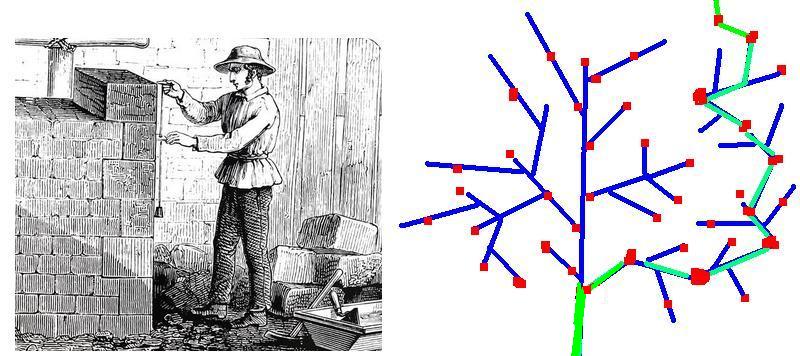
Prima di tutto, si parte dai documenti conservati nella propria famiglia, che possono essere tanti o pochi a dipendenza dell'importanza avuta in passato dal casato e anche da ciò che si è voluto conservare. Fino ad alcuni decenni fa in ogni famiglia, specialmente del ceto rurale, tutti i manoscritti importanti si conservavano (magari in solaio o in qualche cartone o baule). Con l'avvento della civiltà dei consumi ci fu un vero scempio in questo campo e si bruciarono o si indirizzarono al macero numerosissimi documenti, certamente di notevole valore storico locale. Inoltre ci si dovrà basare su quanto raccontato dai genitori, nonni parenti, nonché da altra gente del villaggio di origine. Tutto quanto raccontato dai vecchi, perfino le leggende, ha un fondamento nella realtà storica. Avuta la notizia, bisognerà poi accertarne il fondamento a mano dei documenti.
Si aprono due strade che ossono essere percorse anche contemporaneamente
Ci si affida fin dall'inizio ai registri anagrafici parrocchiali: libri dei battesimi, dei matrimoni, dei defunti, elenco dei cresimati, stati delle anime. Come è intuibile, prima di una certa data detti registri sono manoscritti in latino, ma si tratta di un latino volgare assai comprensibile. La presenza della Chiesa e il profondo legame delle sue istituzioni con il territorio permeano l'intera storia italiana: gli archivi ecclesiastici sono depositari di un patrimonio documentario di immenso valore, il cui studio contribuisce alla ricostruzione di larghissima parte della storia italiana.
Questi argomenti ci accompagnano fino alla meta' del cinquecento -inizio seicento a seconda delle zone
Giu' giu' quindi fino agli anni intorno al 1600 ( anni in cui i dettami del Concilio di Trento vengono rispettati quasi ovunque dai parroci ) la ricerca a ritroso e' abbastanza agevole perche' gli archivi religiosi sono pieni di dati su ogni famiglia italiana ed ogni gruppo parentale viene identificato dai parroci con un medesimo cognome per evitare matrimoni tra consanguinei
L'abbastanza agevole e' legato alla perdita di documenti per incurie o disgrazie e alla forte mobilita' delle famiglie di luogo in luogo , che rende il filo genealogico come il percorso di un fiume carsico che ogni tanto scompare per ricomparire poi in un altro luogo talvolta con un cognome diverso
Infatti la difficolta' consiste che per seguire il filo genealogico occorre conoscere gli spostamenti della famiglia e le parrocchie a cui la famiglia faceva riferimento .Cosa talvolta non agevole
Vi e' poi un'intervallo temporale che genera difficolta nel periodo in cui i rapporti tra Stato e Chiesa diventano difficili : !870 fine del potere temporale ----1929 patti lateranesi
La seconda strada e' quella dell'anagrafe dello Stato unitario
Parlo di atto di nascita , di atto di morte, di atto di matrimonio , di atto di residenza, ................
Le vicende territoriali italiane sono state complesse ma dai giorni nostri al 1919 possiamo parlare di uno Stato unitario con una sua anagrafe
Anche qui troveremo la difficolta' di conoscere la residenza dei nostri antenati e quindi di stabilire a quale comune rivolgerci per averli
Ma fino al 1919 i documenti sui nostri antenati sono una quantita' enorme ed e' abbastanza difficile non trovarne traccia
E' il trionfo della burocrazia
documenti fiscali , militari, permessi di fare qualcosa , documenti igienico sanitari , onoreficenze , patenti , .................
-Verbali comunali, che prima erano i verbali della pubblica Vicinanza, ossia dell'assemblea dei Vicini.
-I registri delle taglie, cioè delle imposte dirette di un comune;
-I testamenti e gli arbitrati , conservati specialmente negli archivi parrocchiali;
-I protocolli delle imbreviature dei pubblici notai (rogiti notarili), dove in ogni strumento rogato dal notalo, per esigenza giuridica stessa dell'atto, sono dettagliatamente nomi- nate le persone coinvolte;
-I registri delle Confraternite, che nei secoli scorsi avevano anche uno spiccato scopo sociale e fungevano da banche locali (quindi con l'indicazione di tutti coloro che facevano dei legati e di coloro che ricevevano prestiti in denaro);
-I pubblici contratti ( vendita di boschi da tagliare da parte di un comune e successiva ripartizione del ricavato tra i fuochi vicini, pubblico reclutamento di soldati, appalto di costruzioni nel comune, ecc.);
-I processi civili e penali, in particolare i processi per stregoneria, dove si trovano anche lunghissimi elenchi di indiziati di eresia segreta, cioè di stregoneria;
-I registri agricoli, con il bestiame caricato sulle alpi e con i relativi proprietari, con i pegni (multe) pagate per trasgressioni agricole;
- Le mappe catastali e gli estimi; Le divisioni ereditarie;
........................................................................
Comunque lo strumento principe e' lo Stato di famiglia Storico (o originario),
L'Anagrafe della popolazione residente si configura come un "registro" che documenta la posizione dei cittadini residenti, siano essi italiani o stranieri, e ne rileva i movimenti. L'Anagrafe, inoltre, tiene conto di tutti i mutamenti che si verificano nel Comune per cause naturali o civili, cioè per nascita, matrimonio, morte, emigrazione, immigrazione I cittadini italiani debbono da sempre essere iscritti nell’anagrafe di un Comune italiano, con l’obbligo di comunicare al proprio Comune tutte le variazioni dei dati anagrafici (stato civile, cittadinanza, indirizzo, composizione della famiglia, residenza). Le schede relative alle famiglie - i cosiddetti "cartellini" - consentono di elaborare facilmente un documento chiamato Stato di famiglia Storico (o originario), che presenta lo specchietto dei vari componenti un nucleo familiare, riportando le relative indicazioni su data e luogo di nascita, di matrimonio, di morte. In genere i registri dei comuni sono corredati da indici alfabetici annuali o decennali per ogni tipologia di atto. In caso contrario può non essere semplice per il comune rintracciare un singolo nominativo, soprattutto quando le richieste si riferiscono ad un arco cronologico e non ad una data precisa.
|
In realta' l'anagrafe italiana segue le fasi della riunificane ed ha l'avvio con la proclamazione del Regno d'Italia . Proclamazione monca ancora del Veneto e di Roma nel Regno d'Italia l'Anagrafe fu istituita, anche se a carattere facoltativo, con Regio Decreto 31 dicembre 1864, n. 2106; successivamente venne resa obbligatoria con legge 20 giugno 1871, n. 297. I dati anagrafici sono pubblici, ma solo attraverso l'emissione di certificati; infatti, non è consentito consultare i registri d'Anagrafe. I certificati di nascita, matrimonio e morte di regola conservati presso gli Uffici di Stato Civile dei comuni italiani a partire dal 1866, cioè dopo l'emanazione del Regio Decreto 15 novembre 1865, n. 2062 sull'ordinamento dello Stato Civile e sono regolamentati dal Regio Decreto 9 luglio 1939, n.1238.
Quindi il primo fatto dirimente e' la proclamazione del Regno d'Italia con a capo i Savoja Il secondo fatto dirimente e' la conquista napoleonica
L'intervallo di tempo che va dalla conquista napoleonica alla proclamazione del Regno unitario rappresenta per l'anagrafe degli stati preunitari tutta una serie di comportamenti diversi Il periodo prima della conquista napoleonica si configura come totalmente privo di anagrafe CIVILE per tutta l'Italia. In tutta Italia fa testo solo l' anagrafe RELIGIOSA ( che dovrebbe partire dal CONCILIO DI TRENTO ) ma che in molti luoghi parte anche precedentemente
Fuori dall'anagrafe religiosa avanti l'anagrafe di origine francese , bisogna arrangiarsi con documenti vari e DIVERSI da Stato a Stato preunitario TIPOLOGIE DI DOCUMENTI esistenti in uno Stato ( talvolta in un luogo ) non esistono in un altro stato documenti fiscali documenti catastali documenti notarili : in particolare testamenti , successioni , doti e patti matrimoniali , acquisti e vendite , ................ Tribunali sentenze civili e penali censimenti antichi alberi genealogici ( da controllare !!! ) ..........................
|

In alcune città italiane i rapporti mercantili capitalistici s'erano formati già nei secoli XIV e XV, ma a causa del frazionamento politico e della controriforma inizia una decadenza che durerà sino all'unificazione nazionale.
Agli inizi del 1500 Milano era governata dai duchi della famiglia Sforza, Venezia dall'oligarchia commerciale, Firenze dai Medici, nell'Italia centrale vi era lo Stato della Chiesa e a sud il regno di Napoli, governato dalla dinastia spagnola degli Aragona. Non esisteva un unico mercato nazionale come in Inghilterra e in Francia. Le città, pur essendo molto ricche, basavano la loro attività sul commercio coll'estero e questo le rendeva inevitabilmente rivali. Di qui l'inizio della decadenza economica, dopo la grande fioritura dei Comuni e delle Signorie.
La Spagna non faceva altro che perseguire una politica di rafforzamento dell'ordine feudale esistente nell'Italia meridionale e in Sicilia. Ciò ebbe come conseguenza un progressivo impoverimento delle masse contadine.
Lo Stato della Chiesa non era interessato all'unificazione nazionale. Sul piano economico aveva un sistema analogo a quello spagnolo. Inoltre era impegnato nella lotta contro la Riforma protestante, di cui temeva il diffondersi negli stati italiani.
Nel corso del '500 si sviluppano notevolmente le arti (Raffaello, Michelangelo, Ariosto, Leonardo da Vinci, ecc.).
* * *
Il Seicento italiano fu caratterizzato dal predominio della monarchia spagnola, che diventò sicuro dopo la pace di Cateau-Cambrésis (1559), con cui si pose termine alle guerre italiane tra Borboni di Francia e Asburgo di Austria e Spagna: quest'ultimi occupano il ducato di Milano e tutta l'Italia meridionale e insulare.
Tale situazione resterà invariata fino alla pace di Utrecht tra Francia e Spagna (1713), che concluderà la guerra di “successione spagnola” (1700-1713), causata dal fatto che l'ultimo discendente Asburgo di Spagna, Carlo II, era morto senza lasciare figli maschi.
La Spagna conserverà l'indipendenza dalla Francia, ma sul suo trono salirà un Borbone francese e il suo predominio in Italia verrà surclassato da quello austriaco fino al 1748 (pace di Aquisgrana fra Borboni spagnoli e Asburgo austriaci).
La Sicilia in un primo momento passerà al duca di Savoia, in seguito agli Asburgo d'Austria, mentre la Sardegna ai Savoia. Dopo il 1748 i Borboni spagnoli (subentrati agli Asburgo spagnoli) torneranno nel Mezzogiorno (esclusa la Sardegna) e l'Austria resterà in Lombardia e Toscana.
Durante l'egemonia spagnola resteranno relativamente indipendenti: Repubblica Veneta (oppressa però nei suoi domini mediterranei dai Turchi), Stato Pontificio (che nulla aveva potuto nell'Europa settentrionale con la Controriforma) e Ducato di Savoia (condizionato però dagli Asburgo in Lombardia e dalla Francia a occidente).
Sul piano economico l'Italia ebbe un tracollo dal quale, fino all'unità nazionale, non riuscirà più a sollevarsi. Divisa in tanti staterelli fra loro concorrenziali, l'economia mercantile non riuscì a trovare lo spazio sufficiente per allargarsi e ingrandirsi (i dazi doganali e il protezionismo glielo impedivano). Influenzata inoltre dalla Controriforma cattolica e dalla politica conservatrice, aristocratica e di mera rapina degli Asburgo, l'Italia fu costretta ad abbandonare i mercati (nei quali si era distinta prima di ogni altra nazione europea) e a ritornare alla terra (rifeudalizzazione), la quale, anche se garantiva redditi minori, era una fonte d'entrata più sicura. Naturalmente non mancarono le rivolte contro il governo spagnolo (la più famosa fu quella di Napoli del 1647, capeggiata dal pescivendolo Masaniello) - ma nessuna ebbe esito positivo.
Verso la metà del 1700 al nord nobiltà e clero avevano circa i 2/3 di tutte le terre coltivabili, al sud addirittura i 9/10. Il livello dell'agricoltura era molto basso e la tecnica primitiva. Molti contadini fuggivano all'estero o si ribellavano, diventando anche eretici (Valdesi).
Complessivamente le ragioni della decadenza sono queste:
assenza di un unico mercato interno;
presenza di barriere doganali, dazi elevati e protezionismo fra gli stati italiani (il che comporta l'aumento del prezzo delle merci);
all'interno di ogni stato italiano solo la città principale poteva estendere la propria industria; quando Inghilterra, Francia e altri paesi nord-europei sviluppano una loro manifattura, i prodotti (soprattutto tessili) delle città industriali italiane (Firenze, Milano, Venezia, Padova...) non sono più concorrenziali. Altre industrie entrano in crisi: cantieristica, cotone, armi, ecc. Solo i prodotti di lusso continuano ad essere richiesti (seta, oreficeria, vetro veneziano, oggetti d'arte) ma il consumo riguarda una stretta minoranza;
dopo la conquista turca di Costantinopoli nel 1453, i mercanti italiani, per riavere i diritti commerciali, devono pagare forti tasse, per cui i rapporti coll'Oriente finiscono (l'unica via era quella che passava per l'Egitto, ma qui i sultani arabi hanno il monopolio del commercio);
con la scoperta dell'America (1492) il Mediterraneo perde molta della sua importanza, a tutto vantaggio delle coste atlantiche.
A causa della decadenza economica, accelerata dalla divisione politica, mercanti e imprenditori cominciano ad abbandonare l'attività commerciale e industriale, cercando altri settori nei quali investire con profitto i propri capitali. Di qui lo sviluppo delle operazioni puramente finanziarie e usuraie (prestiti concessi ad alti interessi); di qui l'acquisto di terre e di titoli nobiliari da parte della borghesia cittadina. In pratica, mercanti, banchieri e imprenditori si trasformano in proprietari terrieri che concedono ai contadini piccoli appezzamenti di terra in affitto e a condizioni semifeudali. La rendita feudale diventa la fonte principale dei loro redditi.
Nell'Italia centrosettentrionale, man mano che si chiudono le industrie (opifici), una gran quantità di operai è costretta a lasciare le città e a ritornare nelle campagne. Di qui il grande sviluppo dell'orticoltura. Il tipo fondamentale di affitto diventa la mezzadria: cioè in base a un contratto il mezzadro deve assumersi tutte le spese dell'azienda, apportare i miglioramenti necessari e introdurre nuove colture. In tutto questo il proprietario poteva sempre interferire. Egli però s'impegnava a fornire sementi, bestiame, strumenti agricoli o il denaro per comprarli. Il mezzadro doveva dare metà raccolto al proprietario e pagare le imposte allo Stato.
Purtroppo, i mezzadri, dovendo sopportare il peso delle guerre di conquista franco-spagnole e vessati da interessi usurai, facilmente diventavano, pur essendo formalmente liberi, schiavi del loro padrone, per cui la fuga era punita col carcere. E così, oltre alla metà del raccolto, il padrone, col tempo, pretenderà altre corvées. In una situazione ancora peggiore si trovavano gli operai salariati agricoli, completamente privi di qualsiasi proprietà.
Il commercio era praticamente inesistente: i paesi nord-europei erano più forti e concorrenziali. Anche l'industria stagnava. I ceti privilegiati non pagavano tasse, vivevano di rendita, ricoprivano le cariche maggiori nell'esercito e nell'apparato statale...
E' nella seconda metà del '700 che l'Italia, grazie a un prolungato periodo di pace, può in parte riprendersi economicamente. Lo sviluppo dell'agricoltura assume un carattere più mercantile che feudale. La classe borghese s'interessa a migliorare la produzione agricola. Si sviluppa la manifattura tessile e metallurgica, dove venivano riuniti molti operai, nonché molti lavoratori a domicilio che eseguivano operazioni singole.
Sommosse tuttavia non mancarono in questo periodo. L'aumento dei prezzi infatti facilmente trasformava i contadini in braccianti, gli artigiani in operai salariati delle manifatture. Di fronte a queste sommosse i governi assolutistici italiani cercano di alleggerire la pressione sulle masse intaccando alcuni privilegi delle classi nobiliari e del clero, ma la maggioranza delle riforme dell'assolutismo illuminato fallisce, a causa delle resistente delle classi privilegiate.
Ciò indusse gli ideologi illuministi della giovane borghesia italiana a chiedere l'abolizione dei privilegi dei nobili e del clero, nonché l'applicazione di leggi egualitarie. Si formano delle Società culturali borghesi (ad es. quella dei Pugni ove il Beccaria scrisse Dei delitti e delle pene) che chiedevano la fine della divisione politica degli stati italiani, l'abbattimento delle barriere doganali, dei dazi protettivi, l'adozione di una legislazione unificata, ecc. Queste Società riponevano grandi speranze nei monarchi, esortandoli a unirsi e a togliere le terre ai nobili e al clero per darle ai contadini.
A queste idee presto si aggiunsero quelle provenienti dalla Francia rivoluzionaria, ma gli illuministi italiani, molto più di quelli francesi, continuavano ad attendere le riforme dall'alto. Ciononostante la Rivoluzione francese trovò in Italia molti seguaci. Nel nord i francesi insieme agli italiani illuministi costituirono la Repubblica Cisalpina (ex-possessi austriaci, ex ducato di Modena, Legazioni pontificie), a Genova la Repubblica Ligure, a Roma quella Romana, a Napoli quella Partenopea.
Tuttavia, l'aspirazione degli illuministi italiani alla costituzione di una Repubblica unificata non trovò l'appoggio di Napoleone, che preferiva dominare un'Italia divisa. Questo fu uno dei motivi per cui gli italiani si allontanarono dalla Francia. Altri motivi furono: il carattere predatorio della politica francese, la divisione dei territori della Repubblica Veneta fra Austria e Francia, il sequestro francese di moltissime opere d'arte italiane, la mancata concessione ai contadini delle terre confiscate al clero (terre che finirono solo alla borghesia).
Milano nel 700 - Cesare Borgia

by Tuttogenealogia.it
Ricercare prima del 1800
D: consapevole che i registri dell'anagrafe sono stati introdotti nel 1806 in Italia, come posso fare a risalire a ulteriori antenati?
R: Prima di quel tempo c'erano i registri parrocchiali, se la parrocchia di tuo interesse li conserva puoi trovare: battesimi, matrimoni e morti.
Sono generalmente in latino, ma comunque non sono impossibili da capire
In più potresti anche trovare gli stati delle anime, un registro dove per ogni famiglia si segnavano tutti i suoi componenti (sinceramente non mi è mai capitato di trovarli nella mia ricerca). Se non sono andati distrutti potrebbero anche partire dalla fine del '500. Se la parrocchia non li costudisce prova a contattare l' archivio diocesano, potrebbero averli loro. gli "stati delle anime" sono dei veri e propri censimenti delle famiglie che componevano il paese.
Spesso il problema più che il latino sono le calligrafie a volte impressionant
Ti consiglio di contattare l'Archivio Storico della Diocesi e chiedere in maniera più dettagliata la tipologia di documentazione disponibile
Oppure negli archivi di stato puoi trovare gli atti notarili, in questo caso però la ricerca è più complessa.
Poi c'è anche il catasto onciario. In tutto il Regno di Napoli a metà del 1700 fu redatto questo catasto in cui puoi trovare una sorta di stato delle anime e l' importo tassato ad ogni famiglia (e se non sbaglio anche una descrizione dei beni). Si trova all' archivio di stato di Napoli.
In Sicilia ci sono i "riveli"
Ricapitolando per ricerche nel 1700.
Registri parrocchiali (parrocchia o Diocesi);
Stati delle Anime (parrocchia o Diocesi);
Processetti matrimoniali (Diocesi);
Catasti e Numerazioni dei Fuochi (Archivi di Stato o Archivi Comunali);
Atti notarili e altri documenti vari (Archivi di Stato).
E la documentazione fiscale , eternamente le tasse
by Tuttogenealogia.it
|
considerazionigenealogiche
Come detto la strada piu' facile per una ricerca genealogica in Italia e' rappresentata dalla consultazione dei registri della Chiesa cattolica La chiesa dai tempi piu' antichi si' e' presa l'incarico di provedere almeno alla registrazione del battesimo Cosi troviamo in alcuni luoghi elenchi di battesimi risalenti anche al XIV secolo Solo a Siena il comune ebbe un analoga premura e provvide autonomamente ad un analoga operazione (battesimi delle tavole della Biccherna )
Molto piu' tardi la Chiesa ha iniziato ad occuparsi dei matrimoni sebbene su di essi avesse appuntato la sua attenzione , da molto tempo , per gli impedimenti legati alla consanguineita' Mentre per molto tempo ha invece trascurato la registrazione dei decessi. Operazione ,invece non trascurata dalle autorita' civili che attraverso l'anagrafica ecclesiastica delle nascite e quella civile dei battesimi cercavano di tenere sotto controllo l'andamento demografico ed i fabbisogni di cibo della popolazione
Una grande svolta si ha col concilio di Trento che fa seguito alla grande ulteriore divisione delle chiese cristiane che segue la divisione tra la chiesa di Oriente e di Occidente Ora a dividersi nettamente dalla Chiesa cattolica e' una larga fetta di paesi del Centro e Nord Europa
E' importante per un ricercatore genealogista conoscere le decisioni prese alla fine del Concilio di Trento nel 1563 e quanto avvenne nel 1614 l'intenzione della Chiesa cattolica era di combattere le eresie e le cattive abitudini religiose , a questo fine la chiesa cattolica creo' una gabbia che imprigionava l'intera comunita' cattolica in un sistema unico di sorveglianza Iniziato nel 1563 il sistema si perfeziono' nel 1614 e si trasmise fino ai nostri giorni A vigilare sul sistema furono delegati i parroci , a vigilare sui parroci i Vescovi Purtroppo ( sempre per il genealogista ) i parroci non sempre e non in ogni luogo furono solerti ad applicare le disposizioni e puo' succedere che i registri in certi luoghi non ci fossero o non fossero formulati secondo le disposizioni Purtroppo per il genealogista non sempre e non dovunque i registri religiosi sono sopravvissuti all'incuria e ai disastri Ma vediamo che cosa cosa accade nel 1563 e nel 1614 di tanto utile al genealogista Noi siamo abituati ad identificare la nostra famiglia con un cognome ma esiste un periodo molto lungo in cui gli individui della nostra famiglia non sono stati individuati attraverso un cognome ma attraverso un patronimico
Generalmente i cognomi nascono in Italia tra il 1100 ed il 1200 (lo abbiamo visto nella prima parte ) Ed abbiamo visto che non tutte le famiglie si cognomizzano .Che la cognomizzazione si estende lentamente nelle varie famiglie e che inizialmente la cognomizzazione riguarda solo le famiglie del ceto dirigente Nel 1614 secondo le intenzioni della Chiesa cattolica ciascuna famiglia avrebbe dovuto essere identificata con un cognome Essendo lo spirito guida della ricerca genealogica il cognome ecco che i registri religiosi diventano fondamentali per la ricerca genealogica dal 1614 ai giorni nostri Ed inoltre fornendo i battesimi dal 1563 permettono di spingere la ricerca fino a questa data
L'ANNO 1563 : TERMINA IL CONCILIO DI TRENTO E' L'ANNO DECISIVO PER LA GENEALOGIA ITALIANA ( registri di battesimo e di matrimonio )
L'ANNO 1614 : E' L'ANNO DECISIVO PER L'AFFERMAZIONE DEL COGNOME ITALIANO ( obbligo di individuare il fedele tramite un cognome )
E' possibile che la Chiesa cattolica ad inizio 1600 colga la tendenza delle societa' a cognominarsi (individuare tramite un cognome ) e l'adotti contribuendo al definitivo successo del cognome sulla forma patronimica
Il concilio di Trento nato per imporre l'ortodossia della religione cattolica e responsabile della definitiva rottura con le chiese protestanti, istitui un sistema di controllo sulla popolazione attraverso la registrazione cartacea in appositi registri di alcuni avvenimenti della vita religiosa del fedele Inizialmente furono presi in considerazione solo la nascita il matrimonio Da quel momento in poi ogni parroco doveva annotare in libri separati i battesimi e i matrimoni avvenuti all’interno della parrocchia. Lo scopo era di seguire la vita religiosa dell'individuo ed evitare che venissero violate le leggi religiose con matrimoni tra consanguinei , tra parenti spirituali ( padrini , madrine ), o evitare situazioni di bigamia o convivenza (abbastanza comuni nei tempi ante concilio ) In generale, la chiesa avrebbe dovuto tenere i registri dallo 11 novembre 1563 . Molte parrocchie si conformarono solo molto più tardi. La maggior parte delle parrocchie,infatti, hanno mantenuto i registri da circa 1595 a oggi. Infatti nel 1595 vengono rafforzate le imposizioni papali Quasi ogni persona che ha vissuto in Italia e di religione cattolica , è stata registrato in un verbale della chiesa cattolica durante gli ultimi 400/500 anni. Col Concilio di Trento la Chiesa cattolica da il via all'obbligo per tutti i parroci di registrare su carta e conservare in appositi registri : I battesimi I matrimoni con relative pubblicazioni e processetti matrimoniali Mentre prima le registrazioni erano iniziativa delle singole diocesi ora diventa un obbligo tener nota in parrocchia almeno di nascite e matrimoni Quindi , la chiesa comando' la tenuta di questi primi registri ( battesimi,matrimoni ) nel 1563 a causa delle riforme proclamate in occasione del Concilio di Trento. Le parrocchie si sono conformate ai nuovi dettami in tempi diversi a seconda della solerziadei parroci e dei vescovi che avrebbero dovuto vigilare. La maggior parte delle parrocchie, tuttavia, hanno mantenuto i registri da circa il 1595 a oggi. Nel 1595 infatti vi e' stato un nuovo richiamo papale per richiamare i parroci all'obbligo delle pratiche di registrazione e la quasi totalita' dei parroci ancora inadempienti inizia ad adeguarsi L'obbligo della registrazione su carta comporta l'abitudine a mettere su carta i dati importanti per la religione Il libro dei battesimi (liber baptizatorum) è il registro in cui vengono annotati i nominativi di coloro che hanno ricevuto il sacramento del battesimo. Ogni parroco è tenuto a compilarlo e a conservarlo a partire dalle disposizioni contenute nel decreto istitutivo del Concilio di Trento. Istruzioni relative ai formulari da utilizzare nella compilazione dei dati sono fornite dal Rituale romano di papa Gregorio XIII del 1583, in seguito riprese nel rituale del 1614 di papa Paolo V. Secondo le indicazioni stabilite dalla normativa, sui registri dei battesimi i parroci hanno il compito di annotare il nome del battezzato, paternità e maternità, la data del battesimo, il nome del celebrante, i nominativi di padrini e madrine. Vengono aggiunte delle precisazioni in caso di figli illegittimi, esposti, di battezzati sub conditione o di celebrante differente dal parroco. Il Codice di diritto canonico del 1983 prevede che nel libro dei battezzati sia annotato successivamente anche la confermazione e tutto ciò che riguarda lo stato canonico dei fedeli, in rapporto al matrimonio, all'adozione, all'ordine sacro, alla professione perpetua emessa in un istituto religioso e al cambiamento del rito. Leggendo questi libri possiamo facilmente notare che nei secoli passati moltissime erano le nascite, ma erano davvero pochissimi i bambini che sopravvivevano a causa dell'elevatissima mortalità infantile. Inizialmente furono compilati in italiano, con note scarne ed essenziali, in seguito, a partire dalla seconda metà del Seicento, si diffuse l'uso del latino e di formule sempre più complete e accurate. A partire dagli inizi del XX secolo vengono usati registri prestampati. I bambini sono stati battezzati in genere entro pochi giorni dalla nascita. I registri battesimali di solito danno i nomi del bambino e dei genitori, lo stato di legittimità, nomi di testimoni o padrini, e la data del battesimo. È inoltre possibile trovare la data del bambino nascita, professione del padre, e il luogo della famiglia di residenza. Morte o informazioni matrimonio è stato a volte aggiunto come una nota a margine. Il nome della via o l'indirizzo della famiglia possono essere fornite anche per le città più grandi. Nella versione più completa, la registrazione di battesimo presenta anche il numero di pagina ed il numero progressivo di registrazione nell’anno, la data di nascita, inclusa l’ora, e la data di battesimo con il nome di chi ha amministrato e del parroco, il nome e cognome del neonato (con due colonne distinte per registrare i maschi e le femmine), il nome del padre e del nonno e nonna paterna, il nome e cognome della madre e del nonno e nonna materna, inoltre compare anche la via e il numero civico dove risiedono i genitori, luogo e data di matrimonio. Ma le informazioni potrebbero essere molte di più. Infatti talvolta è presente la professione dei genitori, nome e cognome dei padrini, dei loro rispettivi padri e la parrocchia da dove provenivano e l’ostetrica. Purtroppo in passato era molto frequente che fosse la stessa ostetrica ad amministrare il battesimo nel caso in cui il bimbo era reputato in pericolo di vita. Se il bimbo non moriva, venivano “supplite le cerimonie” in chiesa da un sacerdote. Ecco perchè anche nel registro troviamo informazioni riguardanti l’ostetrica. I registri precedenti danno meno informazioni. Essi possono dare solo i nomi del bambino e il padre e la data del battesimo. Essi possono contenere il nome della madre, o possono contenere solo il suo nome di battesimo. I primi registri registrano solo la data del battesimo; record successivi possono includere la data di nascita. Quindi nel battesimo : chi e' il padre ( talvolta il nonno ) chi e' la madre ,chi e' il padrino chi e' la madrina Aborti spontanei sono stati a volte registrati in chiesa battesimale o registri di sepoltura. Nella maggior parte dei casi, tuttavia, la nascita non viene registrata
PIEVE = Chiesa con battistero Entrambi gli aspetti connotativi, l'amministrazione del battesimo e l'esazione delle decime, cominciarono ad essere vincolanti a partire dall'epoca carolingia, grazie a precise norme che furono introdotti nella legislazione e grazie ad una massiccia e capillare azione di riordino delle comunità cristiane. Da una parte, i sacramenti maggiori non si potrevano ricevere in luoghi diversi dall'edificio che si era affermato come chiesa battesimale e la sepoltura era fortemente limitata. Dall'altra, il versamento della decima era obbligatorio per i manentes, i residenti sulle terre sottoposte alla pieve. Non si trattava di una tassa nominale, ma di un prelievo sui frutti della terra, che venne, gradualmente e problematicamente, fissato in relazione con le aree su cui erano presenti i coltivatori, liberi e servi. Proprio per effetto di questo legame la pieve andò definendosi come circoscrizione territoriale, all'interno della quale i residenti erano legati alla chiesa principale. A quest'ultima erano gerarchicamente subordinate le altre chiese o cappelle esistenti nell'area. La creazione di una rete, locale e diocesana, di rapporti di aggregazione e di subordinazione avvenne nel corso di un processo secolare, a partire dal IX secolo, sulla base di precedenti legami di fede che avevano unito i vescovi e le Chiese cittadine con le comunità cristiane sparse nei territori circostanti. Nei primi secoli di cristianizzazione delle campagne si era formata una rete a maglie larghe di chiese battesimali o chiese matrici che erano unite ai vescovi residenti nelle città da un legame di fede e da una comunanza di devozioni e di liturgie. La creazione delle circoscrizioni diocesane, basate su un'organizzazione istituzionale e gerarchica delle comunità, si sovrappose a questo assetto primitivo, con un processo discontinuo, fortemente influenzato dalle situazioni e volontà politiche locali, dall'entità e dislocazione dei patrimoni dei singoli vescovi, dalla struttura geomorfologica dei territori. Sia il vincolo “di fede”, sia quello istituzionale gerarchico si affermarono in modo problematico, in fasi diverse, che ebbero tempi e durate differenti. Tra la rete più antica delle dipendenze e quella dell'ordinamento pievano-diocesano non si determinò una piena coincidenza. In area gardesana si creò una molteplicità di singole situazioni, raccordate con i centri diocesani spesso in modo incerto e problematico, all'interno di ambiti ecclesiastici dai confini rimasti indefiniti almeno fino alla fine dell'XI secolo. In tutte, la pieve – o la chiesa battesimale – emerse come soggetto aggregatore locale dotato di una forte identità e di un saldo legame con la popolazione locale. Tanto che, spesso, la pieve, intesa non come semplice comunità di fede, ma come circoscrizione territoriale divenne riferimento per l'identificazione dei luoghi, degli insediamenti o dei possessi fondiari2; si attestò come riferimento amministrativo e geografico.
Le Pievi : Cosa erano le Pievi di Cinzio Violante....................................studio di Cinzio Violante
Il sistema delle pievi.Vita pastorale, edifici e circoscrizioni ecclesiastiche nelle campagne gardesane ....................................studio di Renata Salvarani
PERCORSI RELIGIOSI NEL MUGELLO PIEVI E PIVIERI....................................studio di EMMA MANDELLI MICHELA ROSSI
Pubblicazione di Matrimonio e processetti Accanto ai libri dei matrimoni, che registrano l'atto finale del sacramento amministrato agli sposi, negli archivi parrocchiali sono spesso conservati i documenti preparatori raccolti nel periodo che precede la celebrazione del rito, riuniti in una serie archivistica denominata processetti matrimoniali o pubblicazioni matrimoniali. Nei processetti matrimoniali si possono conservare: si possono conservare: il certificato di battesimo e cresima degli sposi, il certificato di morte in caso di vedovanza di uno dei contraenti, eventuali dispense vescovili rilasciate per ridurre il numero delle pubblicazioni o per ovviare ad impedimenti canonici quali la parentela fino al quarto grado di consanguineità per i futuri coniugi. Il Concordato del 1929 tra Stato e Chiesa riconosce gli effetti civili del matrimonio canonico e, di conseguenza, anche dei documenti ecclesiastici prodotti nell'ambito del sacramento. Un matrimonio è stato generalmente annunciato la domenica per tre messe consecutivi prima del matrimonio. Questi annunci, chiamati pubblicazioni, ha dato occasione a chiunque di farsi avanti se a conoscenza di eventuali motivi per cui la coppia aveva impedimenti al matrimonio In aggiunta o in sostituzione dei registri reali di matrimonio, alcune chiese italiane tenuta libri separati per registrare pubblicazioni di matrimonio.
Registro dei matrimoni Il libro dei matrimoni (liber matrimoniorum) è il registro in cui i parroci annotano i nominativi di coloro che sono stati uniti in matrimonio al fine di registrare l’avvenuta amministrazione del sacramento.Ogni parroco è tenuto a compilarlo e a conservarlo a partire dalle disposizioni contenute nel decreto istitutivo del Concilio di Trento. matrimonio : il matrimonio in genere avveniva nella parrocchia della sposa I registri matrimonio indicano la data del matrimonio, il nome della sposa e dello sposo. Indicano anche se i fidanzati fossero al primo matrimonio o vedovi , danno i nomi dei testimoni. Di solito danno altre informazioni : l' età, la residenza, il lavoro ,i nomi dei genitori, e i luoghi di nascita. Nel caso di vedovi le registrazioni possono nominare i coniugi precedenti e le loro date di morte. I dati riportati sui registri dei matrimoni variano, e sono più o meno dettagliati, a seconda della formula utilizzata dai parroci per annotare il sacramento, ma anche in base al contesto in cui viene celebrato il matrimonio (in caso di omissione delle pubblicazioni per dispensa vescovile, di celebrazione su licenza se il ministro non è il parroco o se gli sposi provengono da altra parrocchia o diocesi, in caso di dispensa per consanguineità, etc.). Nel libro dei matrimoni sono indicati, più comunemente, la data della cerimonia del matrimonio e delle tre pubblicazioni canoniche o l’indicazione della dispensa vescovile che ne ha permesso la riduzione a un numero inferiore, il nome e il titolo del celebrante (archipresbiter, presbiter, rector), il nome degli sposi, loro paternità e maternità, parrocchia o luogo d’origine, il nominativo dei testimoni con loro paternità. In alcuni casi i registri dei matrimoni possono riportare anche informazioni più dettagliate riguardo agli sposi come l’età, la professione, l’alfabetizzazione. Talvolta si trovano anche registri relativi alle pubblicazioni di matrimonio Nel caso di una parrocchia soppressa o accorpata, la loro conservazione può essere affidata all’archivio diocesano, dove spesso si trovano serie documentarie costituite dalle copie dei registri dei sacramenti, tra le quali anche i duplicati dei libri dei matrimoni, che i parroci sono tenuti a consegnare secondo quanto stabilito da disposizioni vescovili e dal Codice di diritto canonico del 1917, che impone di depositare annualmente in curia vescovile una copia dei libri canonici, eccetto gli stati delle anime.
Estratto del sito della Chiesa Cattolica, Il matrimonio si componeva di tre elementi: il sacramento, la Messa, la benedizione solenne degli sposi. Il primo si poteva celebrare in qualunque giorno dell'anno (cfr. CIC 1917, can. 1108 § 1); la seconda (Messa) era proibita in tutti i giorni in cui non si poteva celebrare una votiva di II classe, nelle domeniche e nei giorni in cui era proibita la benedizione solenne degli sposi. La benedizione, non obbligatoria ma caldamente consigliata (can. 1101 § 1), non poteva però essere data al di fuori della Messa (se non con indulto papale: cfr. RM 381, a); la benedizione era proibita dalla I domenica di Avvento a Natale (inclusi i giorni estremi) e dal mercoledì delle ceneri sino a Pasqua (inclusi i giorni estremi) (cfr. can. 1108 § 2). L'ordinario del luogo poteva però concedere di celebrare la benedizione solenne anche nei giorni proibiti, salve le leggi liturgiche, per giusta causa, ammonendo però gli sposi di astenersi da una pompa smodata (cfr. can. 1108 § 3). Nei giorni in cui era proibita la Messa ma concessa le benedizione, si celebrava la Messa del giorno cui si aggiungeva l'orazione della Messa pro sponsis impedita . Se erano proibite tanto la Messa quanto la benedizione, esse si celebravano al giorno più opportuno che non fosse impedito (cfr. RM 380). Nel quinto precetto la Chiesa non vieta la celebrazione del sacramento del Matrimonio; ma soltanto la solennità delle nozze dalla prima domenica dell’Avvento sino all’Epifania, e dal primo giorno di Quaresima sino all’ottava di Pasqua. Quale è la solennità delle nozze proibita? La solennità proibita da questo precetto consiste nella Messa propria degli sposi, nella benedizione nuziale, e nella pompa straordinaria delle nozze. Perché le dimostrazioni di pompa non convengono nell’Avvento e nella Quaresima? Le dimostrazioni di pompa non convengono nell’Avvento e nella Quaresima, perché questi sono tempi specialmente consacrati alla penitenza e all’orazione. Nei tempi passati, la legislazione ecclesiastica esortava a rispettare il clima penitenziale dell'Avvento e, soprattutto, della Quaresima. La celebrazione delle nozze, con l'abituale clima di festa, strideva con l'austerità richiesta in quei tempi liturgici. Per questo, si proibiva la «celebrazione solenne» delle nozze, cioè non si celebrava la Messa né si impartiva la benedizione sugli sposi. Così, il Rituale Romanum, approvato da Pio V dopo il concilio di Trento, nella sua revisione del 1952 da parte di Pio XII, afferma che il matrimonio si può contrarre in qualunque tempo dell'anno, ma la benedizione solenne delle nozze è normalmente vietata in Avvento e in Quaresima. Da questa norma deriva il pensiero comune per cui non ci si può sposare in quaresima. Era vietata la celebrazione solenne delle nozze, con la benedizione sacerdotale sugli sposi. Di fatto, le nozze erano sconsigliate in questo periodo, ma in caso di necessità si potevano celebrare, limitandosi al consenso degli sposi davanti al parroco e a due o tre testimoni. (Lorena Bobbio )
Fin dai primi secoli, l'intervento del sacerdote è stato caratterizzato da una solenne benedizione, dopo l'espressione pubblica del consenso coniugale. Il consenso avveniva all'inizio fuori della chiesa (in facie ecclesiæ), seguito poi da una celebrazione all'interno dell'edificio sacro. Col tempo, si celebrò tutto in chiesa: prima la liturgia essenziale del consenso; poi, dopo che l'uomo e la donna erano stati dichiarati marito e moglie, la Messa, al cui interno era prevista la benedizione sugli sposi. Con la riforma liturgica seguita al Vaticano II, abbiamo un'unica celebrazione, all'interno della quale avviene sia il consenso che la benedizione sugli sposi. (Lorena Bobbio )
La compilazione dei registri dei matrimoni viene recepita più lentamente rispetto alla tenuta di altri libri parrocchiali. Il Concordato del 1929 tra Stato e Chiesa riconosce gli effetti civili del matrimonio canonico e, di conseguenza, anche dei documenti ecclesiastici prodotti nell’ambito del sacramento.
Il 1614 e' l'anno in cui si fa un passo fondamentale per la diffusione del cognome Il concilio di Trento aveva imposto ai parroci l'individuazione del nato, del padre ,dei padrini e delle madrine e l'individuazione degli sposi parlando solo di "nomina"
Nel 1614 la legislazione sopra i registric canonici si arricchisce e si perfeziona col "rituale romanorum" dove al posto di "nomina"(individuazione generica ) si parla di "cognomina" che porta ad imporre ai parroci di identificare l'individuo con un cognome Il cognome era un elemento di individuazione utile a gestire le omonimie , introducendo l'obbligo della individuazione del fedele e della famiglia ai parroci di fatto si favorisce la cognomizzazione delle famiglie . Per cui i registri parrocchiali divengono il mezzo per dare un cognome a chi non lo aveva e designano il prete come colui che da un cognome alle famiglie sotto la sua giurisdizione Siamo di fronte ad un serio tentativo di un anagrafe dei fedeli fatta dalla Chiesa I nuovi registri rendono obbligatorio tener nota di : morti e sepolture ( molte diocesi tenevano nelle parrocchir gia'da prima questi registri , per cui e' possibile trovarne di antecedenti al 1614 ) cresime precetto pasquale: un registro deve esser dedicato a verificare l'osservanza per il precetto pasquale della comunione ( status animarum ) questo in definitiva viene inteso dai parroci come una sorta di censimento e fotografa cosi le famiglie talvolta tenendo conto di tutti i componenti che in quel momento si trovavano presso la casa ( contando anche i bambini che non sarebbero stati obbligati alla comunione ) Se uno dei componenti della famiglia era fuori per lavoro non era conteggiato dal parroco. In pratica una sorta di censimento religioso annuale
Il libro o registro dei defunti (liber defunctorum) è il registro in cui vengono annotati i nominativi di coloro che sono morti e la loro condizione sacramentale; è doveroso segnalare che in questi volumi, specialmente tra quelli più antichi, sono talvolta indicate anche le cause della morte. L'obbligo della compilazione di questo registro venne ufficialmente introdotta dal Rituale romano di Paolo V (1614), che ne prescrive la tenuta per le chiese in cui si provvede alla sepoltura dei defunti; solitamente vengono annotati il nome del defunto, la data della morte o della sepoltura, l'età, lo stato civile, la causa della morte, il luogo della tumulazione, il conferimento dei sacramenti, in particolare il sacramento dell'estrema unzione, il nome sacerdote che ha conferito i sacramenti o accompagnato il defunto al cimitero. Registri simili ai libri dei morti sono rintracciabili dal XIV secolo ma sono compilati con finalità differenti, in particolare quando previsti dal potere civile. La tenuta di questo registro è introdotta dal Rituale romanum del 1614. Questo tipo di documentazione è piuttosto difforme a seconda dei territori e del periodo in cui sono redatti. Il formulario è fissato dal Rituale, altre norme per la compilazione di questi documenti sono emanate nel corso degli anni da vescovi e cardinali. Sui registri dei morti i parroci annotano il nome del defunto, la data della morte o della sepoltura, l’età, lo stato civile, la causa della morte, il luogo della tumulazione, il conferimento dei sacramenti, in particolare il sacramento dell’estrema unzione, il sacerdote che ha conferito i sacramenti o accompagnato il defunto. Normalmente l'eta' alla morte e' scarsamente affidabile Il libro dei defunti è conservato negli archivi parrocchiali di pertinenza, insieme agli altri libri canonici Nel caso di una parrocchia soppressa o accorpata, la loro conservazione può essere affidata anche all’archivio diocesano, dove spesso si trovano serie documentarie costituite dalle copie dei registri dei sacramenti, tra le quali anche i duplicati dei libri dei defunti, che i parroci sono tenuti a consegnare secondo quanto stabilito da disposizioni vescovili e dal Codice di diritto canonico del 1917, che impone di depositare annualmente in curia vescovile una copia dei libri canonici, eccetto gli stati delle anime. Registri simili ai libri dei morti sono rintracciabili dal XIV secolo ma sono compilati con finalità differenti, in particolare quando previsti dal potere civile. Rispetto ad altri libri parrocchiali, le annotazioni delle sepolture si diffondono tardivamente, solo a partire dalla fine del XVI secolo.
STATUS ANIMARUM
il piu' utile dei registri religiosi , a me pare lo "stato delle anime" il piu' utile perche' e' una sorta di fotografia della famiglia in un dato anno il piu' utile ma anche quello rintracciabile con meno facilita' perche' meno conservato In un qualsiasi luogo il numero delle famiglie ,poi , e' molto minori del numero degli individui Quindi e' piu' semplice trovare la famiglia ,ricavarne la composizione e le eta' dei singoli componenti e quindi ricercarne i dati anagrafici individuali
Status animarum ......................Roma
Status animarum ......................Roma nel settecento
Status animarum ......................Siena, contado
Status animarum ......................Viterbo
Status animarum ......................generico
Status animarum ......................generico
Il registro ecclesiastico denominato “Stato delle anime” o "Status animarum" merita un discorso a parte. Come abbiamo accennato esso divenne obbligatorio solo dopo il "Rituale Romanum" del 1614. Su di esso andavano riportati i dati anagrafici dei parrocchiani, i sacramenti da loro ricevuti, ma anche informazioni relative al mestiere che svolgevano e a ciò che possedevano, in quanto questo registro serviva anche per calcolare la cosiddetta decima, la ‘tassa’ da versare alla chiesa. Anche il registro sullo “Stato delle anime” fornisce importanti informazioni che riguardano le visite pastorali del vescovo nella sua diocesi e circa le situazioni soggettive, economiche e lavorative, dei fedeli e delle loro famiglie.
Gli stati delle anime (status animarum) sono registri che riportano determinati dati anagrafici e religiosi dei parrocchiani, ma anche le professioni da loro svolte e le proprietà possedute, elementi assai utili per determinare l'importo della decima da versare alla Parrocchia; gli stati delle anime possono essere pertanto considerati una sorta di censimento organizzato della popolazione. A differenza del libro dei battesimi e di quello dei matrimoni, la cui compilazione venne istituita e regolamentata a partire dal Concilio di Trento, gli stati delle anime vennero introdotti dalla costituzione Apostolicae sedis di papa Paolo V (1614). Le disposizioni contenute nel documento pontificio prescrivevano al parroco di annotare tutti i componenti dei vari nuclei familiari al fine di verificare la soddisfazione dell'obbligo del precetto pasquale. Questa documentazione era redatta o aggiornata annualmente, di solito in occasione della visita compiuta dal sacerdote nelle case dei parrocchiani per la benedizione pasquale, e pertanto costituisce una fonte importante per studi demografici, sociali, toponomastici ed eventuali ricerche genealogiche. Sul registro sono annotati i fedeli secondo i nuclei o fuochi famigliari, intesi però non come famiglia naturale, cioè composta da individui uniti fra loro da vincoli di parentela, ma come comunità comprensiva di chi si è unito alla famiglia per altre ragioni, solitamente economiche, lavorative o per condivisione dell’abitazione. A partire dal capofamiglia, di ciascun individuo sono generalmente riportati nome e cognome, età, rapporto di parentela che lo lega al nucleo famigliare, condizione rispetto ai sacramenti di cresima, confessione, comunione o eventuale soddisfazione dell’obbligo pasquale. Se la compilazione degli stati delle anime è particolarmente accurata, oltre a fissare la situazione religiosa e sacramentale dei parrocchiani, è possibile rintracciarvi anche altre annotazioni importanti quali le relazioni parentali, come la composizione del nucleo familiare, la condizione lavorativa del capofamiglia, lo stato economico della famiglia, le eventuali attività degli altri componenti della famiglia, la presenza di domestici, i nomi delle vie e delle contrade, la proprietà o meno dell'abitazione. Il libro dello stato delle anime è di grande utilità per le ricerche, dato che non sempre siamo così fortunati da ritrovare tutti i documenti relativi a battesimo, matrimonio, e morte dei nostri antenati. Ogni parroco è tenuto a compilarli già dal 1614. Questa documentazione è redatta o aggiornata annualmente, di solito in occasione della visita compiuta dal sacerdote nelle case dei parrocchiani per la benedizione pasquale. Sul registro sono annotati i fedeli secondo i nuclei o fuochi famigliari, intesi non come famiglia naturale, cioè composta da tutti gli individui uniti da vincoli di parentela, ma come comunità comprensiva di chi si è unito alla famiglia per altre ragioni, solitamente economiche, lavorative o per condivisione dell’abitazione. A partire dal capofamiglia, di ciascun individuo sono riportati, generalmente, nome e cognome, età, rapporto di parentela che lo lega al nucleo famigliare, condizione rispetto ai sacramenti di cresima, confessione, comunione o eventuale soddisfazione dell’obbligo pasquale (indicati semplicemente con le sigle C oppure Ch o Chr, Con o Conf, Com a seconda delle usanze locali, più raramente con altri simboli).. Gli stati delle anime come fonte per la storia. Se la compilazione degli stati delle anime è particolarmente accurata, oltre a fissare la situazione religiosa e sacramentale dei parrocchiani, è possibile rintracciare nei registri altre annotazioni importanti quali le relazioni parentali, la condizione lavorativa del capofamiglia, le eventuali attività degli altri componenti, la presenza di domestici, i nomi delle vie e delle contrade, la proprietà o meno dell'abitazione.. Questa documentazione, dunque, può costituire una fonte importante per studi demografici, sociali, di toponomastica e per ricerche genealogiche..
A differenza del libro dei battesimi e del libro dei matrimoni, la cui tenuta è istituita e regolamentata a partire dal Concilio di Trento, gli stati delle anime sono introdotti dalla costituzione Apostolicae sedi di Paolo V del 1614. Le disposizioni contenute nel documento pontificio prescrivono al parroco di annotare tutti i componenti dei nuclei familiari della parrocchia al fine di verificarne la soddisfazione dell’obbligo del precetto pasquale. Gli stati delle anime sono conservati negli archivi parrocchiali di pertinenza, tra gli altri libri canonici o parrocchiali (insieme al libro dei battesimi, libro dei cresimati, libro dei matrimoni e libro dei defunti).. Nei casi di parrocchie soppresse o accorpate, la loro conservazione può essere affidata all’archivio diocesano di pertinenza..
Nel libro dei cresimati si trovano indicati soltanto il nome e cognome del cresimando e talvolta l'età. Questo sacramento e quindi la relativa registrazione nel libro veniva impartita solitamente ogni cinque anni in occasione della visita pastorale da parte del Vescovo. Nella nostra Parrocchia l'uso di tenere un registro apposito in cui registrare le Cresime si è diffusa soltanto in tempi relativamente recenti. Il primo dei quattro registri esistenti in Archivio venne iniziato nel 1883 da don Gioacchino Cella, arciprete di Pontenure dal 1856 al 1890.
Sarebbe meraviglioso possedere dal 1563 questa immensa mole di dati anagrafici , purtroppo in molti luoghi si arriva alle soglie del xix secolo senza che i parroci abbiamo ancora adempiuto agli obblighi per ignavia o ignoranza E purtroppo alcuni registri ecclesiastici italiani sono stati distrutti in varie guerre in tutta la storia d'Italia. Altri registri sono stati distrutti a causa d'incendi o d'incuria. Alcuni sono andati persi o rubati , e altri ancora sono stati distrutti da insetti, parassiti e umidità. Normalmente i registri canonici sono conservati nelle parrocchie Abbastanza recentemente comprendendo il valore di questo patrimonio documentale e le difficolta' di una corretta ed efficace conservazione si sta tentando di radunare i registri negli archivi diocesani Se i documenti originali della chiesa sono andati persi o distrutti o sono illeggibili, si puo' tentare di trovarne un duplicato negli archivi diocesani. il alcune diocesi vi era abitudine antica che le parrocchie depositassero una copia dei battesimi ( ci si era posto il problema di salvaguardare i documenti chiedendone ai parroci una copia ) La prassi del dupplicato si estende notevolmente gia' dal 1800 Purtroppo non esisteva una pratica standard per mantenere documenti duplicati fino al 1900. I duplicati esistenti sono normalmente conservati presso gli archivi diocesani.
WIKIPEDIA l registri parrocchiali (anche libro parrocchiale) indica un registro, di norma custodito nella chiesa parrocchiale, in cui sono annotati, a cura del parroco, gli avvenimenti correlati alla vita religiosa della parrocchia: battesimi, cresime, matrimoni e funerali. A questi quattro libri se ne aggiunge un quinto, lo Status Animarum, in cui, in particolari occasioni (in genere durante le benedizioni pasquali), viene annotato un censimento o una descrizione generale dello stato delle anime della parrocchia. I registri parrocchiali vanno dunque a costituire un patrimonio storico e sociologico ineguagliabile, punto di riferimento di una completa ed accurata ricerca genealogica. Le annotazioni sui registri devono obbedire alle precise formalità definite dal rito romano nel 1614 : ogni documento pubblico deve riportare il luogo, la data e la natura dell'atto iscritto, il nome dell'officiante, il nome della parti interessate, quello dei testimoni presenzianti e deve essere sottoscritto dall'ufficiale. La Chiesa cattolica prescrive che nei suoi registri le persone vengano designate non con il solo nome ma anche con l'indicazione della parentela e della parrocchia di appartenenza. Queste informazioni ne accrescono l'utilità nelle ricerche documentariI registri parrocchiali rappresentano un'importantissima fonte di informazioni, soprattutto per la demografia e per ricerca genealogica, ossia per la ricostruzione delle origini di una persona o di una famiglia. Infatti, di regola, ogni annotazione di battesimo riporta i nomi dei genitori (a volte tuttavia con il cognome del solo padre) e in tal modo è possibile, da una parte, identificare univocamente la linea genealogica, dall'altra, risalire indietro negli anni ricercando, a propria volta, gli atti relativi a tali genitori. L'informazione aggiuntiva della parrocchia di provenienza, inoltre, permette di continuare la ricerca a ritroso sui registri di quest'ultima parrocchia. Le annotazioni riportano anche nomi di testimoni o di madrine e padrini, che possono essere utili per identificare meglio i personaggi ricercati. Nella ricerca genealogica, infatti, è forte il rischio di omonimie in quanto, sull'onda della Controriforma, andarono gradualmente scomparendo molti nomi "particolari" (per esempio benauguranti) a favore dei nomi di santi riconosciuti. Si ebbe, in sostanza, una rarefazione dei nomi usati e quindi più frequenti omonimie, fonte di maggior rischio di confusione per il ricercatore. Un aiuto - o da altro punto di vista - un ulteriore elemento di incertezza è dato dalla diffusione dell'uso di dare ai nipoti, non solo primogeniti, il nome dei nonni. In famiglie numerose, come avveniva di regola in passato, questo porta a difficoltà crescenti per la ricerca. Utilissime per la ricerca sono anche le annotazioni a margine effettuate dal parroco, che si rivelano preziose fonti di informazione per la conoscenza di fatti accaduti alla comunità, come eventi sismici e meteorologici, o per l'individuazione di registrazioni e notizie (battesimo, matrimonio, parentele, ecc.) riferibili a un soggetto già noto per altre vie. Anche lo Stato delle anime fornisce importanti informazioni sulle visite pastorali del vescovo nella sua diocesi e sulle situazioni soggettive (economiche e lavorative) delle persone e delle loro famiglie (si veda alla voce Status Animarum: valore storico e documentario). Il valore storico di questa documentazione si riduce, ovviamente, man mano che si esce dalla ricerca individuale delle origini di famiglia e ci si addentra nelle vicende generali di un territorio o di una popolazione: se ne potranno trarre comunque elementi demografici, onomastici, toponomastici e perfino - specialmente nel caso di note in italiano - lessicali o linguistici.
BY sito Enrico Giustiniani
Poi ci si affida ai nominati registri anagrafici parrocchiali: libri dei battesimi, dei matrimoni, dei defunti, elenco dei cresimati, stati delle anime. Come è intuibile, detti registri sono manoscritti in latino, ma si tratta di un latino volgare assai comprensibile. La presenza della Chiesa e il profondo legame delle sue istituzioni con il territorio permeano l'intera storia italiana: gli archivi ecclesiastici sono depositari di un patrimonio documentario di immenso valore, il cui studio contribuisce alla ricostruzione di larghissima parte della storia italiana. In questi libri si trovano notizie molto importanti: Libri dei battesimi (Liber baptizatorum), che registrano i battezzati, con la data del battesimo (che nella maggior parte dei casi coincideva col giorno della nascita oppure con il giorno seguente), il nome dei genitori, il nome dei padrini di battesimo, del sacerdote che amministrò il sacramento e ovviamente il prenome o i prenomi imposti al neonato. In caso di battesimo eseguito in circostanze di grave pericolo di morte del nascituro o della puerpera, da persona cognita (per esempio dalla levatrice), talvolta ancora prima dall'uscita dall'utero materno, ne è fatta menzione. La cerimonia battesimale veniva poi effettuata dopo qualche tempo in chiesa, per dare il crisma ufficiale. Anche i figli nati da nubili o vedove venivano menzionati come tali e spesso era specificato anche il nome del padre, con la menzione "ex illicito coitu", "ex damnato thoro", ecc. - come confessato dalla partoriente alla levatrice. Nel Medioevo i cosiddetti figli naturali erano una cosa normale: il padre dava il suo cognome o patronimico al neonato. Con l'avvento della Riforma e della Controriforma si strinsero i rubinetti relativi alla libertà sessuale. Le nascite al di fuori del matrimonio furono considerate un'infamia e di conseguenza si agì. E così ci furono i figli illegittimi, davanti alle porte di qualche casa o di quegli istituti che accoglievano i trovatelli e aumentarono gli aborti e perfino gli infanticidi. Libri dei matrimoni (Liber matrirnoniorum): vi sono indicati gli sposi, molto spesso con l'indicazione dei loro genitori, i testimoni al matrimonio, il sacerdote officiante e le pubblicazioni fatte in chiesa, nonché gli impedimenti di consanguineità e di affinità secondo il Codice di diritto canonico e le eventuali dispense rilasciate dal Vicario, dal Vescovo, dal Nunzio apostolico o anche dal Vaticano. Non si dimentichi che detto Codice di diritto canonico esigeva la dispensa fino al 5' grado di consanguineità e pure per la cosiddetta parentela spirituale (per esempio tra padrino e figlioccia, tra fratellastro e sorellastra). Nei nostri archivi parrocchiali le dispense matrimoniali sono moltissime e, nella maggior parte dei casi, la motivazione è "ob angustiam loci" (per la ristrettezza del luogo) il che è poi un modo elegante per suggellare matrimoni di convenienza (che erano la maggioranza). Si riusciva ad ottenere mediante questi matrimoni ciò che ora si ottiene con il raggruppamento fondiario. Sia nei libri dei battesimi, sia in quelli dei matrimoni, tra i padrini e le madrine di battesimo e tra i testimoni di nozze si trovano spesso persone emigrate che si fanno rappresentare alla cerimonia da parenti. Le registrazioni dei battesimi da parte delle singole parrocchie sono generalmente le prime fonti ecclesiastiche a comparire, già prima che il Concilio di Trento nel 1563 le rendesse obbligatorie. La loro funzione, dapprima solamente religiosa, divenne a poco a poco più rilevante anche sotto il profilo civile, visto che la competenza anagrafica fu riservata fino all'800 in maniera quasi esclusiva alle autorità ecclesiastiche. Negli stati italiani preunitari non esisteva una regolamentazione uniforme: ci sono casi - per esempio le città di Reggio Emilia e Modena - in cui l'autorità civile si occupò delle registrazioni anagrafiche fin dal primo '500; bisogna tuttavia arrivare fino all'epoca napoleonica per assistere al sorgere dell'ufficio preposto allo "stato civile". Con l'avvento della Restaurazione si verificò ancora la frammentazione e la diversificazione delle norme e della tenuta delle registrazioni anagrafiche nei diversi stati italiani, ma dopo l'unità d'Italia - nel 1865 - vennero istituiti e regolamentati gli uffici di stato civile presso i Comuni. Con l'unità d'Italia lo stato incaricò quindi i comuni della tenuta e della conservazione degli atti anagrafici: tuttavia, viste le particolari modalità con cui si completò il processo di unificazione, in alcune zone delle Venezie le registrazioni parrocchiali sono ancora l'unica fonte anagrafica disponibile per il periodo che va dal 1870 al 1924. Gli atti parrocchiali hanno quindi immediata efficacia giuridica (completi delle necessarie autenticazioni da parte della Cancelleria Diocesana) se anteriori a quanto disposto dal Regio Decreto del 15 novembre 1865, n. 2062, sull'ordinamento dello Stato Civile dei Comuni. Gli Archivi Diocesani conservano documentazione altrettanto importante per la ricostruzione delle storie locali. Particolarmente interessanti sono i documenti sulle visite pastorali compiute dal Vescovo almeno ogni 5 anni, in cui si trovano descrizioni degli arredi e del patrimonio parrocchiale, informazioni sulle cappellanie e sulle confraternite attive nella parrocchia, l'elenco dei "benefici" parrocchiali, dei lasciti alla chiesa (in beni o in messe), dello jus patronati ed altro. Questi sono i principali Libri parrocchiali: Libri dei defunti (Liber mortuorum): vi sono elencati i decessi, in parecchi casi con l'indicazione dell'età del defunto (annorum quinquaginta circumeirca), se è molto ricevendo tutti i sacramenti previsti della Chiesa, dove e quando è stato seppellito, eventuali suoi titoli in vita, la sua attività e, talvolta, la causa della morte (caduto da un dirupo mentre andava a caccia, caduto da un castagno mentre stava bacchiando l'albero, morto annegato nel fiume, barbaramente ucciso dai soldati francesi, ecc.). Per i defunti all'estero ci sono spesso le registrazioni nei libri dei morti del villaggio, ma solo quando i parenti facevano fare le esequie in loco (pagando) oppure quando la notizia giungeva al parroco per iscritto. In moltissimi altri casi i morti all'estero non figurano menzionati nel Liber mortuorum. Elenco dei cresimati (Nomina confirmatorum): quando il Vescovo veniva per la visita pastorale (magari a 25 anni di distanza dalla precedente) venivano cresimati tutti quelli che non lo furono prima. E qui si trovano dei cresimati che vanno dall'età di un anno fino ai 70 anni. Queste Nomina confirmatorum ci servono per riassumere quanti erano ancora in vita dei battezzati, poiché spesso i neonati morti duranti il parto o qualche giorno dopo non venivano registrati oppure lo furono in modo non chiaramente intelligibile (a dipendenza del prete o frate che fece l'iscrizione). Gli stati delle anime (Stalus animarum): era questo un censimento fatto dai parroci in determinate occasioni, magari in coincidenza con la visita pastorale, in cui si indica- vano tutti i fedeli del villaggio, a famiglia per famiglia, con la loro età. Erano menzionati quanti erano stati ammessi al sacramento dell'Eucaristia, quanti a quello della Cresima, ecc. Era una statistica a scopo religioso che oggi ci serve anche come documento demografico. In molti comuni ce ne sono parecchi di questi "Status animarum", in altri nessuno. I registri precedentemente citati devono essere la base di partenza che sarà completata da altri manoscritti di archivio. Negli archivi pubblici, ma specialmente in quelli parrocchiali, sono conservati moltissimi testamenti. Ciò è cosa molto importante per la ricostruzione. Lo stesso dicasi per gli archivi privati. Nel libri mastri familiari e nei quinternetti si trovano non solo notizie sul dare e sull'avere di ogni capofamiglia, bensì anche notizie familiari. Il capofamiglia scriveva i suoi crediti e i suoi debiti in questi libri, ma poi in qualche pagina annotava anche gli avvenimenti importanti della famiglia: le nascite, i matrimoni, i decessi, con parecchi dettagli. Nel grande mosaico delle fonti archivistiche si possono reperire e completare le notizie raccolte nei documenti citati precedentemente. Norme sugli archivi ecclesiastici: La conservazione dei documenti di importanza vitale per la parrocchia ha inizio già dal Medioevo, ma è soprattutto con la costituzione apostolica Maxima vigilantia, emanata da papa Benedetto XIII nel 1727, che viene sancito l'interesse e la cura per gli archivi ecclesiastici, compresa la custodia dei libri dei battezzati, dei confermati (cresimati), dei matrimoni, dei morti, gli status animarum e il registro delle riscossioni delle decime annuali. Il Nuovo Codice di Diritto Canonico, promulgato nel 1983 da Giovanni Paolo II, prevede esplicitamente l'esistenza di un "Archivio Storico" in ciascuna Diocesi e fornisce disposizioni per la cura, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio documentario: tuttavia non tutti gli archivi diocesani hanno la possibilità di ospitare gli archivi parrocchiali, che spesso sono ancora conservati presso le singole parrocchie. Attualmente: gli archivi ecclesiastici sono archivi privati, "speciali" in quanto sottoposti ad un regime concordatario con l'amministrazione statale italiana, ma non assimilabili assolutamente agli archivi degli enti pubblici o statali (archivi di stato, archivi dei comuni, ecc.). Fare ricerche negli archivi parrocchiali Tutte le precauzioni sulla precisione e sull'esattezza dei dati di partenza - valide per le ricerche in qualsiasi archivio - sono accentuate dalla difficoltà per il personale della Curia (e ancora di più per il singolo parroco) di fornire supporto alle ricerche. La ricerca in archivio "per conto terzi" si configura come un'attività straordinaria e spesso proibitiva: bisogna quindi assicurarsi non solo che l'archivio parrocchiale sia ancora esistente, ma che sia consultabile, e tenere conto e rispettare la disponibilità fornita dal parroco o dai responsabili dell'archivio diocesano. Consigli pratici La maggior parte dei documenti ecclesiastici - almeno fino alla metà del 1800 - sono redatti in latino, sulla base di un formulario abbastanza consolidato, e con il ricorso frequente ad abbreviazioni di tipo paleografico, che possono essere sciolte con un po' di pazienza e tramite il confronto tra i diversi atti. L'Associazione Archivistica Ecclesiastica sta da tempo portando avanti la "Guida degli Archivi Diocesani d'Italia", strumento molto utile per individuare la Diocesi di competenza della propria parrocchia ed avere un primo riscontro sull'esistenza della documentazione necessaria. E' sempre opportuno avvisare la Curia Diocesana della necessità di consultazione degli archivi parrocchiali, richiedendo - quando possibile - un nulla osta alla ricerca presso il Vicariato Generale. Per la presentazione di atti ecclesiastici come documentazione ai fini del riconoscimento della cittadinanza italiana gli atti devono essere autenticati dal parroco, dal Cancelliere Diocesano, e - in alcuni casi - dalla Procura della Repubblica del capoluogo di Provincia. Un grande lavoro di raccolta di dati anagrafici - per la maggior parte desunti da archivi parrocchiali, è stato fatto dagli appartenenti alla Chiesa dei Santi degli Ultimi Giorni. BY sito Enrico Giustiniani
|
Registro dei battesimi
Il libro dei battesimi (liber baptizatorum) è il registro in cui i parroci annotano i nominativi di coloro che hanno ricevuto il sacramento del battesimo. Ogni parroco è tenuto a compilarlo e a conservarlo a partire dalle disposizioni contenute nel decreto istitutivo del Concilio di Trento.
Istruzioni relative ai formulari da utilizzare nella compilazione dei dati sono fornite dal Rituale romano del 1583, successivamente riprese in quello del 1614.
Secondo le indicazioni stabilite dalla normativa, sui registri dei battesimi i parroci hanno il compito di annotare il nome del battezzato, paternità e maternità, la data del battesimo, il nome del celebrante, i nominativi di padrini e madrine. Vengono aggiunte delle precisazioni in caso di illegittimi, esposti, di battezzati sub conditione o di celebrante differente dal parroco.
In base a istruzioni successive e all’accuratezza della compilazione dei parroci, i registri dei battesimi possono riportare informazioni più complete che comprendono, per esempio, anche luogo e data di nascita del battezzato e nome dell’ostetrica.
Il Codice di diritto canonico del 1983 prevede che nel libro dei battezzati sia annotato successivamente anche la confermazione e tutto ciò che riguarda lo stato canonico dei fedeli, in rapporto al matrimonio, all'adozione, all'ordine sacro, alla professione perpetua emessa in un istituto religioso e al cambiamento del rito.
Il libro dei battesimi come fonte per la storia
Grazie alle informazioni raccolte insieme alle note relative al sacramento, i Libri dei battesimi sono utili non solo per la conoscenza della situazione religiosa e sacramentale di una parrocchia, ma anche come fonte fondamentale per studi demografici, sociali, giuridici, di onomastica e per ricerche genealogiche.
Dove cercare
Il libro dei battesimi è una tipologia documentaria conservata negli archivi parrocchiali di pertinenza, insieme agli altri libri canonici o parrocchiali (libro dei cresimati, libro dei matrimoni, libro dei defunti e agli stati delle anime). Nel caso di una parrocchia soppressa o accorpata, la loro conservazione può essere affidata anche all’archivio diocesano, dove spesso si trovano serie documentarie costituite dalle copie dei registri dei sacramenti, tra le quali anche i duplicati dei libri dei battesimi, che i parroci sono tenuti a consegnare secondo quanto stabilito da disposizioni vescovili e dal Codice di diritto canonico del 1917, che impone di depositare annualmente in curia vescovile una copia dei libri canonici, eccetto gli stati delle anime.
STORIA
L’origine della tenuta di registrazioni relative all’amministrazione del sacramento del battesimo è piuttosto antica. Pur non essendo una prassi generalizzata, esempi di registri di questo tipo sono attestati in Italia già nel XIV e XV secolo. I dati vengono raccolti con finalità differenti rispetto a quelle attuali, per esempio con valore dimostrativo per l’accesso a cariche pubbliche, per garantire la legittimità di una nascita o la cittadinanza di un individuo. Per questo motivo, le registrazioni più antiche possono riportare informazioni relative al battezzato differenti rispetto alle disposizioni tridentine.
A partire dal XVI secolo si nota una maggiore attenzione pastorale nella raccolta dei dati.
La produzione dei libri dei battesimi diviene significativa dopo il Concilio di Trento che ne fissa anche modalità di compilazione. La riforma tridentina tratta di questo sacramento nel contesto di quello del matrimonio. La registrazione di padrini e madrine, infatti, permette di verificare ed escludere una cognatio spiritualis, legame che si instaura tra padrino e battezzato, motivo di impedimento per un matrimonio.
Ulteriori indicazioni circa i dati da raccogliere nel Libro dei battesimi sono fornite da Gregorio XIII nel Rituale romanum e nel Rituale di Paolo V.
BIBLIOGRAFIA
G. Badini, Archivi e Chiesa. Lineamenti di archivistica ecclesiastica e religiosa, Bologna, Patron, 2005.
Chiesa cattolica, Codice di diritto canonico. Testo ufficiale e versione italiana. Sotto il patrocinio della Pontificia Università Lateranense e della Pontificia Università Salesiana, Roma, Unione Editori Cattolici Italiani 1983.
A. Gallo, Libri parrocchiali in Enciclopedia cattolica, Città del Vaticano, Ente per l’enciclopedia cattolica e per il libro cattolico, 1949.
A. Turchini, Archivi della Chiesa e archivistica, Brescia, La Scuola, 2011
Registro dei battesimi
Il libro dei battesimi (liber baptizatorum) è il registro in cui i parroci annotano i nominativi di coloro che hanno ricevuto il sacramento del battesimo. Ogni parroco è tenuto a compilarlo e a conservarlo a partire dalle disposizioni contenute nel decreto istitutivo del Concilio di Trento.
Istruzioni relative ai formulari da utilizzare nella compilazione dei dati sono fornite dal Rituale romano del 1583, successivamente riprese in quello del 1614.
Secondo le indicazioni stabilite dalla normativa, sui registri dei battesimi i parroci hanno il compito di annotare il nome del battezzato, paternità e maternità, la data del battesimo, il nome del celebrante, i nominativi di padrini e madrine. Vengono aggiunte delle precisazioni in caso di illegittimi, esposti, di battezzati sub conditione o di celebrante differente dal parroco.
In base a istruzioni successive e all’accuratezza della compilazione dei parroci, i registri dei battesimi possono riportare informazioni più complete che comprendono, per esempio, anche luogo e data di nascita del battezzato e nome dell’ostetrica.
Il Codice di diritto canonico del 1983 prevede che nel libro dei battezzati sia annotato successivamente anche la confermazione e tutto ciò che riguarda lo stato canonico dei fedeli, in rapporto al matrimonio, all'adozione, all'ordine sacro, alla professione perpetua emessa in un istituto religioso e al cambiamento del rito.
Il libro dei battesimi come fonte per la storia
Grazie alle informazioni raccolte insieme alle note relative al sacramento, i Libri dei battesimi sono utili non solo per la conoscenza della situazione religiosa e sacramentale di una parrocchia, ma anche come fonte fondamentale per studi demografici, sociali, giuridici, di onomastica e per ricerche genealogiche.
Dove cercare
Il libro dei battesimi è una tipologia documentaria conservata negli archivi parrocchiali di pertinenza, insieme agli altri libri canonici o parrocchiali (libro dei cresimati, libro dei matrimoni, libro dei defunti e agli stati delle anime). Nel caso di una parrocchia soppressa o accorpata, la loro conservazione può essere affidata anche all’archivio diocesano, dove spesso si trovano serie documentarie costituite dalle copie dei registri dei sacramenti, tra le quali anche i duplicati dei libri dei battesimi, che i parroci sono tenuti a consegnare secondo quanto stabilito da disposizioni vescovili e dal Codice di diritto canonico del 1917, che impone di depositare annualmente in curia vescovile una copia dei libri canonici, eccetto gli stati delle anime.
STORIA
L’origine della tenuta di registrazioni relative all’amministrazione del sacramento del battesimo è piuttosto antica. Pur non essendo una prassi generalizzata, esempi di registri di questo tipo sono attestati in Italia già nel XIV e XV secolo. I dati vengono raccolti con finalità differenti rispetto a quelle attuali, per esempio con valore dimostrativo per l’accesso a cariche pubbliche, per garantire la legittimità di una nascita o la cittadinanza di un individuo. Per questo motivo, le registrazioni più antiche possono riportare informazioni relative al battezzato differenti rispetto alle disposizioni tridentine.
A partire dal XVI secolo si nota una maggiore attenzione pastorale nella raccolta dei dati.
La produzione dei libri dei battesimi diviene significativa dopo il Concilio di Trento che ne fissa anche modalità di compilazione. La riforma tridentina tratta di questo sacramento nel contesto di quello del matrimonio. La registrazione di padrini e madrine, infatti, permette di verificare ed escludere una cognatio spiritualis, legame che si instaura tra padrino e battezzato, motivo di impedimento per un matrimonio.
Ulteriori indicazioni circa i dati da raccogliere nel Libro dei battesimi sono fornite da Gregorio XIII nel Rituale romanum e nel Rituale di Paolo V.
BIBLIOGRAFIA
G. Badini, Archivi e Chiesa. Lineamenti di archivistica ecclesiastica e religiosa, Bologna, Patron, 2005.
Chiesa cattolica, Codice di diritto canonico. Testo ufficiale e versione italiana. Sotto il patrocinio della Pontificia Università Lateranense e della Pontificia Università Salesiana, Roma, Unione Editori Cattolici Italiani 1983.
A. Gallo, Libri parrocchiali in Enciclopedia cattolica, Città del Vaticano, Ente per l’enciclopedia cattolica e per il libro cattolico, 1949.
A. Turchini, Archivi della Chiesa e archivistica, Brescia, La Scuola, 2011 (Saggi; 15. Storia).
DOVE CERCARE
Archivio diocesano
Archivio parrocchiale
CHI HA PRODOTTO LA DOCUMENTAZIONE
Parrocchia
LE RICERCHE
Ricerche biografiche e agiografiche
Ricerche demografiche
Ricerche genealogiche
Persone e famiglie
Storia del pensiero e del costume
Registro dei matrimoni
Il libro dei matrimoni (liber matrimoniorum) è il registro in cui i parroci annotano i nominativi di coloro che sono stati uniti in matrimonio al fine di registrare l’avvenuta amministrazione del sacramento.
Ogni parroco è tenuto a compilarlo e a conservarlo a partire dalle disposizioni contenute nel decreto istitutivo del Concilio di Trento.
I dati riportati sui registri dei matrimoni variano, e sono più o meno dettagliati, a seconda della formula utilizzata dai parroci per annotare il sacramento, ma anche in base al contesto in cui viene celebrato il matrimonio (in caso di omissione delle pubblicazioni per dispensa vescovile, di celebrazione su licenza se il ministro non è il parroco o se gli sposi provengono da altra parrocchia o diocesi, in caso di dispensa per consanguineità, etc.).
Nel libro dei matrimoni sono indicati, più comunemente, la data della cerimonia del matrimonio e delle tre pubblicazioni canoniche o l’indicazione della dispensa vescovile che ne ha permesso la riduzione a un numero inferiore, il nome e il titolo del celebrante (archipresbiter, presbiter, rector), il nome degli sposi, loro paternità e maternità, parrocchia o luogo d’origine, il nominativo dei testimoni con loro paternità.
In alcuni casi i registri dei matrimoni possono riportare anche informazioni più dettagliate riguardo agli sposi come l’età, la professione, l’alfabetizzazione.
Il libro dei matrimoni come fonte per la storia
Grazie alle informazioni raccolte insieme alle annotazioni attinenti al sacramento, i libri dei matrimoni sono utili non solo per la conoscenza della situazione religiosa e sacramentale di una parrocchia, ma anche come fonte fondamentale per studi antropologici, demografici, sociali, giuridici, di onomastica e per ricerche genealogiche.
Documentazione correlata
Accanto ai libri dei matrimoni, che registrano l’atto finale del sacramento amministrato agli sposi, negli archivi parrocchiali sono spesso conservati i documenti preparatori raccolti nel periodo che precede la celebrazione del rito, riuniti in una serie archivistica denominata processetti matrimoniali o pubblicazioni matrimoniali. Nei processetti matrimoniali si possono conservare: il certificato di battesimo e cresima degli sposi, il certificato di morte in caso di vedovanza di uno dei contraenti, eventuali dispense vescovili rilasciate per ridurre il numero delle pubblicazioni o per ovviare ad impedimenti canonici quali la parentela fino al quarto grado di consanguineità per i futuri coniugi.
Dove cercare
Il libro dei matrimoni è conservato negli archivi parrocchiali di pertinenza, tra gli altri libri canonici (insieme al libro dei battesimi, libro dei cresimati, libro dei defunti e agli stati delle anime).
Nel caso di una parrocchia soppressa o accorpata, la loro conservazione può essere affidata all’archivio diocesano, dove spesso si trovano serie documentarie costituite dalle copie dei registri dei sacramenti, tra le quali anche i duplicati dei libri dei matrimoni, che i parroci sono tenuti a consegnare secondo quanto stabilito da disposizioni vescovili e dal Codice di diritto canonico del 1917, che impone di depositare annualmente in curia vescovile una copia dei libri canonici, eccetto gli stati delle anime.
STORIA
L’origine della tenuta di registrazioni relative all’amministrazione del sacramento del matrimonio è piuttosto antica. Pur non essendo una prassi generalizzata, esempi di registri di questo tipo sono attestati in Italia già nel XIV e XV secolo. I dati vengono raccolti con finalità differenti rispetto a quelle attuali, per esempio con valore dimostrativo per l’accesso a cariche pubbliche o ancora per garantire la legittimità di una nascita o la cittadinanza di un individuo. Per questo motivo, le registrazioni più antiche possono riportare informazioni relative agli sposi differenti rispetto alle indicazioni tridentine.
La produzione dei libri dei matrimoni diviene significativa dopo il Concilio di Trento poiché si inserisce tra i provvedimenti legati a questo sacramento, tesi a rafforzare le strutture famigliari al fine di impedire l’endogamia.
La compilazione dei registri dei matrimoni viene recepita più lentamente rispetto alla tenuta di altri libri parrocchiali.
Il Concordato del 1929 tra Stato e Chiesa riconosce gli effetti civili del matrimonio canonico e, di conseguenza, anche dei documenti ecclesiastici prodotti nell’ambito del sacramento.
BIBLIOGRAFIA
G. Badini, Archivi e Chiesa. Lineamenti di archivistica ecclesiastica e religiosa, Bologna, Patron, 2005.
Codice di diritto canonico. Testo ufficiale e versione italiana. Sotto il patrocinio della Pontificia Università Lateranense e della Pontificia Università Salesiana, Roma, Unione Editori Cattolici Italiani, 1983.
A. Gallo, Libri parrocchiali in Enciclopedia cattolica, Città del Vaticano, Ente per l’enciclopedia cattolica e per il libro cattolico, 1949.
A. Turchini, Archivi della Chiesa e archivistica, Brescia, La Scuola, 2011 (Saggi; 15. Storia).
DOVE CERCARE
Archivio diocesano
Archivio parrocchiale
CHI HA PRODOTTO LA DOCUMENTAZIONE
Parrocchia
LE RICERCHE
Ricerche biografiche e agiografiche
Ricerche demografiche
Ricerche genealogiche
Persone e famiglie
Storia del pensiero e del costume
Con questo nome si indicavano i fascicoli allegati agli atti di matrimonio, che contenevano le certificazioni necessarie, ad iniziare dalle pubblicazioni, per poter redigere l'atto di matrimonio.
Per coloro che si occupano di genealogie i processetti rappresentano un "tesoretto" documentale, in quanto si tratta di trascrizioni di atti di battesimo e di morte, quasi sempre in latino, attraverso i quali si può ricostruire la storia di una generazione, comprese alcune notizie che non si potrebbero reperire in altro modo.
Già il solo atto di matrimonio è il documento principale che fornisce al genealogista ascendenze e discendenze familiari, in quanto contiene, oltre ovviamente ai nomi degli sposi, quelli dei rispettivi genitori, con le annotazioni se sono vivi o defunti, presenti o non presenti all'atto, consenzienti o meno. Mi riferisco, come avrete capito, agli atti di matrimonio più antichi, in quanto oggi molte di queste formalità non sono più richieste.
Non voglio dilungarmi oltre, per non togliervi quella curiosità che potreste avere nello scoprire che cosa di fatto si può trovare all'interno di questi processetti, e per farlo prenderò in esame un matrimonio, avvenuto nel lontano 1809, quando per la prima volta, a seguito delle leggi napoleoniche, fu istituito l'ufficio dello stato civile comunale con l'anagrafe. Il matrimonio riguarda un mulattiere, Arcangelo Zaccari, e una giovane di nome Serafina Maddalena Santanna,
i quali per prima cosa fecero formale richiesta di rendere pubblica la loro volontà di sposarsi. A chi? al cancelliere presso il Sindaco del Comune di Sammarco nel quartiere Piazza [di basso], notaro Domenico Arcuri. Questi annota sull'atto che il tre dicembre 1809, domenica, alle ore quindici, annuncia e pubblica, per la prima volta la parola di matrimonio di Arcangelo Zaccari, di anni diciannove, molettiere, domiciliato nel Comune e abitante nel quartiere del Crité, figlio del quondam Xaverio, morto di anni quarantacinque, e di Saveria Spinelli, vivente e presente, di anni cinquanta, e di Maddalena Santanna, la promessa sposa, di anni diciotto, qui domiciliata anche nel quartiere del Crité, figlia delli furono coniugi Carmine e Dorotea Nico.
La pubblicazione letta ad alta voce è affissa nel luogo predetto. Il documento seguente è l'atto di matrimonio celebrato il 15 dicembre 1809 nel quartiere del Critè, registrato con il numero 12, in cui sono scritte le formule di rito, "non avendo trovato opposizione, annuendo alla loro richiesta, avendo loro letto il presente atto e il capitolo del codice civile, accertata la lodo decisione, li dichiara uniti in matrimonio, alla presenza dei testimoni Domenico Cristofalo di anni 26 e Gennaro Santoro di anni 25". L'atto si conclude con segno di croce degli sposi, analfabeti, e le firme dei testimoni e del sindaco Vincenzo Fera.
Già da questi due atti abbiamo un quadro della genealogia degli sposi, limitato ovviamente ai soli genitori, ma chi volesse saperne di più deve sperare in qualche altra notizia contentenuta nei documenti allegati, e in caso non la trovasse deve mettersi alla ricerca del matrimonio dei genitori degli sposi, che essendo antecedente al 1809, è reperibile nei registri parrocchiali conservati presso l'archivio diocesano, purtroppo non tutti, perché molti di loro andarono distrutti per motivi diversi (rivolte, sottrazioni, incendi ecc.).
Nel caso nostro, però, ho trovato nel "processetto" alcuni interessanti documenti che corredano la storia familiare. Vediamo di che cosa si tratta. Subito dopo la copia dell'atto di matrimonio è allegata una dichiarazione del canonico Giuseppe Mazzei e del curato Michele Perrotta che
"avendo perquisito il libro dei morti della Comune hanno trovato la seguente particola: Anno Dni milles° septigententes° nonages° octavo 1798 die undecima 11 mensis Julii S.Marci C. Carmelus Santanna a Castrofranco accola* huijus Civ e ac viduus qdm Magadalena Pepe a S.Lauro, globulis plumbeis percussus, morte praematura vitam finivit in Territorio hujus Cive ... "
Grazie a questo documento sappiamo che Carmine Santanna, padre della sposa, morì prematuramente perché "colpito da pallettoni"!
Potrei continuare, citando gli altri documenti e il loro contenuto, ma mi fermo qui, per farvi rendere conto come tra le varie carte possiamo trovare testimonianze che non troveremmo in nessun'altra parte.
Per darvi un'idea del lavoro che ho potuto svolgere grazie a queste ricerche, vi basti pensare che ho ricostruito la storia di oltre cinquecento famiglie di San Marco, e chi volesse verificare quanto i documenti esaminati siano stati utili può visitare le pagine con le varie genealogie familiari ad iniziare dal cognome Zaccaro.
San Marco Argentano, 3 ottobre 2022
Paolo Chiaselotti
* Castrofranco accola, abitante nella campagna di Castrofranco (o Castelfranco, oggi Castrolibero). Incola chi abitava nel borgo
la documentazione che i nubendi presentavano alla Curia vescovile per la celebrazione del matrimonio. I fascicoli più antichi, risalenti alla prima metà del secolo XVI, contengono oltre all'attestazione del parroco delle tre «canoniche pubblicazioni inter solemnia missarum», alle fedi di battesimo, cresima e stato libero, anche le dichiarazioni rese dai testimoni sulla conoscenza della famiglia e dei futuri sposi. Nella serie sono anche presenti i fascicoli relativi alla licenza per la celebrazione del matrimonio in casa e quelli relativi allo stato libero degli sposi che provenivano da altre parrocchie. Nella documentazione più recente (secolo XX) si trova allegato il «giuramento suppletorio», firmato dallo sposo e da due testimoni, relativo allo stato libero mantenuto durante il periodo di assenza per il servizio militare. In caso di matrimonio tra parenti, nei processetti sono presenti anche gli atti relativi alla dispensa da impedimento al matrimonio per grado di affinità o consanguineità fino al quarto grado, contenenti spesso l'albero genealogico della famiglia. In coda alla serie è stato raggruppato il carteggio relativo agli impedimenti matrimoniali, che consta di 108 fascicoli, cioè sia la corrispondenza con il vescovo sia le cause istruite dalla curia vescovile a seguito delle istanze prodotte da chi era intenzionato, per varie motivazioni, ad impedire la celebrazione del matrimonio. (A. Caprio)
Non è possibile che non risultino i nomi dei testimoni... è obbligatorio segnarli dai tempi del Concilio di Trento, come già detto.
Il "processetto matrimoniale" deve essere conservato nell'Archivio Diocesano... ma non se ne può prendere visione senza un giustificato motivo... però spesso i testimoni della promessa di matrimonio non coincidono con quelli del matrimonio.
Giusto... è il registro che si firma alla fine della cerimonia... spesso viene, però, creato anche un "elenco" dei matrimoni che viene usato per ricerche veloci, è quello a cui si fà riferimento nella risposta precedente.
I registri "bastardelli" sono tutt'altra cosa... sono dei registri riservati che possono essere consultati solo con l'autorizzazione dell'autorità ecclesiastica competente e riguardano solo i matrimoni segreti e di coscienza, sono stati aboliti da moltissimi anni.
Il controllo dello stato libero dei futuri sposi ha costituito una preoccupazione essenziale della Chiesa cattolica nella difesa dell’unicità e indissolubilità del sacramento del matrimonio. Per evitare casi di bigamia e matrimoni clandestini, il Concilio di Trento prescrisse degli obblighi (pubblicazione, presenza del sacerdote e dei testimoni alle nozze, registrazione) che furono localmente integrati da una vera e propria inchiesta (processetto). Questa era basata sull’esame di testimoni chiamati ad attestare che i futuri sposi non avessero contratto in precedenza un vincolo matrimoniale, o perché celibi o perché vedovi. Raccogliendo testimonianze sul passato dei richiedenti che non erano nativi o che nel corso del tempo si erano allontanati dalla città, le indagini miravano a rispondere alla sfida che la mobilità geografica poneva al rispetto della disciplina matrimoniale. I processetti, che si basavano su procedure burocratiche e sulla produzione di prove, raccolte spesso a partire da diversi contesti geografici e giurisdizionali, testimoniano anche la necessità per la Chiesa di fare affidamento sulla parola di coloro che conoscevano i richiedenti.
Questo colloquio sarà composto da due sessioni. Dopo una giornata di studio tenutasi ad Atene (10-11 settembre 2021), dedicata al controllo prematrimoniale da parte della Chiesa ortodossa e a casi di matrimoni misti nell’Europa orientale (XVI-XVIII secolo), la prima sessione del convegno sarà dedicata allo studio dell’adozione e della diffusione di queste indagini matrimoniali nel mondo cattolico, privilegiando l’Italia e allargando il confronto ad altre aree (Austria, Francia, Brasile). Questa sessione ruoterà intorno ad alcune linee di riflessione : il meccanismo istituzionale e la procedura, la strutturazione del processetto, i fondi archivistici conservati in vari archivi diocesani.
La seconda sessione del convegno mira a presentare l’indagine condotta sui processetti veneziani nell’ambito del programma ANR : "Processetti". Matrimonio e mobilità a Venezia, XVI-XVIII secolo. Oltre ad una presentazione della metodologia utilizzata per la strutturazione dei dati, saranno presentati i primi risultati dell’analisi, riguardanti la tipologia dei processetti, le relazioni che intercorrono fra i richiedenti e i loro testimoni e le prove scelte allo scopo di attestare il passato dei futuri sposi. Lo sfruttamento analitico dei processetti di stranieri permette di ricostruire le strutture di fondo che hanno determinato la mobilità verso Venezia, le traiettorie individuali e l’impatto che la peste del 1630 ebbe sulla migrazione.
|
l'orto genealogico che un ricercatore puo' coltivare specie scendendo in tempi remoti ( secoli antecedenti al 1800 ) e' sempre molto piccolo La genealogia e' una scienza dove non puo' esistere il tuttologo L'Italia e' una nazione fortemente segnata da diversita' che caratterizzano un luogo dall'altro ( anche luoghi che distano pochi chilometri ) Questo e' dovuto alla suddivisione in Stati preunitari secolari ( e volendo ad ancora piu' antiche divisioni comunali ) fortemente differenziati per storia politica , religiosa , per leggi , per usanze e per costumanze , per divisioni sociali , per abitudini fiscali , per abitudini demografiche estese ai nomi ed ai soprannomi ed ai cognomi ( e' nota la diversa impostazione nella creazione dei cognomi toscani rispetto ai cognomi meridionali ) , per usi notarili ecc...eccc... Un ricercatore abituato alle zone meridionali si trovera' in profondo disagio operando nell'estremo nord e viceversa La stessa vastita' della documentazione diventa un ostacolo : in Toscana scendendo nei secoli XIV e XIII e XII e' difficile per il ricercatore padroneggiare la documentazione di Firenze e Siena contemporaneamente E penso sia il medesimo nel Regno : dove padroneggiare la documentazione siciliana , napoletana, pugliese , calabrese, abruzzese deve presentare difficolta' anche estremamente maggiori . Per non parlare delle zone ai confini tra il Regno e lo Stato pontificio Per non parlare di tutti quei territori di valico sull'Appennino regni di nessuno se non di poteri locali non riconosciuti dalla legge e dalla storia ma effettivi Per non parlare delle zone di transumanza ......... .........................................
E' conveniente prima di iniziare una qualunque ricerca genealogica passare da questi tre italianissimi siti : sito fondamentale per i tanti dati anagrafici che via via raccoglie sito gestito dai Beni culturali Il Portale Antenati nasce, in linea con altri portali dedicati alla ricerca genealogica e alla storia familiare, promossi in numerosi Paesi, dalla volontà di mettere a disposizione on line l’enorme patrimonio documentale di interesse anagrafico e genealogico – in particolare, atti di stato civile, le liste di leva e ruoli matricolari – conservato negli Archivi di Stato italiani, indispensabile per condurre ricerche sulla storia familiare e degli individui, ma anche di grande interesse per la ricerca storica, genealogica, demografica e le scienze sociali.
GLI ARCHIVI PER LA RICERCA ANAGRAFICA...........................un punto di partenza on line .....un data-base fondamentale
Forum e sito gestito una volta gestito da Luca Bertotti : Tuttogenealogia un sito molto utile a chi sta imparando a muoversi da solo nel mondo della ricerca dove si puo' ricevere aiuto competente nell'interpretazione dei documenti , sui 1000 dubbi , sulla mancanza di idee
https://www.tuttogenealogia.it/ ...........................ottimo sito di ricerca genealogica
Forum dell'associazione I.A.G.I. 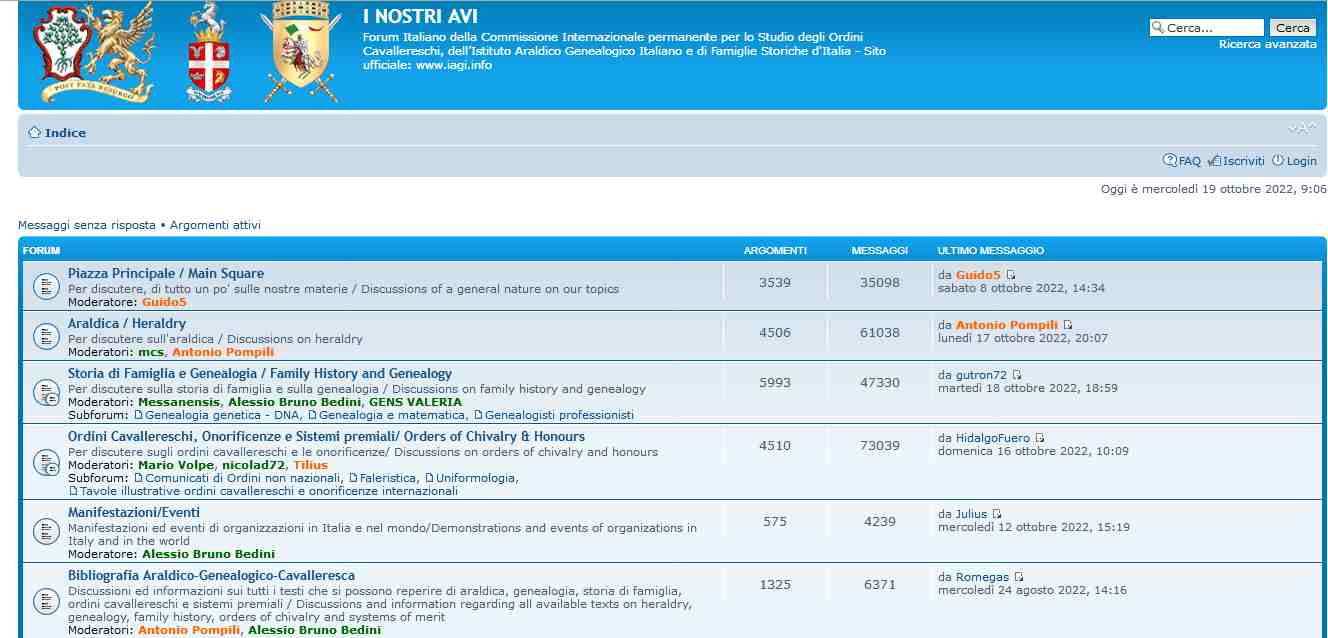
Siti dove potrete trovare persone cortesi e preparate che gratuitamente vi aiuteranno a muovere correttamente i primi passi Ricostruire la propria storia familiare e' un'impresa che richiede pazienza e tenacia ma che alla lunga sempre si rivela piena di soddisfazioni chiunque siano stati i propri antenati : ricchi o poveri , nobili o contadini , famosi o sconosciuti.
SITI UTILI
UN DATA BASE ANAGRAFICO GRATUITO : I MICROFILM DEI MORMONI O SANTI DEGLI ULTIMI GIORNI I Mormoni affermano che i defunti, anche se non aderirono in vita al loro credo, possono ascendere alla gloria celeste mediante una sorta di battesimo “retroattivo”, considerando che soltanto la famiglia nella sua interezza può accedere al più elevato dei tre cieli nel Regno di Dio. Coloro che sono in vita dunque, essendo le anime dei morti prive di corpo e non potendo quindi ricevere il battesimo direttamente, devono aiutare i propri antenati ad ottenere la salvezza facendosi battezzare al loro posto. A questo scopo è però indispensabile ricostruire ogni tipo di parentela e di legame genealogico, radunando tutte le informazioni anagrafiche necessarie sui propri avi defunti, affinché anch’essi possano godere delle benedizioni del “Vangelo”. Da più di un secolo la “Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni” raccoglie nomi grazie al lavoro assiduo e volontario di un numero crescente di missionari (se ne contano ormai almeno 40 mila) che, fino ad oggi, hanno battuto palmo a palmo, oltre alle anagrafi comunali, anche gli archivi parrocchiali di tutto il mondo.
Trova la tua famiglia Scopri te stesso. Siamo un’organizzazione internazionale senza scopo di lucro che offre strumenti gratuiti per aiutarti a scoprire la tua genealogia.
GLI ARCHIVI PER LA RICERCA ANAGRAFICA...........................un punto di partenza on line .....un data-base fondamentale
UN DATA BASE ANAGRAFICO A PAGAMENTO : ANCESTRY.COM o ANCESTRY.IT
IMPORTANTE O INTERESSANTE e' stabilire la diffusione attuale di un cognome utile a determinarne il luogo di origine e a tentare di studiarne mappe migratorie utile a determinare i possibili luoghi d'incrocio a fronte di matrimoni. Ecco i siti migliori :
COGNOMIX DIFFUSIONE DI UN COGNOME ITALIANO
UN SITO DI ECCEZIONALE UTILITA' : ITALIA IN DETTAGLIO REGIONI PROVINCE COMUNI E COGNOMI con PREZIOSI elenchi comuni soppressi
ELENCO PROVINCE ITALIANE NELLE REGIONI IN FOGLIO ELETRONICO
ELENCO COMUNI ITALIANI IN FOGLIO ELETTRONICO
HANNO PARLATO DEI VOSTRI ANTENATI ?
HANNO PARLATO DEI VOSTRI ANTENATI ?
UTILITA'
Opera dell’archivista modenese Adriano Cappelli (1859-1942), il Dizionario, pubblicato in prima edizione nel 1899, è uno strumento essenziale per chiunque si cimenti con la lettura e la trascrizione di testi e documenti medievali o di prima età moderna, in latino o volgare italiano, nei quali molto utilizzato è il sistema abbreviativo. Il Dizionario è utile pure per l’interpretazione delle abbreviazioni epigrafiche del mondo romano e medievale. Considerata la complessità del sistema abbreviativo medievale, il Dizionario non può però sciogliere esaustivamente tutte le abbreviazioni nelle quali ci si può imbattere nel corso della lettura di un documento antico.
da dr Sergio De Mitri Vallier venerdì 16 agosto 2013, 14:38 (sul forum IAGI)
La tecnologia mette a disposizione semplici strumenti che tutti sono in grado di utilizzare . Per avere notizie generiche su un cognome o una famiglia è sufficiente digitarlo su : 1) Un motore di ricerca : es. https://www.google.it/ 2) Un sito che dia notizie sulla concentrazione e la diffusione di un cognome in Italia ed all'estero : es. http://worldnames.publicprofiler.org/ http://www.gens.info/italia/it/ http://www.cognomix.it/mappe-dei-cognomi-italiani/ 3) Un sito che dia ampie notizie bibliografiche su una famiglia,un cognome o su un personaggio storico : es. http://books.google.it/ http://www.treccani.it/enciclopedia/ http://openlibrary.org/ http://archive.org/ https://archive.org/search.php?query=crollalanza 4) Siti per la ricerca anagrafica on line . http://www.antenati.san.beniculturali.it/
|
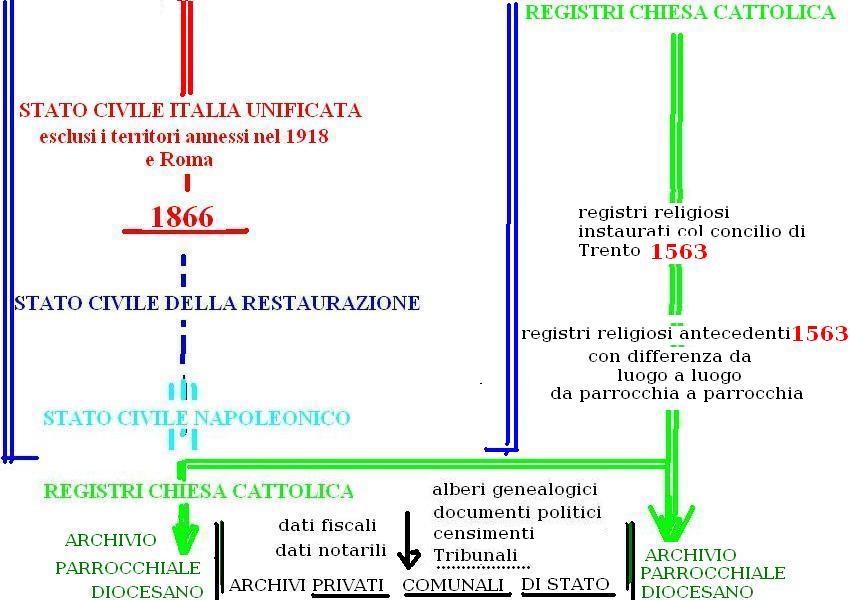
|
STATI PREUNITARI
La nascita dello stato civile fu infatti uno dei grandi cambiamenti che segnarono il passaggio dall'antico regime all'età contemporanea. Con tale istituto le istituzioni civili occuparono un terreno che era tradizionalmente stato della Chiesa. Questa infatti, sin dalla fine del XVI secolo, con il concilio di Trento, aveva affidato ai parroci il compito di tenere e conservare appositi registri, noti come "libri canonici" per registrare in modo sistematico nascite e battesimi, matrimoni e decessi.
Stato civile napoleonico (1806–1815) Napoleone introdusse la pratica di tenere dei registri di stato civile in alcune zone dell’Italia fin dal 1806, pratica che fu rigidamente attuata fino a quando egli perse il potere, nel 1815. Per questo motivo, in genere, i registri napoleonici coprono il periodo dal 1806 al 1815.
Stato civile della restaurazione (1815–1865)
|
Gli stati italiani preunitari demandarono quasi totalmente alla chiesa cattolica la tenuta dell'anagrafica di Stato
Quindi se e il ricercatore dovesse utilizzare solo dei documenti anagrafici apparecchiati dagli stati italiani preunitari farebbe una fatica molto spesso disperata e giungerebbe solo ad inizio 1800 fine 1700
La religione cattolica era strettamente la religione dello Stato e le violazioni religiose si confondevano con le violazioni civili , ed i buoni costumi statali si confondevano con i buoni costumi religiosi
Stato e religione erano un unico sistema di potere e di ordine
Stato e religione erano uno stampella dell'altro
IL LATO OSCURO DELLA CHIESA CATTOLICA :

Chi non ascoltasse la messa od osservasse i precetti era da tener d'occhio come sovversivo
chi leggesse libelli contrari ai principi con cui la chiesa spiegava il mondo
Il parroco sorvegliava e diveniva spia
Stato e religione erano quindi un tutt'uno collaboranti nel mantenere lo STATUS QUO
Il gendarme, il giudice , ed il prete uniti per l'ORDINE PUBBLICO . Forza e persuasione
Quindi non bisogna stupirsi di non trovare un'anagrafica statale ma solo un anagrafica religiosa che si assicurava in primis che tu ti comportassi di buona volonta' da buon cattolico e che non avessi pensieri moletsti all'ordine pubblico
Una cappa di silenzio ,di superstizione ,di ignoranza a protezione dello STATUS QUO
L'ultima condanna a morte dell'inquisizione avvenne in Spagna addirittura il 31 luglio 1826 quando un povero apostata Cayetano Ripoll maestro elementare di buoni principi fu condannato come eretico testardo
le sue colpe ? : sostituire l’espressione “Ave Maria” con “Lodare Dio” nelle preghiere di classe, non andare a messa e non accompagnarci i suoi studenti, non uscire sulla porta per salutare il passaggio della processione del patrono e mangiare carne il Venerdì Santo
L’arcivescovo di Valencia Simon Lopez giustificò l’esecuzione e il processo con una frase: “Dio voglia che serva da punizione per uno e da lezione per altri“.
La rivoluzione francese mando in frantumi questo sistema di potere ,prima temporaneamente poi definitivamente con una societa' che vieppiu' si slegava da quella parte della religione che e' superstizione
L'efficenza burocratica ed organizzativa dello Stato francese mise in evidenza le carenze e le necessita' della burocrazia italiana preunitaria
Se i nostri antenati debbono al curato una quieta rassegnazione , noi dobbiamo gratitudine perche' senza quei registri da KGB non avremmo mai potuto ricostruire le storie dei nostri antenati
|
DOCUMENTI CHE POSSONO ESSERE DI AIUTO ALLA RICERCA GENEALOGICA
CENSIMENTI Avvenimenti estremamente rari nell'Italia preunitaria in Toscana ad esempio quello del 1841 e precedentemente quello del 1561 e del
Esistono poi gli archivi notarili per chi aveva comperato o venduto qualcosa o ....... Una volta il notaio era molto presente nella vita delle persone. Anche per dare forma legale al matrimonio . Chi possedeva qualcosa e lo trasferiva , o chi accedeva ad un prestito , o ............................chiamava il notaio a testimone di quanto era avvenuto per il presente e per il futuro
I documenti notarili possono accompagnarci molto indietro nel tempo ma impongono una ricerca estremamente difficile e assai casuale esaminando i notai che operavano in zona ma non potendo escludere altri
Fortunatamente ( solo per il genealogista ) esistono i documenti fiscali Tutti hanno sempre avuto a che fare con lo Stato che sempre ha chiesto soldi anche ai piu' poveri per le piu' svariate ragioni In genere negli archivi storici comunali o negli archivi di stato troviamo documentati dazzaioli , tasse sul sale , tasse sul macinato , tasse sulle doti ,......................di luogo in luogo con nomi diversi ma ricchi di indicazioni sulle famiglie
Attraverso i documenti fiscali e i documenti notarili il genealogista puo' fare con molta fortuna e con molta fatica passi anche decisivi nel passato familiare
rivestono anche particolare importanza i seguenti manoscritti: -Verbali comunali, che prima erano i verbali della pubblica Vicinanza, ossia dell'assemblea dei Vicini. -I registri delle taglie, cioè delle imposte dirette di un comune; -I testamenti e gli arbitrati , conservati specialmente negli archivi parrocchiali; -I protocolli delle imbreviature dei pubblici notai (rogiti notarili), dove in ogni strumento rogato dal notalo, per esigenza giuridica stessa dell'atto, sono dettagliatamente nomi- nate le persone coinvolte; -I registri delle Confraternite, che nei secoli scorsi avevano anche uno spiccato scopo sociale e fungevano da banche locali (quindi con l'indicazione di tutti coloro che facevano dei legati e di coloro che ricevevano prestiti in denaro); -I pubblici contratti ( vendita di boschi da tagliare da parte di un comune e successiva ripartizione del ricavato tra i fuochi vicini, pubblico reclutamento di soldati, appalto di costruzioni nel comune, ecc.); -I processi civili e penali, in particolare i processi per stregoneria, dove si trovano anche lunghissimi elenchi di indiziati di eresia segreta, cioè di stregoneria; -I registri agricoli, con il bestiame caricato sulle alpi e con i relativi proprietari, con i pegni (multe) pagate per trasgressioni agricole; - Le mappe catastali e gli estimi; Le divisioni ereditarie;
|
|
|
|
NUOVA FEUDALITA'
Principali tasse e balzelli del periodo medievale In questo articolo [ di Massimo Fois ] vengono descritte alcune delle tasse e diritti feudali più in uso nel periodo medievale.
Il Focatico L'imposta istituita da Carlo I D'Angiò nel 1263, era una tassa applicata a ciascun fuoco o focolare, cioè su ciascuna abitazione di un gruppo familiare o su ciascun fumante se l'abitazione comprendeva più gruppi familiari. Il fuoco nel basso medioevo denominava, come detto, l'unità famigliare composta da tutti coloro che vivono nella stessa casa, saldano dosi e cucinano al medesimo fuoco. Nella primavera di ogni anno, il comune inviava alla Magistratura Comunitarie la consueta stampa occorrenti a compilare le operarazioni di focatico. Entro il 30 giugno venivano inoltrate le scritture che alla fine di agosto venivano rispedite alla rappresentanza comunitaria, con il foglio di riparto approvato per detta imposta, mentre i ruoli venivano passati all'esattore comunale per la riscossione da farsi entro date ben precise. Il ruolo si divideva in tre categorie:il fuoco, la terra coltivata e la classe di reddito. I meno abbienti non era assoggettati a tale imposta, ma questo dava origine ad evasioni o a esenzioni concesse per individui che ricoprivano cariche pubbliche (senatori, notai, clero, ecc…). L'Imbottato Il dazio era sostanzialmente una tassa che doveva essere pagata da tutta la comunità per i prodotti agricoli che si possedevano. In un registro risulta "d'imbottar li grani et vini in calende di Novembre di ciascuno Anno per quali grani et vini, quelli che in detto giorno si trovano averli in casa sono tenuti subito fatta la visita et descrittione d'essi pagar alla comunità. Per esempio a Gambolà nel 1619 erano tassati per imbottato un sacco di frumento, fagioli, segale, ceci, fave per due soldi; un sacco di miglio, avena, melega per un soldo; una brenta di vino buono puro per quattro soldi; una brenta di vino chiappato per due soldi e otto denari, ma venivano tassati nuovamente se questi beni venivano venduti o comprati da forestieri.Fodro Dal francone fodar, nutrimento, indica l'obbligo di fornire ospitalità e sostentamento al re, all'imperatore, ai titolari di pubbliche funzioni, al loro seguito e alle milizie, incombente sui vassalli, sui possessori di terre o complessivamente sulle collettività delle località attraversate durante il loro passaggio. Utilizzato nei diritti germanici e nordici, presentava analogie con l'annona romana. Determinante per l'esercizio effettivo della giurisdizionale, perchè garantiva i rifornimenti alle autorità itineranti, ebbe costante applicazione nel corso del medioevo e costituiva uno dei fondamentali diritti pubblici. Dal sovrano il fodro passò ai conti, ai vescovi, agli abati, alle città e grandi o medi proprietari. Fu uno dei principali scontri da Federico Barbarossa e le città lombarde. E detto anche albergaria. Altri tributi e diritti feudali abbeverata: per dissetare gli animali nei fontanili; in latino medioevale ius beverandiacquatico: per attingere acqua da fonti o sorgenti; in latino medioevale ius aquandierbatico: per falciare l'erba in un prato; detto anche erbaggioglandatico: per raccogliere ghiande o condurre maiali nei querceti; anche escatico e ghiandaticolegnatico: per tagliare e raccogliere legna di alto fusto; in latino medioevale ius lignandi; altro sinonimo boscaticomacchiatico: per raccogliere legna di basso fusto, arbustipantanatico: per pescare anguille e rane negli stagnipascolatico: per condurre greggi al pascolo (ius pascendi); più¹ diffuso il diritto di fidapedatico: per attraversare o percorrere a piedi strade, sentieri o proprietà private; anche pedaggiopiscatico: per catturare pesci in acqua dolce o salata; anche pescaticopontatico: per transitare sui ponti doganali o di proprietà privataripatico: per approdare o sostare su rive di acque internesiliquatico: per raccogliere carrube ed altri baccellispicatico: per raccogliere spighe dopo la mietitura; in latino medioevale ius spicandi; inoltre spicilegio e spigaggioDocumento inserito il: 22/12/2014
|
|
DIFFICOLTA'
Spostamenti cambio di cognome nello spostamento da un luogo all'altro fase cognome-patronimico distruzione dei documenti o inesistenza dei documenti religiosi
AGEVOLAZIONI
Scendendo nel passato diminuisce il numero di persone che popolavano una citta' Roma agli inizi del 1400 aveva 60.000 persone (!) Quindi gli individui elencati nei registri di battesimo diminuiscono andando indietro con gli anni fino alla peste nera del 1348
|
|
considerazionigenealogiche
una ricerca del dr Michele Luzzati Prima del cognome
questa splendido articolo di Michele Luzzati fatto a misura di Pisa meriterebbe l'eguale in ogni luogo d'Italia Memoria genealogica in assenza di cognome nella Pisa del Quattrocento di Michele Luzzati Publications de l'École Française de Rome Année 1986 90 pp. 87-100
Sin dai secoli piu' antichi i Comuni italiani si sono posti il problema del numero di individui che abitavano la citta' , per calcolare il fabbisogno di cibo e far fronte in qualche modo ai periodi di carestia evitando le rivolte contro il caro viveri E per far pagare le tasse e per tenere sotto controllo gli obblighi militari si avevano sicuramente degli elenchi E per esercitare forme di controllo Nei documenti sopravvissuti :
abbiamo elenchi di consiglieri che appartengono ai diversi tipi di consigli del Comune medioevale abbiamo elenchi di cittadini eminenti che giurano paci , alleanze composti anche di migliaia di persone ( Pisa ) Gli estimi trecenteschi ( documenti fiscali) ci mostrano a Firenze i nominativi dei capi famiglia con la tassa che dovevano pagare Le matricole delle Arti ci mostrano lunghi elenchi di persone iscritte Il libro di Montaperti ci mostra elenchi di cittadini chiamati alle armi e presenti nell'esercito cittadino
Non abbiamo pero' nessuna forma di registrazioni che possano considerarsi forme di anagrafe vera e propria cosi come la intendiamo per uno Stato moderno La registrazione dei battesimi e' stata sempre l'elemento base ed e' praticamente sempre stata delegata alla chiesa cattolica E spesso i battesimi sono stati raccolti in un unico luogo : come a Firenze o a Pisa nei registri del battistero In Toscana fa eccezione Siena dove anche il Comune registrava i battesimi
In pratica a Firenze ci si limito' a contare il numero di nascite di maschi e femmine in collaborazione con le registrazioni di battesimo ecclesiasticheattraverso fave nere e bianche al momento della nascita ( fava nera maschio, fava bianca femmina ) e contemporaneamente tenendo conto del numero delle morti Solo dagli anni 80 del trecento a Firenze esistono libri statali i Liber aetatis che elencano le nascite limitandosi a prendere in considerazione quelle avvenute all'interno delle famiglie del ceto dirigente cioe' in quelle famiglie che avevano acquisito il diritto di essere imborsate per le cariche comunali
Le registrazioni del battistero fiorentino iniziano pero' solo nel 1450 ( la denuncia nominativa delle bocche ,completa di eta' , nel catasto fiorentino del 1427 da una specie di fotografia della situazione anagrafica di quell'anno ) Firenze non e' il solo luogo dove la Chiesa conserva documenti battesimali di molto antecedenti il 1563 A Gemona ad esempio vi sono registrazioni di battesimo sin dal 1379 A Siena dal 1381 con le tavole della Bicherna A Palermo ................ A Parma dal 1458 A Pisa dal 1457 A Prato............................ A Venezia dal 1506
Lo stato teneva sicuramente i registri dei morti allo scopo di contarli ( quindi non sempre nominativi ) e per differenza ricavare la situazione demografica e il fabbisogno di grano
Varie chiese conservano inltre necrologi relativi agli individui sepolti all'interno dei loro complessi
Questo pero' non ha dato per molto tempo luogo a forme di registrazioni che possano considerarsi forme di anagrafe Questo non ha influito all'affermazione del cognome sulla forma patronimica (che non causava eccessive difficolta' )
l'affermazione del nome familiare ( cognome ) rimane legata per lunghissimo tempo all'affermazione economica e politica della famiglia e probabilmente ad una motivazione che consenta l'uso di uno stemma Abbiamo visto come nel primo catasto del 1427 a Firenze solo una minoranza di famiglie ha un cognome L'unico catasto fiorentino che ha goduto degli studi storici e' il primo cioe' quello del 1427. Sui catasti fiorentini successivi non sono stati fatti molti studi
Ho l'impressione che in Toscana nel corso del quattrocento la diffusione del cognome subisca un accelerazione e agli inizi del cinquecento un numero assai maggiore di famiglie porti un nome familiare ereditario e questo fatto sia ora slegato dal successo politico ( forse legato a diritti di proprieta' sui beni ) Probabilmente sono notai a fare da veicolo all'affermazione del cognome su scala piu' vasta
Disponiamo per Firenze ( solo citta) del censimento del 1562 , su cui poter effettuare un esame dei capofamiglia per vedere se erano cognominati e come
|
|
considerazionigenealogiche ROMA CAPITALE
Nel 1870 viene riunificata Roma all'Italia La monarchia dei Savoja entra in contrasto col Papa e la BUROCRAZIA STATALE si divide dalla BUROCRAZIA RELIGIOSA Per un lungo periodo gli atti religiosi non diventano esecutivi sull'anagrafe civile battesimi, morti , matrimoni celebrati in chiesa, non vengono automaticamente registrati nei registri civili LE DUE REALTA' NON DIALOGANO PIU' . L'11 febbraio 1929 Pio XI e Benito Mussolini stipularono i Patti Lateranensi (così chiamati perché firmati nel Palazzo del Laterano a Roma). Nei Patti si affermava che la sola religione statale era quella cattolica, e che l'Italia riconosceva lo Stato della Città del Vaticano. . Nel diritto civile italiano, il matrimonio concordatario è un matrimonio che si celebra innanzi ad un ministro del culto cattolico, al quale lo Stato riconosce, a certe condizioni, effetti civili. È regolato dall'art. 8 della legge 25 marzo 1985, n. 121 e dall'art. 4 del Protocollo addizionale che costituisce parte integrante dell'accordo (legge 121/1985). Tuttavia, la legge n. 847/29 è ancora vigente per la parte compatibile con le nuove norme, così come è stata modificata dalle sentenze della Corte costituzionale, che riguardo ad un patto trattato tra due nazioni e Stati sovrani (Italia e Città del Vaticano) ha delineato i principi supremi dell'ordinamento costituzionale come parametro del giudizio di costituzionalità delle disposizioni concordatarie (sentenza n. 30 del 1º marzo 1971, C. Cost., 2.2.1982, n.16; 1.3.1971 n.32). . . tipi di matrimonio riconosciuti oggi dall'ordinamento italiano A--Quello meramente religioso; B--Quello religioso ad effetti civili; C--Quello civile; D--Quello acattolico. Nel diritto civile italiano, quando il matrimonio canonico viene trascritto nei Registri di Stato Civile del Comune viene detto matrimonio concordatario, al quale lo Stato riconosce effetti civili. Nel caso l'atto non venga trascritto nei Registri di stato civile, il matrimonio avrà valore solo per la Chiesa. . . Il dissidio tra Stato e Chiesa , specie per quanto riguarda i matrimoni genero' situazioni abnormi e talvolta di bigamia acclarata Ovviamente in tale periodo predomina lo STATO che ha facolta' di valutare come reati certe situazioni ( la Chiesa potendo solo scomunicare )
|
|
considerazionigenealogiche CONSANGUINEITA'
|
|
considerazionigenealogiche
Il DNA è composto di quattro basi chimiche: adenina (A), tinina (T), guanina (G) e citosina (C). La sequenza di queste lettere, nelle sue infinite combinazioni, determina com'è fatto ogni organismo vivente e qual è la sua predisposizione ad alcune malattie. La sequenza con cui si susseguono le basi azotate lungo la catena può avere combinazioni infinite ed è ciò che distingue il DNA di una persona da quello di un'altra. Ogni organismo vivente, infatti, possiede un proprio patrimonio genetico diverso da quello di chiunque altro. Ognuno di noi eredita il proprio patrimonio genetico per il 50% dal padre e per il 50% dalla madre. Ognuno di noi, se ha un figlio, gli trasmette il 50% del proprio patrimonio genetico. Per ogni gene, dunque, sono presenti due alleli: uno ereditato dal padre e uno dalla madre. La funzione cui i due alleli di un gene sono deputati è la stessa, ma diverso può essere il messaggio codificante: per esempio abbiamo 2 alleli per il carattere “colore degli occhi”, ma un allele può codificare per il “colore chiaro”, l’altro per il “colore scuro”. Se entrambi gli alleli sono uguali (es. colore chiaro/colore chiaro), l’individuo è detto omozigote per quel carattere (in greco omòs vuol dire uguale); se i due alleli sono differenti (es. colore chiaro/colore scuro), l’individuo è detto eterozigote. I geni sono organizzati in strutture chiamate cromosomi, gli esseri umani ne hanno 23 coppie in ogni loro cellula. 22 coppie di autosomi (non coinvolti nella caratterizzazione del sesso dell’individuo----DNA AUTOSOMICO) e una coppia di cromosomi sessuali.( X-DNA ; Y-DNA ) La sequenza con cui si susseguono le basi azotate lungo la catena può avere combinazioni infinite ed è ciò che distingue il DNA di una persona da quello di un'altra. Ogni organismo vivente, infatti, possiede un proprio patrimonio genetico diverso da quello di chiunque altro. Per quanto riguarda i cromosomi sessuali c’è da far notare che la loro trasmissione alla prole è in qualche modo vincolata. Tutti i figli maschi condividono lo stesso cromosoma Y del loro padre del loro zio e nonno paterno e così via per tutti i maschi di una stessa famiglia. Questo perché il cromosoma Y è sempre ereditato dal padre (discendenza patrilineare). Tutti i figli maschi e femmine hanno lo stesso DNA mitocondriale della loro madre, nonna materna e così a ritroso per tutto l’albero genealogico della loro madre. Questo perché i mitocondri con il loro particolare DNA sono sempre ereditati dalla madre (discendenza matrilineare). La trasmissione dei geni mitocondriali differisce completamente da quella dei geni nucleari in quanto non subiscono la ricombinazione casuale per mezzo del crossing over e vengono sempre ereditati per via materna. Discendenza matrilineare e patrilineare sono i principi su cui si fondano i test di accertamento di parentela, grazie ai quali è possibile scoprire un legame di sangue tra due o più soggetti anche in assenza dei genitori biologici per le analisi.
I gemelli identici o monozigoti sono individui derivanti da un unico zigote (l'ovulo fecondato dallo spermatozoo). Poco dopo il concepimento, lo zigote comincia a moltiplicarsi dando origine ad un ammasso di cellule, sempre più numerose ed organizzate, che prende il nome prima di morula e poi di blastocisti. Nelle gravidanze gemellari monozigotiche l'ammasso cellulare si scinde in due parti che generano organismi geneticamente identici, cioè con identico patrimonio genetico. I gemelli non identici, o dizigoti, derivano invece da due ovuli distinti, fecondati da due spermatozoi, ognuno dei quali diventa uno zigote con un patrimonio genetico che è per circa la metà uguale all'altro. Ecco perché possono anche essere di sesso diverso.
tra 75 000 e 70 000 anni fa l'esplosione di un supervulcano....................
La teoria della catastrofe di Toba sostiene che tra 75 000 e 70 000 anni fa l'esplosione di un supervulcano al di sotto del lago Toba, probabilmente il più grande evento eruttivo negli ultimi 25 milioni di anni, rese ancora più rigido il clima del pianeta che già stava attraversando una glaciazione. Studi filogenetici sul cromosoma Y umano suggeriscono che circa 75 000 anni or sono la specie umana fu ridotta a poche migliaia di individui. Questo collo di bottiglia nella numerosità della popolazione umana spiega in parte la scarsa variabilità genetica nella nostra specie. Alcuni ricercatori fanno risalire all'eruzione di Toba la causa di quella drastica riduzione. La teoria per ora non appare in contraddizione con le datazioni matrilineari dell'Eva mitocondriale e patrilineari dell'Adamo Y-cromosomiale. Secondo questa teoria, un evento simile lasciò conseguenze molto gravi in tutto l'ecosistema mondiale del tempo, portando molti organismi sull'orlo dell'estinzione.
Questa teoria è stata proposta nel 1998 da Stanley H. Ambrose dell'Università dell'Illinois a Urbana-Champaign. L'effetto collo di bottiglia dovuto all'eruzione di Toba si troverebbe anche per altre specie di mammiferi. Le popolazioni di scimpanzé dell'Est africano, degli orangutan del Borneo, dei macachi dell'India, dei ghepardi e delle tigri hanno tutte recuperato a partire da un numero molto basso di esemplari circa 70 000–55 000 anni fa. Fra l'altro, la separazione genetica fra gorilla di pianura orientale e gorilla di pianura occidentale è stimata essere avvenuta circa 77 000 anni fa.
Nella genetica umana, l'Adamo cromosomiale-Y o Adamo cromosomico è l'ultimo antenato comune dal quale tutti gli uomini viventi discendono in linea paterna. L'Adamo cromosomiale-Y probabilmente è vissuto circa 75 000 anni fa in Africa ed è la controparte dell'Eva mitocondriale.
L'Adamo cromosomiale-Y riceve il suo nome dal personaggio biblico Adamo raccontato nel libro della Genesi. Questo mero accostamento non vuole ipotizzare che l'Adamo ancestrale sia stato l'unico uomo maschio del suo tempo, ma semplicemente colui che produsse una linea completa di figli maschi fino ad oggi: è, cioè, l'antenato a cui converge tutta la popolazione attuale o, in particolar modo, il cromosoma Y dal quale discendono tutti i cromosomi Y umani attualmente diffusi nel mondo.
Uno studio biologico dell'Università di Stanford sopra 93 polimorfismi genetici umani scoperti in questo cromosoma, in 1000 individui di 21 regioni del mondo, calcolò che un progenitore o gruppo di antenati maschili comuni a tutti gli uomini attuali visse in Africa circa 70 000 anni fa[senza fonte]. Studi successivi del cromosoma Y hanno stimato date anteriori per l'antenato maschile comune facendolo risalire tra i 100 000 e i 200 000 anni fa.
Si crede che l'apparizione dell'Adamo cromosomiale-Y sia da relazionarsi alla "Teoria della catastrofe di Toba". Questa catastrofe avrebbe provocato un restringimento del pool genetico della specie umana in modo tale da potenziarne l'unità genetica, la quale si presume fosse ridotta a solo 1000 individui intorno all'anno 70 000 a.C.
Così come i cromosomi-Y si ereditano per via paterna, i mitocondri si ereditano per via materna. Pertanto è valido applicare gli stessi principi. Il progenitore comune più vicino per via materna è stato soprannominata Eva mitocondriale.
LO STUDIO Y_DNA UN NUOVO STRUMENTO GENEALOGICO ( ???? ) O UNO STRUMENTO GENEALOGICO FUTURIBILE strumento che muove e nasconde molti interessi economici , al quale accostarsi per ora con la circospezione che serve a chi non padroneggia la scienza, l'ambiente, e le circostanze ) OGGI : risultati e raccolta dati tutti da verificare : "guarda com' entri e di cui tu ti fide ..." Ma nel futuro molto prossimo lo strumento principe nella ricerca genealogica Ritengo che il futuro della genealogia sara' legato strettamente allo Y-DNA cioe' un sistema d'individuazione pienamente scientifico L'albero genealogico sara' patrilineare suffragato da documenti e da Y-DNA Quindi cognomi "omonimi " ( pensi al cognome Rossi che necessariamente e' composto di moltissimi capostipiti diversi ) dovranno necessariamente distinguersi in base allo Y-DNA Questo se ci pensa accadeva gia' nei tempi antichi ( quando era chiaro che famiglie omonime non erano parenti ) A Firenze ad esempio i Ridolfi ( cognome importante ) erano suddivisi in tre ( il Ceramelli ne cita addirittura 7 ) casati importanti che pur avendo lo stesso cognome non erano per niente parenti Cosi per distinguerli avevamo : Ridolfi di piazza Ridolfi di ponte Ridolfi di borgo Stesso cognome ----Y-DNA diverso ----necessita' di una individuazione diversa per distinguere gente con Y-DNA diverso Tutto il resto ( Y-DNA escluso ) scientificamente cade sotto la logica dello MRCA
Oggi pero'
UNA FEMMINA UMANA EREDITA DALLA MADRE LO STESSO DNA-MITOCONDRIALE E NESSUN DNA SESSUALE DAL PADRE. UN MASCHIO EREDITA DALLA MADRE IL DNA MITOCONDRIALE E DAL PADRE SOLO LO Y-DNA
LA FEMMINA UMANA MARCHIA QUINDI I PROPRI FIGLI COL PROPRIO DNA-MITOCONDRIALE , IL MASCHIO MARCHIA I PROPRI FIGLI MASCHI COL PROPRIO CROMOSOMA Y E CON NESSUNA PARTE DEL MITOCONDRIALE EREDITATO DALLA MADRE
ALLO STATO ATTUALE DEGLI STUDI LO Mt--DNA VIENE CONSIDERATO POCO UTILE ALLO STUDIO GENEALOGICO AL CONTRARIO LO Y--DNA VIENE CONSIDERATO ASSAI UTILE QUINDI LE FEMMINE RESTANO PRIVE DELLA BUSSOLA GENEALOGICA NON EREDITANDO IL CROMOSOMA Y CHE PASSA SOLO DA MASCHIO A MASCHIO
L'UTILITA' DELLO Y--DNA E' LEGATO ALLE MUTAZIONI CHE ABBASTANZA SPESSO SUBISCE NELLA TRASMISSIONE TRA PADRE E FIGLIO ( DA TENER PRESENTE CHE DUE FRATELLI MASCHI POSSONO RICEVERE O NON RICEVERE LA MEDESIMA MUTAZIONE QUESTE MUTAZIONI SI SUCCEDONO CON UNA FREQUENZA DI 100 --150 ANNI PER CUI I MASCHI DI UNO STESSO ALBERO GENEALOGICO TENDONO A DIFFERENZIARSI PER MUTAZIONI FORMANDO UN ALBERO DI MUTAZIONI CHE PUO' ESSERE SEGUITO A RITROSO COME SI SEGUE L'ALBERO GENEALOGICO ( QUINDI SOLO LUNGO LA LINEA MASCHILE ) .
Puo' accadere ovviamente che gia' figlio e padre abbino uno Y-DNA diverso per una mutazione e quindi i fratelli maschi abbiano Y_DNA sensibilmente diverso
https://www.tuttogenealogia.it/ ...........................ottimo sito di ricerca genealogica VERIFICA ALBERO GENEALOGICO CON DNA
VERIFICA ALBERO GENEALOGICO CON DNA ......................Per la cortesia di Adriano Squecco
Per fare un esempio, se ho ereditato da mio padre un YDNA con le 3 mutazioni M1/M2/M3 e nel corso della mia esistenza ne sorge una nuova M4 nel mio cromosoma Y, mio figlio maschio avra' un YDNA con 4 mutazioni. Se un altro individuo, indipendentemente dal suo cognome, ha un YDNA con le mutazioni M1/M2/MX se ne deduce che appartiene alla mia stessa linea paterna. E dal numero di mutazioni diverse (1 in questo caso, ossia M3 in una linea e MX nell'altra) si ricava una stima spannometrica del tempo trascorso dalla separazione delle due linee. In questo caso 1 mutazione vale circa 100/150 anni e quindi, in questo esempio, gli individui avranno probabilmente anche lo stesso cognome.
io condivido con mio fratello le stesse mutazioni o le stesse meno o piu' una ( uno di noi potrebbe essere l'inizio di una mutazione ) l'unico supporto alla ricerca genealogica da parte della genetica e' basato sul cognome paterno perche' e' possibile suddividere uno stesso cognome secondo l'individuo che ne e' lo stipite ( MRCA) Ad esempio : Se io faccio una ricerca su tutti i "Rossi" italiani sono in grado di suddividerne l'insieme Cognome in tanti sottoinsiemi ROSSI---YDNA che hanno in comune lo stipite (MRCA) Questo stipite lo trovo nell'intervallo temporale 1100 ---- 1600 poiche' generalizzando i cognomi moderni nascono tra il 1100 e il 1600 Sotto il limite inferiore di questo intervallo continueremo a trovare antenati ma privi di cognome Considerando per ogni secolo 4 generazioni l'intervallo e' 37---17 generazioni
Molto difficile ( anzi al momento impossibile per mancanza di conoscenze e studi ) invece e' costruire l'albero di questi Rossi aventi la stessa origine cioe' individuare cronologicamente con sicurezza i nodi del loro albero
Problema : io condivido con mio fratello le stesse mutazioni o le stesse meno o piu' una ( uno di noi potrebbe essere l'inizio di una mutazione ) Scendendo nel passato io condivido coi miei avi sempre meno mutazioni E questo mi pare un punto importante ed enigmatico del problema piu' ci allontaniamo nel tempo e meno sono i punti comuni nello YDNA e il calcolo diviene statistico e quindi con margini di aleatorieta'
"If two individuals match in the 12-marker test for either 10 out of 12 (10/12) or 11 out of 12 (11/12), they are also considered related, but the time frame to the common ancestor, MRCA, is more distant than if they had a 12/12 match. Where the matches are less that 10/12, the two individuals are not considered to be related; certainly not in genealogical terms. If your 12-marker test results match another participant’s exactly, 12/12, your common ancestor occurred between 1 and 62 generations ago, with a 50% probability that the common ancestor lived 14.5 generations ago or less. There is a 90% probability it was within 48 generations and a 95% probability it was within 62.
You can shorten this time span to the MRCA as determined by the 12-marker test significantly by increasing the number of markers tested to 25 or 37.
If two individuals match exactly (25/25) in the 25-marker test, their MRCA would have lived between 1 and 32 generations ago, with a 50% probability that the common ancestor lived 7 generations ago or less. There is a 90% probability the MRCA was within 24 generations and a 95% probability that it was within 32 generations. Therefore, increasing the markers tested from 12 to 25 lowers the time frame to the most likely MRCA from 14.5 to 7 generations.
If two individuals match exactly (37/37) in the 37-marker test, their MRCA would have lived between 1 and 20 generations ago, with a 50% probability that the common ancestor lived 5 generations ago or less. There is a 90% probability the MRCA was within 16 generations and a 95% probability that it was within 20 generations. Therefore, increasing the markers tested from 12 to 37 lowers the most likely time frame to the MRCA from 14.5 to 5 generations." http://www.kknfa.org/howmanymarkers.htm
E' EVIDENTE CHE VALE IL CALCOLO DELLE PROBABILITA' I MARKER TEST RAPPRESENTANO IL CAMPIONE ESTRATTO DA UN INSIEME LA PROBABILITA' DI PARENTELA CHE RICAVIAMO GIA' CON 12 MARKER ( 95% ) E' ESTREMAMENTE ELEVATA
A me parebbe non sia possibile COMUNQUE allo stato attuale costruire l'albero genealogico con la sola genetica ma solo sia possibile di poter dire con sufficiente sicurezza se due persone con lo stesso cognome sono parenti per linea maschile anche nel caso la loro parentela risalga al secolo XII Cosa comunque mi pare di molto interesse .E' comunque una ricerca da specialisti per cui bisogna andare sulla fiducia . Qualcosa perlomeno per me che stento a inquadrare Non ho la minima idea di come si scelgano i marker test e perche' questi diano un risultato attendibile . Ne come facciano a trovare le mutazioni del cromosoma esaminando solo una parte dello Y-DNA
La genealogia come disciplina ausiliaria della genetica
il terzo articolo che ho segnalato dice Gli aplogruppi del Y-DNA sono utili per determinare se due individui apparentemente non correlati che condivisono lo stesso cognome effettivamente discendono da un antenato comune in un passato non troppo lontano (da 3 a 20 generazioni). Questo risultato è ottenuto confrontando gli aplotipi attraverso i marker STR
E' evidente si possa fare perche' il riconoscimento della paternita' viene fatto ed e' attendibile Ed e' cosa corrente di tutti i giorni . Quindi il biologo sa dove mettere le mani ma comunque e' costretto ad usare il calcolo delle probabilita' Quello che mi lascia perplesso e' che nell'era di Facebook ( in cui tutti si cercano e si aggregano ) nessuna delle grandi aziende del settore abbia mai proposto uno ricerca sui cognomi Sono costretto a fidarmi di quanto sento affermare A me pare CHE ALLO STATO ATTUALE DI DATI RACCOLTI E CONOSCENZE ACQUISITE non sia possibile costruire l'albero genealogico con la sola genetica ma solo sia possibile di poter dire con sufficiente sicurezza se due persone con lo stesso cognome sono parenti per linea maschile anche nel caso la loro parentela risalga al secolo XII il problema di risalire dall'origine del cognome nell'intervallo 1100--1600 e legare quell'uomo (stipite primo del cognome o MRCA ) ad un uomo moderno con lo stesso cognome essendosi il suo Y-DNA diversificato con una decina di mutazioni casuali e' oggi possibile esaminando le persone con un medesimo cognome .
ALESSIO BRUNO BEDINI IAGI FORUM : ESAME DEL DNA A FINI GENEALOGICI
http://www.iagiforum.info/index.php?sid=ec8c4142740b37f72cbb0ccbdc6c17c9 DOMANDA : Ho un cognome non eccessivamente diffuso 400 / 500 famiglie. Se analizzassi un membro maschio ( col metodo che dovreste dirmi ) di ciascuna famiglia, quali sono le certezze ( genealogicamente ) che potrei ottenere ? RISPOSTA : Testando il cromosoma Y di almeno 1 maschio per ogni ramo avreste la certezza del vostro collegamento genetico o meno. Le carte a volte possono non dire il vero.. pensiamo al caso due fratelli che risultano figli di due stessi genitori ma poi però uno è figlio dell'amante della madre. Il DNA invece non mente! Quindi anche se i rami divergono da 700 800 900 anni e' possibile stabilire la parentela o la non parentela certa . Giusto ? A questo punto se riesco a ricostruire un albero (perfettamente documentato ) che discende ad un tizio vissuto nel trecento su un ramo mi basterebbe l'esame del DNA per provare o escludere il legame con un ramo di una famiglia omonima ho capito bene ? Quale e' il test minimo per ottenere la sicurezza della parentela ( e quale il costo approssimativo ? ) Con un test a 67 marcatori hai la certezza matematica anche a distanza di 700-800 anni. Il costo con FTDNA è $268 (250 euro)
Per esempio - ho tre 12 marcatori con le famiglie Berni, Hopkins, e Frank. Un "match 12 marker" indica un antenato comune paterna diretto tra 800-1200 tra il Berni, Hopkins, Frank, e la mia famiglia paterna. A "24 e match" indicherebbe un rapporto più stretto, probabilmente un antenato paterno comune intorno 1400-1500.
MILANO - Il patrimonio genetico dei membri di una famiglia è così simile che, anche quando genitori e figli non si conoscono, è comunque possibile stabilirne la parentela con l'analisi del Dna. Basandosi su questo fatto, uno studio inglese ha dimostrato come alcuni uomini, non imparentati tra loro ma con lo stesso cognome, discendono tutti da un unico antenato risalente al XIV secolo. COGNOMI INSOLITI - La ricerca ha preso in considerazione 1.600 cittadini inglesi, non imparentati tra di loro, con 40 cognomi comuni (incluse le variazioni ortografiche). Turi King e Mark Jobling, dell'Università di Leicester, hanno appurato che tra gli uomini con un cognome raro (meglio se localizzato geograficamente, come ad esempio Grewcock, Wadsworth, Ketley), esiste una linea ereditaria continua a partire dai primi antenati della famiglia. I nipoti che portano oggi il loro cognome, insieme a esso hanno ricevuto dai padri anche il genoma del cromosoma sessuale Y. La stessa cosa non accade invece per i nomi familiari molto diffusi, come per esempio quelli legati ai mestieri (Smith, uno dei cognomi anglosassoni più diffusi al mondo, vuol dire "fabbro"). È più probabile che questi in passato siano stati adottati da persone non imparentate tra loro e che quindi non condividevano neppure il genoma. LONTANI PARENTI - L'indagine è stata condotta in Inghilterra ma le conclusioni sono applicabili a livello internazionale. Grazie a questa scoperta infatti sarebbe possibile ricostruire i legami genealogici effettivi delle famiglie sparpagliate per il mondo che condividono un cognome particolare, anche laddove non esistono archivi parrocchiali o ci sono documentazioni incomplete. Nello specifico i cognomi inglesi furono introdotti in Bretagna dopo la conquista normanna (nel X secolo d. C.) ed erano ampiamente diffusi già pochi secoli dopo, perciò i vari Attenborough e Ravenscroft di oggi hanno probabilmente tutti un unico antenato comune inglese vissuto 700 anni fa. APPLICAZIONI ANTROPOLOGICHE E FORENSI - Grazie a questi risultati sulle famiglie britanniche, gli scienziati hanno anche sfatato la credenza popolare sui figli illegittimi: "Le persone spesso citano un detto per cui una persona su dieci sarebbe un figlio illegittimo. I nostri studi invece dimostrano che si tratta di un'esagerazione. La frequenza reale è di un illegittimo ogni 25", dichiara il prof. Jobling. Inoltre, potendo mettere in stretta relazione il genoma con determinati cognomi, in futuro lo studio potrà essere di grande aiuto anche alla scienza forense che potrebbe identificare il cognome dei colpevoli direttamente dall'analisi del Dna trovato sulla scena del crimine. Valentina Tubino 12 febbraio 2009
by Adriano Squecco : Dopo aver raccolto tantissimi dati sulla mia genealogia mi e' venuto spontaneo cercare di capire quanto questi dati fossero allineati con la biologia. Limitandomi ad esempio alla mia linea paterna, mi sono semplicemente chiesto se il mio antenato paterno piu' lontano nel tempo, nato intorno alla meta' del 1500, fosse biologicamente un mio reale antenato paterno. E mi sono chiesto anche come avrei reagito se avessi scoperto di aver compilato un albero genealogico non corrispondente alla realta' biologica della mia linea paterna. Ossia se ci fosse stato nella mia linea paterna un cosiddetto "evento non paterno" (adozione etc). In altre parole, mi sono chiesto come l'avrei presa se avessi scoperto di aver ricostruito l'albero genealogico del cognome 'sbagliato'. Essendo molto interessato alle indagini in generale, ho quindi cercato di capire se ci fossero degli strumenti utili a darmi delle risposte in merito. Il mio approccio alla genetica e' stato quindi inizialmente dovuto a questo. Avrei potuto anche ritenermi soddisfatto del mio bell'albero genealogico (che per il mio cognome e' completo quasi di tutti i rami), ma invece ho cercato di andare oltre alla genealogia, per cercare di dare delle risposte alle domande che avevo dentro. Utilizzando l'albero genealogico da me ricostruito, ho quindi cercato un cugino paterno vivente che genealogicamente fosse il piu' lontano possibile da me. Ed in effetti ne ho trovato uno che ha come comune antenato paterno piu' vicino a me un antenato nato agli inizi del 1600. La genetica del cromosoma Y dice che apparteniamo esattamente alla stessa linea paterna. Visto che c'ero ho contattato anche un altra persona con lo stesso cognome che appartiene ad un ramo che non sono riuscito a collegare genealogicamente al restante albero principale e la cui linea vive da almeno un paio di secoli in altra regione (molto) lontana dalla regione di origine del mio cognome. Anche in questo caso la genetica ha confermato l'appartenenza alla stessa identica linea paterna. Quindi alla fine ho capito di aver compilato l'albero genealogico 'giusto'. Ed ho anche capito che il ramo 'fuori regione' appartiene al mio stesso albero, nonostante esperti genealogisti lo ritenessero, vista la distanza geografica, il risultato di una semplice omonimia. Sempre per cercare di andare oltre alla genealogia, mi sono ad un certo punto chiesto se la mia linea paterna, presente in Friuli sin dalla meta' del 1500, fosse sempre vissuta li'. Anche in questo caso la genetica puo' fornire dei dati. Ho infatti creato una mappa di distribuzione del mio gruppo paterno, basandomi su una mutazione del mio cromosoma Y che risale all'incirca a 3.500 anni fa. E questa e' la mappa che sono riuscito a mettere insieme. La genetica da sola non da' tutte le risposte, ma insieme ad altri dati (genealogici, storici etc) puo' aiutare quanto meno ad avanzare delle ipotesi che non sono campate in aria. Questo solo per dare qualche esempio pratico di utilizzo della genetica in ambito genealogico e non. By Adriano Squecco
|
|
IN REALTA'
non sono un biologo e quindi sono ignorante nel senso che non domino appieno l'argomento chimico ed ho quindi diversi punti oscuri , ma ritengo sia bene tenere presente questo Vi e' stata una diffusione scorretta dell'argomento avendo grandi aspettative , ma il nostro grado di ignoranza e' ancora troppo elevato Mi sono sempre chiesto come mai le aziende non proponessero a cognomi di piccola diffusione screening a costi contenuti per verificarne la parentela e dividere i cognomi in casati cioe associare al cognome i vari alberi diversi. Ed ho sempre avuto diffidenza che non lo sapessero fare in realta la conoscenza dell'aplogruppo di tizi con lo stesso cognome giunti fino a noi ti serve solo per escludere Se non hai lo stesso aplogruppo sai che non sei parente Per includere di derivare da uno stesso stipite e quindi di appartenere allo stesso albero serve ben altro Dato per scontato la mancanza di incidenti genealogici nei fili genealogici discendenti (tradimenti ). Serve la comparazione degli Y DNA a due a due con un esame fatto con medesime modalita' Quindi occorre avere contemporaneamente a disposizione i due DNA perche' deve essere preso un sistema di riferimento comune sui due Y-DNA non semplice da stabilire Esame difficile con esito legato a molte difficolta' essendoci in ballo ( dal possibile antenato in comune ) oltre una ventina di mutazioni una decina per te una decina per lui Esame difficile perche non prende in considerazione tutto lo Y-DNA ma solo porzioni di questo L'esame di paternita' vedendo in gioco al massimo una mutazione , e' quindi abbastanza semplice da eseguire Tra fratelli ho al massimo due mutazioni Il risultato e' comunque sempre probabilistico Ma via via che aumenta la possibilita' di mutazioni diventa un esame molto difficile e ad alto rischio di errore Quindi , io credo , dobbiamo rimandare al futuro l'uso dello Y- DNA
|
|
Nelle pagine di questo sito ho cercato di individuare i luoghi dove si manifesta la presenza del cognome Carnesecchi nel periodo intorno al 1560 --1600 cioe'dal momento in cui quasi ovunque e' possibile utilizzare i registri ecclesiastici per ricostruire le genealogie Sara' cosi possibile in futuro per molti Carnesecchi fare indagini genealogiche piu' approfondite Sara' cosi possibile attraverso pochi campioni di DNA verificare i legami o i non legami tra i vari nuclei Includendo eventualmente nella ricerca i Duranti e i Castellani di Reggello
Insomma cio' che mi piacerebbe fare e analizzare il DNA dei vari gruppi dei Carnesecchi per vedere se esiste uno stipite comune o se esistono piu' stipiti Essendo i Carnesecchi un numero di famiglie molto limitato e formando queste dei raggruppamenti ancora piu' limitati ( a Ceprano ad esempio basterebbe fare il tampone DNA solo a due ,tre maschi e non necessariamente a tutti ) penso che con una trenta .quaranta tamponi si potrebbe avere un risultato complessivo )
COMUNQUE AD OGNI GENERAZIONE C'E' SOLO UN MATRIMONIO CHE CI INTERESSA DIRETTAMENTE E QUINDI NEL NOSTRO ALBERO IN OGNI GENERAZIONE FIGURA UN SOLO NUOVO COGNOME QUELLO DELLA MOGLIE MADRE CON UN MASSIMO DI SEDICI COGNOMI PER ARRIVARE AL 1600 ED UN MASSIMO DI TRENTADUE COGNOMI PER ARRIVARE AL 1200
ALCUNI UNISCONO AL PROPRIO COGNOME UNO DI QUESTI COGNOMI SCEGLIENDO TRA QUELLE PARENTELE CHE PENSANO POSSANO DARE MAGGIOR LUSTRO FORMANDO UN COGNOME DOPPIO NON SO QUANTO QUESTA PRASSI SIA GIUSTIFICATA
ABBIAMO VISTO FAR QUESTO IN PASSATO : QUANDO UN RAMO DI UN COGNOME SI ESTINGUEVA E VENIVA , COL BENEPLACITO DEL REGNANTE , PROSEGUITO DA UN ADOTTATO ( DISCENDENTE DA FEMMINA ) CHE INAUGURAVA UN DOPPIO COGNOME E TROVIAMO COSI SITUAZIONI AL LIMITE IN CUI INDIVIDUI PRESENTANO TRE O QUATTRO COGNOMI Se questo andava bene per la FONS HONORUM cozza come adesso vediamo con la ricerca genetica che ci dice che ci parla del rapidissimo degrado della vicinanza genetica per via femminile
Gli ordini più desiderati? «Quello di Malta, che ha più imitazioni della Settimana Enigmistica, e quello dei Templari, per la sua storia affascinante», aggiunge D'Andrea. Di clic in clic, le ricerche si rincorrono. E sì che i numeri della nobiltà sono esigui. «Le famiglie titolate riconosciute nel Libro d'Oro della nobiltà italiana - prosegue degli Uberti - sono 1.200. Intorno a queste, ce ne possono essere altre settemila: approssimativamente cinquemila sono nell'elenco ufficiale, duemila non hanno provveduto a comunicare la loro esistenza, magari perché residenti all'estero». Il forte desiderio di nobiltà si traduce pure in piccoli trucchi. C'è chi adotta il doppio cognome, aggiungendo quello materno, perché fa effetto. E chi sfrutta il cognome che inizia con De, staccandolo e adottando la minuscola. «Queste cose colpiscono chi non sa - continua degli Uberti - de, di, degli, davanti al cognome, sono impropriamente definiti particella nobiliare ma specificano solo una discendenza. Purtroppo ci sono tanti poco seri che garantiscono di saper fare ricerche. Meglio fare da soli. Tutti sappiamo leggere e scrivere, dunque tutti siamo in grado di condurre una ricerca genealogica, peraltro è bellissimo». by https://www.ilmessaggero.it/mondo/come_diventare_nobile_conte_marchese_duca_titolo_nobiliare_da_comprare_come_si_fa_news_oggi-6192146.html?refresh_ce
IN REALTA' I LEGAMI CON LE FAMIGLIE DI ALTRO COGNOME SI ALLENTANO GENERAZIONE DOPO GENERAZIONE CIO' CHE SEMBRA NON ALLENTARSI E' PER I MASCHI DI UNO STESSO GRUPPO PARENTALE IL LEGAME CON L'ADAMO PRIMORDIALE ED IL SUO CROMOSOMA Y
DNA-EXPRESS :analisi genealogiche : https://www.dnaexpress.it/genetica/fratelli-dna-comune/
È il DNA che ci differenzia gli uni dagli altri, che ci rende unici al mondo “al di là di ogni ragionevole dubbio” e, tale patrimonio genetico è frutto esattamente del 50% del genoma di nostro padre e 50% del genoma di nostra madre.
I fratelli che condividono entrambi i genitori sono detti fratelli carnali, germani o bilaterali. I fratelli che hanno in comune un solo genitore sono detti unilaterali. Nello specifico, i fratelli unilaterali che condividono il padre si dicono consanguinei, mentre quelli che condividono la madre si definiscono uterini. Si definiscono fratellastri due individui che condividono un solo genitore: il termine fratellastro è quindi sinonimo di fratello unilaterale. I gemelli monozigoti (anche detti gemelli monovulari o semplicemente identici) derivano da una singola cellula uovo fecondata da uno spermatozoo. I gemelli dizigoti derivano dalla fecondazione di due diverse cellule-uovo da parte di due diversi spermatozoi I gemelli siamesi sono gemelli monozigoti, che alla nascita presentano organi o tegumenti in comune. I gemelli bizigoti o sesquizigoti nascono da una cellula uovo fecondata da due spermatozoi.
DNA in comune tra fratelli?
Nonostante questo principio è importante capire che però tra due fratelli il DNA in comune è circa solo il 25%. Questo perché malgrado ereditiamo il 50% del DNA dai nostri genitori, i nostri fratelli non ereditano lo stesso 50%. In linea generale c’è una sovrapposizione del 50% del DNA di un genitore con i suoi figli, quindi possiamo dire che un fratello ha il 50% del 50% del DNA di un genitore in comune con un altro fratello.
GEMELLI I gemelli monozigoti possiedono esattamente lo stesso DNA, in quanto derivano da una singola cellula uovo e uno stesso spermatozoo. Sono pertanto indistinguibili a livello genetico e l’unico modo per identificarli e tramite le impronte digitali.
FRATELLI E Y-DNA Per verificare che un uomo sia vostro fratello o che comunque condividiate almeno lo stesso padre potresti dover ricorrere ad un particolare tipo di test del DNA, ovvero il test del cromosoma Y. Devi sapere che il cromosoma Y viene ereditato da tutti i figli maschi di uno stesso padre, quindi torna molto utile eseguirlo quando il presunto padre non è disponibile per le analisi.
SORELLE Mediante l’analisi dei polimorfismi del Cromosoma X (X-STR) si può verificare se due o più persone siano sorelle tra di loro. Le donne hanno come cromosoma del sesso due cromosomi X. Un cromosoma X viene trasmesso dalla madre, l’altro dal padre. Dato che il padre ha solo un X, tutte le sue figlie hanno lo stesso cromosoma X. Si possono, dunque, analizzare e confrontare i cromosomi X delle sorelle. Se le sorelle hanno un cromosoma X compatibile, il padre con molta probabilità (superiore al 99%) è lo stesso.
possiamo vedere ( in modo approssimativo ) come si diversificano i DNA parentali nell'allontanarsi delle generazioni
Ad ogni generazione il corredo genetico del padre e della madre si mescolano in modo casuale. Di conseguenza, ogni erede condividerà casualmente il 50% del patrimonio genetico con ciascun genitore. ATTENZIONE : come abbiamo visto pero' il 50% del 50%
Quindi ad ogni generazione il grado di affinità con ciascuno dei rami si dimezza. I gemelli omozigoti soli costituiscono un caso particolare, perché il loro corredo genetico è identico. Come abbiamo già detto, per la biologia non esiste la parentela affine, ma solo quella tra consanguinei.
Può essere utile sovrapporre allo schema precedente un numero che esprime la percentuale di patrimonio genetico che due individui A e B condividono.Si vede bene che ad ogni salto generazionale il numero si dimezza. Va sottolineato che il grado di parentela tra fratelli è 50, perché vi sono stati due rimescolamenti indipendenti del DNA dei genitori. Sarebbe 100 dal punto di vista del DNA solo per gemelli omozigoti, cioè perfettamente identici. DNALe moderne tecniche di analisi sono in grado di misurare il grado di somiglianza di due DNA, che si esprime in centimorgans (cM). Senza addentrarci nel significato di tale unità di misura, diciamo solo che il numero scende rapidamente con la distanza di parentela: tra padre e figlio è circa 3500 cM, mentre tra cugini di primo grado scende a 874 cM. Inoltre, a causa del rimescolamento casuale del DNA, ci si aspetta una certa variabilità nella somiglianza, dunque i valori ammissibili sono compresi tra un minimo ed un massimo, con una media più probabile. La tabella seguente mostra i valori attesi per i diversi gradi di parentela.
biologia : dal bel sito della famiglia SIRTOLI
Lo Y-DNA subisce una mutazione ogni 100-150 anni . Con lo stesso andamento nei 200.000 -300.000 anni dalla comparsa del genere umano , equivalgono a circa 2000 mutazioni Considerando poi che e' molto difficile pensare ad un unico Adamo primordiale ................
e' giusto essere consapevoli che probabilmente chi si sottopone all'analisi in questa fase collabora solo alla costruzione del futuro Avra' forse la gratitudine delle generazioni future ma al momento e' un volontario che paga per esserlo, ed ha in cambio dei risultati di una probabilita' incerta
La prima cosa da sapere, ben spiegata in un video di Vox, è che le aziende come MyHeritage non sequenziano (leggono) completamente il genoma dei loro clienti, ma solo una sua piccolissima parte. Sequenziare il genoma di una persona, cioè tutto il suo DNA, costa circa un migliaio di euro, dunque più di un’analisi di MyHeritage. Inoltre è utile solo fino a un certo punto, dato che il DNA di due diversi esseri umani qualsiasi è identico per più del 99 per cento. Ciò che questi test guardano sono alcuni specifici polimorfismi a singolo nucleotide (SNP), cioè dei punti in cui un gene di un gruppo di persone si distingue dal gene corrispondente di tutte le altre persone per una sola base azotata, cioè per uno solo di quei mattoncini – indicati con le lettere A, C, G e T – che formano il DNA.
by https://www.ilpost.it/2020/01/12/test-dna-origini-antenati/ ( attenzione non si parla di Y-DNA) Ci si può fidare dei test per l’analisi del DNA che si comprano su internet? Sono quelli che sostengono di poter dare informazioni sui propri antenati analizzando un po' di saliva: la risposta breve è no di Ludovica Lugli gennaio 2020
L’inutilità dei Test del DNA delle Origini : i risultati delle analisi danno solo indicazioni probabilistiche, che sono facilmente equivocabili e a volte del tutto prive di significato scientifico
Per comprendere l'attuale STATO DELL'ARTE ( molto arretrato in verita' ) invito a leggere l'articolo contenuto in questo THREAD IAGI https://iagiforum.info/viewtopic.php?f=46&t=24244 06 LUGLIO 2021 Caccia al Dna di Leonardo: identificati 14 discendenti viventi ( nel senso che discendono dal fratellastro=fratello solo da padre) Decenni di ricerche documentali sull'albero genealogico hanno permesso di ricostruire 21 generazioni, dal 1331 a oggi Grazie a un nuovo e più completo albero genealogico della famiglia, la ricerca del Dna di Leonardo Da Vinci ha fatto un balzo in avanti, arrivando a identificare 14 discendenti viventi. Il risultato del lavoro, pubblicato su Human Evolution e frutto di decenni di ricerche documentali, ricostruisce di padre in figlio 21 generazioni, dal 1331 a oggi, e aiuterà a ricostruire il profilo genetico del genio rinascimentale. Nel 2016 erano già stati individuati 35 discendenti viventi di Leonardo, ma erano perlopiù indiretti, frutto di parentele parallele anche in linea femminile, come nel caso più noto del regista Franco Zeffirelli. "Non erano dunque persone che potevano darci informazioni utili sul Dna di Da Vinci e in particolare sul cromosoma Y, che viene trasmesso ai discendenti maschi e rimane quasi invariato per 25 generazioni", ha spiegato Alessandro Vezzosi, autore dello studio e fondatore del Museo Ideale Leonardo da Vinci. I discendenti - La svolta potrebbe arrivare ora dai nuovi discendenti diretti in linea maschile (derivanti dal padre ser Piero e dal fratellastro Domenico) e attualmente in vita. "Hanno un'età compresa tra uno e 85 anni, vivono non proprio a Vinci, ma in Comuni limitrofi fino alla Versilia e fanno mestieri comuni, come l'impiegato, il geometra, l'artigiano", ha precisato Vezzosi. Le ricerche - Il Dna dei discendenti sarà analizzato nei prossimi mesi per contribuire alle ricerche della task force internazionale "The Leonardo Da Vinci DNA Project", presieduta da Jesse Ausubel (della Rockefeller University di New York) e sostenuta dalla Fondazione Richard Lounsbery. Il progetto coinvolge il J. Craig Venter Institute di La Jolla, in California, e diverse altre università e centri di ricerca di alto profilo, tra cui il Dipartimento di Biologia dell'Università di Firenze diretto da David Caramelli.
il senso di questo articolo spiega e capovolge in un certo senso completamente la questione dice oggi E' LA RICOSTRUZIONE DELL'ALBERO GENEALOGICOche aiuta a studiare lo Y-DNA ( notare bene Y-DNA non DNA autosomico ) piuttosto che il contrario
A rinforzare lo schema presentato dalla ricerca su LEONARDO le cose dette da MYHERITAGE vanno completamente nel senso dello articolo si Leonardo con un messaggio chiarissimo nella sua vaghezza : È raccomandato eseguire l'analisi su ulteriori membri della famiglia. Ciascuno dei componenti della tua famiglia trasporta porzioni specifiche di DNA che insieme possono svelare la storia della tua famiglia. Eseguendo l'analisi di uno o entrambi i tuoi genitori puoi ottenere informazioni aggiuntive riguardanti le tue Corrispondenze DNA. Per esempio sarai in grado di scoprire se ciascuna corrispondenza è sul lato paterno o su quello materno. Eseguire l'analisi di genitori, fratelli, cugini e altri parenti è anche molto utile per scoprire ulteriori parenti e per avere maggiori informazioni sulle tue corrispondenze. A causa della natura dell'eredità genetica, i tuoi fratelli potrebbero ottenere risultati di etnia differenti da te. Confrontare i vostri risultati può aiutarvi a scoprire di più sulla vostra ascendenza. by MyHeritage
Quindi solo esaminando moltissimi menbri che appartengono con certezza ad uno stesso albero genealogico patrilineare posso cercare di rintracciare elementi di Y-DNA comuni a tutti i soggetti , fissandoli ed utilizzandoli come indici di appartenenza a quell'albero
DNA autosomico Mt -DNA Y- DNA
I GRUPPI SANGUIGNI NON SERVONO A MOLTO NELL' INDAGINE GENEALOGICA I gruppi sanguigni altro non sono che il tipo di sangue che ognuno di noi eredita direttamente alla nascita. Ne esistono di 4 tipi: lo zero (0), A, B e AB divisi ulteriormente in base alla presenza o meno di un antigene, il fattore Rhesus, nome derivante dalla specie di primati sui quali venne trovato la prima volta. la distribuzione di tali gruppi varia a seconda delle diverse zone del mondo. L’Rh positivo è facilmente riscontrabile nel sangue degli europei e con le migrazioni è stato “esportato” negli altri continenti. In Europa si possono evidenziare tre principali fasce di distribuzione: una prevalenza del gruppo A nel Nord Europa, Europa Centrale e Italia, prevalenza del gruppo 0 e nuovamente Gruppo A nella parte meridionale. Ovviamente queste percentuali tendono sempre di più a modificarsi con l’aumentare dei flussi migratori.
tratto da https://www.donatori-sanmarco.it/gruppi-sanguigni-diffusione-nel-mondo/ |
RICOSTRUZIONE DELLA STORIA FAMILIARE E DELLA QUOTIDIANIETA'
Attendite ad petram unde excisi estis Riflettete sulla roccia da cui siete stati tagliati . Riflettete sulle vostre origini: RICORDARE IL PASSATO SOLO PER COSTRUIRE UN FUTURO MIGLIORE E PER DARE UN SENSO ALLA VITA IL DEBITO VERSO I NOSTRI MORTI E' QUELLO DI RICORDARLI . E' PAGANDO QUESTO DEBITO CHE INSEGNEREMO AI NOSTRI FIGLI A CONSERVARE E TRASMETTERE ANCHE IL NOSTRO RICORDO PERMETTENDO ANCHE A NOI DI SCAMPARE AL NULLA COSMICO , PERMETTENDO ANCHE A NOI DI NON MORIRE PER SEMPRE, PERMETTENDO ANCHE A NOI DI LASCIARE UNA PUR MINIMA TRACCIA L'UTILITA' SOCIALE , DI CONSERVARE IL RICORDO DELLE VICENDE DEL SINGOLO, E' INVECE NELL'ESSERE QUESTO UN MODO DI CONTROLLARE LA VERIDICITA' DELLE VICENDE DELLA MACROSTORIA COSI COME CI VIENE RACCONTATA DAGLI STORICI.
GARANTIRE CIOE' UNA PIU' VERIDICA CONOSCENZA DEI FATTI
E QUINDI IN DEFINITIVA LA VERIDICA RICOSTRUZIONE DI UNA ESPERIENZA COLLETTIVA E DEI SUOI EFFETTI , COSTRUITA ATTRAVERSO MIGLIAIA DI STORIE
vale l'aforisma :
Tempo presente e tempo passato sono entrambi presenti nel tempo futuro....e il tempo futuro è contenuto nel tempo passato" ............T.S. Eliot
le vicende di ogni persona (vicende familiari--MICROSTORIE ) ) si svolgono tra gli effetti e gli incroci con la MACROSTORIA , cioe' le conseguenze delle scelte dei cosidetti GRANDI ( quelli che spesso finiscono nei libri come protagonisti e piu' spesso che non si creda ci finiscono inadeguatamente e indegnamente ) e le storie locali ,quelle piu' vicine a noi
Cosi la ricostruzione della storia familiare o anche di un cognome chiede amore per la storia macro e micro ) e quindi la capacita' di leggere e di ricostruire la storia politica , economica , sociale cioe' delineare il palcoscenico in cui si sono mossi i nostri antenati-
Questo per capire meglio , per intuire le opportunita' e le difficolta' , per comprendere i recinti morali ,religiosi , intellettuali in cui erano costrette e confinate le loro scelte e le loro azioni
Quindi ,nella nostra ricostruzione , ogni storia familiare o di un cognome deve compiere un itinerario , nel corso dei secoli, dai luoghi di origine del cognome , ai luoghi delle emigrazioni con spostamenti regionali , nazionali e oltrenazionali
chiede insomma un lungo sguardo sulla MACROSTORIA e uno attento sulle vicende locali
Cosi la storia di ciascuno di noi diventa un modo di interpretare e comprendere meglio la MACROSTORIA e di verificare la sua ricostruzione . Tante microstorie convalidano quanto si scrive della MACROSTORIA o all'opposto lo pongono in dubbio In questo senso si dice che la storia familiare e' AUSILIARIA alla MACROSTORIA
Cio' che avrebbe quindi senso e utilita' per un individuo assume una valenza per la collettvita' Forma una memoria collettiva avvalorata da una gran quantita' di singoli episodi - La ricostruzione di un mosaico La conoscenza dei possibili errori commessi nel passato E' lo storico che c'e' in noi che alla fine fa scoccare la scintilla 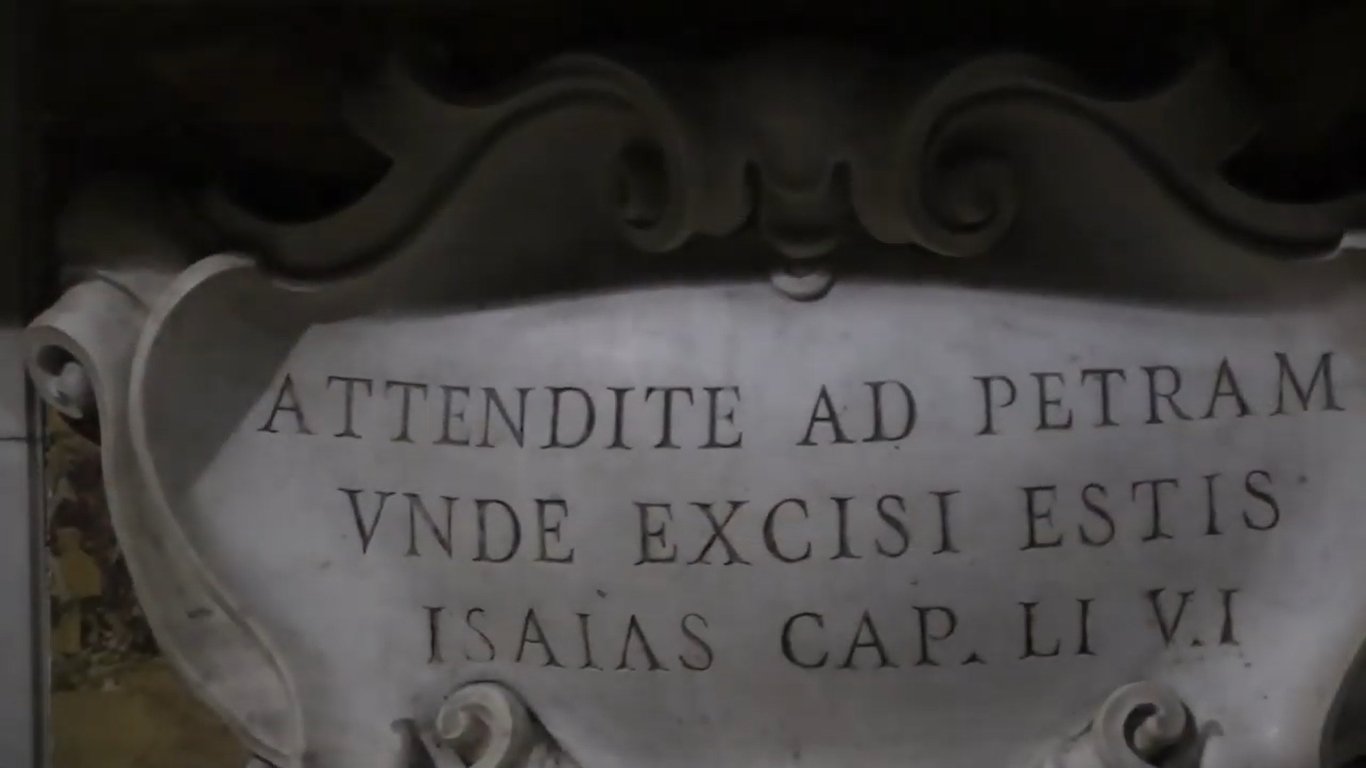
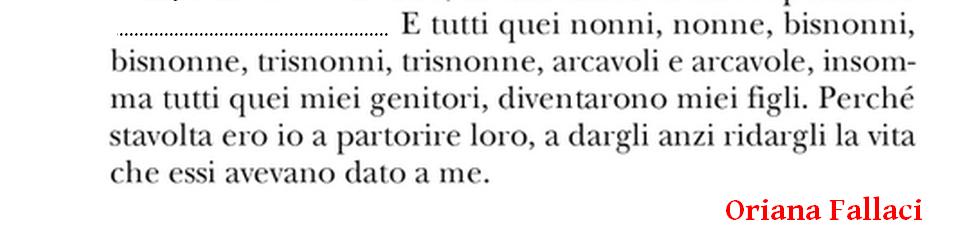
|
STORIA DI FAMIGLIA
La genealogia non e' fine a se stessa , viaggia in parallelo con la ricostruzione della storia famigliare
La ricostruzione genealogica quindi non puo' e non deve andare disgiunta dalla ricostruzione della storia familiare Un albero genealogico non puo' essere solo un elencazione di nomi e date ma deve dare carne agli scheletri , deve restituire le loro vicende umane Questo concetto cosi basilare ( e cosi estremamente trascurato da molti ) lo appresi nei miei inizi dall'amico avv. Roberto Celentano ed ho sempre tentato di applicarlo
un buon genealogista non puo' esimersi dallo studiare la storia dei luoghi scenario delle vite degli uomini e delle donne investigate Un modo di dare una consistenza corporea ed intellettuale alla sequenza dei nomi di un albero genealogico
Tutte le famiglie seguono percorsi sociali comuni nel corso dei secoli arricchiscono, impoveriscono , si nobilitano , emigrano da un luogo all'altro, cambiano mestiere, si accolturano, o si decolturano,........
Anche sul sito Antenati dei Beni culturali : La ricerca delle proprie origini e la ricostruzione della propria storia familiare mira, in primo luogo, a rintracciare le affinità e relazioni parentali. Ma la ricostruzione del filo genealogico, della tavola degli ascendenti per quarti e dell’albero genealogico di una famiglia, non rappresenta che il primo passo per avanzare nella conoscenza dei propri antenati, che diventa più profonda e ravvicinata attraverso la ricerca di documenti che ne testimoniano i modi di vita, il grado di istruzione, i luoghi dove essi hanno abitato e hanno trascorso la loro esistenza, le professioni e i mestieri che hanno esercitato, etc. Dalle loro storie particolari può scaturire un quadro complesso e articolato della società italiana attraverso le generazioni.; dal sito considerazioni dal portale ANTENATI
una realta' che deve conoscere chiunque voglia occuparsi di ricerca genealogica e' questa
"Se si disponesse della genealogia autentica ed esatta di ciascuna famiglia, e' piu' che verosimile che nessun uomo sarebbe stimato o disprezzato in virtu' della sua nascita. Infatti, non v'e' mendicante per le vie che non risulterebbe discendente diretto di qualche uomo illustre, ne' un solo nobile elevato alle piu' alte dignita' dello Stato, degli ordini e dei capitoli, che non scoprirebbe tra i suoi antenati una quantita' di gente oscura. Supponiamo che un gentiluomo d'alto rango, tutto gonfio d'orgoglio per la sua alta nascita, si vedesse passare in rivista sotto gli occhi l'intera serie dei suoi avi, un po' come Virgilio fa contemplare a Enea tutti i suoi discendenti. Da quali contrastanti passioni non sarebbe agitato, vedendo, nello spazio di quattro millenni, un alternarsi continuo, magari a brevi intervalli, di condottieri e di pastori, di ministri di Stato e di artigiani, di principi e di bifolchi?! Da quale tristezza o da quale gioia non si sentirebbe prendere alla vista di tutti gli scherzi della sorte: di fronte a uno spettacolo cosi variopinto, fatto di cenci e di porpore, di strumenti di lavoro e di scettri, di insegne di onore e di marchi d'obbrobrio?! Quale flusso e riflusso di speranze e di timori, di trasporti di gioia e di mortificazione non verrebbe a patire, via via che la sua genealogia gli apparisse brillante o tenebrosa?! Ma se il nostro gentiluomo, gia' cosi fiero dei suoi avi, riuscisse a rientrare in se', considerando con occhi di filosofo tutte queste vicissitudini, non ne sarebbe piu' affatto turbato. Le generazioni dei mortali, alternativamente illustri e abiette, si cancellano, si confondono e si perdono come le onde di un rapido fiume: nulla puo' arrestare la corsa del tempo, che trascina seco cio' che sembrerebbe piu' fermo e imperituro, e lo inghiotte per sempre nella notte eterna". ( voce Genealogia di De Jancourt ----Encyclopedie----Diderot e D'Alembert )
Vi prego caldamente di leggere anche questo estratto da un
intervento del prof Alfeo Giacomelli - Università di Bologna, che mi ha onorato della sua amicizia ,
Estratto un po’ lungo ma molto arricchente per chi ama la geneologia
LA STORIA EDUCHI ALLA PACE , ALLA GIUSTIZIA SOCIALE , ALLA TOLLERANZA :
Non si deve mai dimenticare che la Storia dovrebbe esser ben conosciuta e dovrebbe essere maestra di vita, rappresentando in senso collettivo l'ESPERIENZA che ci evita di rifare i medesimi errori nel futuro
E' difficile perdonare i soprusi e le violenze ma si possono perdonare a patto di ricordarle anche quando il lupo tende a travestirsi da agnello e finge di belare
Cosi non si deve dimenticare che tante sofferenze e ingiustizie che hanno patito i nostri antenati sono legate a strutture sociali ingiustificabili ed arcaiche avallate da una Chiesa cattolica che e' stata per lunghi secoli ( XVI XVII XVIII ) stampella di queste strutture e strumento di obnubilazione delle menti I ritardi culturali della nostra Nazione vengono da lontano . Dal mix esplosivo di dominio spagnolo e Chiesa cattolica Un mix di intolleranza e di superstizione , di potere nobiliare e pretesco , che cercava disperatamente di ancorare al passato mentre un'altra parte del mondo correva verso il futuro
Con mille e mille intelligenze condannate alla persecuzione e costrette ad aver paura della propria intelligenza Con uomini ipocriti e stupidi che soffocarono Galileo , Newton , Darwin e tanti come loro per secoli , ed asservirono lo splendida intelligenza italica al rosario e al servilismo Con uomini ipocriti e stupidi che inventarono l'inferno in terra ed in cielo
Almeno tre secoli della nostra storia recente sono stati sciupati in un neo-feudalesimo cato-nobiliare anacronistico Prigionieri della superstizione mentre la scienza trionfava
LA DIVINA PROVVIDENZA ha lavorato benissimo a favore di quella minoranza di privilegiati che hanno saputo sedersi sin da subito nei posti migliori , in virtu' della prepotenza, dell'intrigo e della furbizia LA DIVINA PROVVIDENZA ha lavorato meno bene per quella maggioranza di derelitti che ha lavorato per mantenere comodi la minoranza di privilegiati e ha visto morire negli stenti i propri figli ed ha subito l'ingiustizia della GIUSTIZIA DEI POTENTI NON DIMENTICATEVI MAI DI COME E' STATA USATA LA DIVINA PROVVIDENZA DAI PRETI E DI CHE ARMA POTENTE SIA CONTRO I DEBOLI e sempre allegri bisogna stare che il nostro piangere fa male al Re , fa male al RICCO , al CARDINALE diventan tristi se noi piangiamo A volte vi e' piu' scienza in una canzonetta che in un trattato di storia
LA STORIA FAMILIARE ( microstoria ) aiuta a comprendere meglio tanti aspetti del passato ( macrostoria ) ....................................... La ricerca genealogica non dovrebbe mai essere disgiunta dalla contemporanea ricostruzione della storia familiare La mia opinione personale e' che la microstoria familiare e' indispensabile per verificare la STORIA che viene scritta sui libri Esaminare le condizioni di vita , le abitudini ,la cultura della societa', le diseguaglianze sociali , i mestieri , la durata della vita,le migrazioni , .... ci permette di aggiungere elementi alla disanima storica a dare maggiori verita' ( o smascherare menzogne ) alla STORIA che gli storici di professione studiano e ci raccontano Nelle nostre ricerche c'e' sempre un germe di verita' Ed infatti questo e' oggi chiarissimo agli storici La " prosopografia " si aiuta con la genealogia e la ricerca familiare per ricostruire il volto dei ceti dirigenti per definire meglio la societa' e le problematiche sociali Questo solo per dire che ricerche come le nostre fatte da storici di professione gia' da tempo hanno una loro dignita' scientifica Spetta a noi dimostrare la validita' scientifica e l'utilita' anche dei nostri studi da appassionati la storia è fatta più delle piccole semplici persone che dai grandi, perché parafrasando Trilussa, l'1 cresce d'importanza più sono gli 0 che ha appresso, nel senso che nessun grande della storia sarebbe grande se non ci fossero stati tanti "piccoli" a seguirlo. Ma, purtroppo, la storia attualmente non è di questo avviso, e ciò crea grandi errori nella storia, anche in pagine importantissime, che continuano ad essere raccontate in maniera totalmente inventata e differente dalla realtà.(Kaharot --Tuttogenealogia ) ............................................... Condurre ricerche sui propri antenati richiede l’acquisizione di conoscenze specifiche e la capacità di saper interpretare con spirito critico le fonti primarie a disposizione. Offre l’opportunità di ritrovare le memorie familiari e il loro intersecarsi con le vicende storiche apprese sui banchi di scuola e di approfondire la conoscenza delle motivazioni interiori che hanno spinto le persone a compiere determinate scelte.
|
|
Verso la metà del 1700 al nord nobiltà e clero avevano circa i 2/3 di tutte le terre coltivabili, al sud addirittura i 9/10. Il livello dell'agricoltura era molto basso e la tecnica primitiva. |
|
Io ho preferito la ricerca sul cognome che ritengo piu' "storica" e molto piu' utile nei suoi aspetti politici, sociali ,economici, storici (cioe' ritengo il campione preso in esame (che ha come indice comune il cognome ) di molto maggior interesse di un campione privo di un elemento unificante di un certo valore ) : La casuale parentela non puo' dare valore particolare al campione , perche' in definitiva siamo tutti parenti. E neppure la storia di un singolo ramo familiare Ho quindi svolto una ricerca su tutte le persone che portano il cognome Carnesecchi legati o meno a me da un rapporto di parentela Come detto un cognome uguale non vuol dire sempre uno stipita comune
Dicono gli esperti che i cognomi italiani sono oltre 360.000. Quindi si dovrebbero avere oltre 360.000 ricerche ognuna delle quali comprendente piu' gruppi parentali ( casati ) omonimi Disegnando cosi una grandissima storia del cognome
Quando lo storico parla di famiglia spesso commette l'errore di porre l'attenzione solo a quella parte che appartiene al ceto dirigente e non a quella che raccoglie le bricciole. Ma un CASATO ( cognome e y-dna) non e' mai un unicum ma e' composto di famiglie piu' ricche e piu' povere
Piu' o meno legate fra loro da considerazioni politiche e sociali a seconda le convenzioni e le necessita' dei tempi
Delinea la mentalita' nobiliare che estranea i poveri e la sovente trascuratezza degli storici nel seguire il destino dei casati nel loro complesso e seguirne le salite e le discese cioe' il profilo altimetrico economico nei secoli dei vari rami di un casato Profilo a volte legato ad handicap individuali ma altre a scelte economiche e politiche A supplire a questa carenza potrebbe servire quella branca della storia che e' la GENEALOGIA e la STORIA FAMILIARE, cioe a legare microstorie con grande storia Trovo interessante , in particolare per questo aspeto, il lavoro di Claudia Tripodi che studiando il declino di un ramo degli Spini ha messo in evidenza meccanismi sociali ed economici troppo poco sottolineati Questa trascuratezza ha spesso privato lo storico di indizi importanti per la ricostruzione della grande storia Ed i lavori di Sergio Tognetti nel seguire anche se pur per breve lasso di tempo i Serristori e il banco Cambini Ancor oggi comunque alcuni storici vedono la caduta alla condizione contadina come una vicissitudine impossibile per una famiglia mercantile mentre questo pare contraddetto da diverse realta' vale sempre e comunque : ed il rischio di errori per omonimia
E’ ovvio che avere uno stesso cognome non vuole sempre dire avere antenati in comune (omonimia )
|
UN ERRORE : FARE RICERCA FAMILIARE PER DESIDERIO DI NOBILTA'
Ogni famiglia ha una quantita' di storie seminascoste nelle pieghe del tempo , che sarebbe bene preservare all'oblio
E' in questa preservazione dei ricordi il valore della ricerca familiare
La nobilitazione di qualche membro aggiunge talvolta meno di altri episodi
Soffriamo pero' di riflessi condizionati
Per troppo tempo siamo stati abituati a pensare che il nobile fosse una sorta di essere superiore
Durante i secoli XVI XVII XVIII in Italia si e' via via affermata una cultura imposta dai ceti nobiliari e favorita dai regimi monarchici
Una visione del mondo subdola che legittimava la diversita' tra gli uomini
Che concedeva a taluni dei privilegi e ad altri solo dei doveri
Che imponeva dei recinti sociali
La religione ci metteva del suo, insegnando rassegnazione e pazienza, agitando la nebbia della superstizione per chiudere occhi e menti alla ragione
La proto-nobilta feudale aveva il disprezzo che ha il guerriero verso l'imbelle o il pacifico
Credeva che la pricipale qualita' dell'uomo fosse il valore guerriero
E questo concetto e' riaffermato anche da Federico II
Non credo sia possibile affermare che quella proto-nobilta' era completamente cristiana solo perche' osservava certi formalismi cristiani mentre e' piu' facile definirla barbaro-cristiana
Per la nobilta' dei secoli xvii e seguenti
La cosa si fa piu' profonda direi una profonda e falsa consapevolezza di superiorita' il disprezzo verso il villano si fa strutturale e ramificato , La nobilta' diventa qualcosa quasi di genetico : la nobilta' e' una sorta di razza all'interno della compagine comunitaria predestinata da un dio a governare la societa' cosi come e' il Re ad avere un diritto divino
Ancor peggio ! mi pare
Cosi viene instillato nel popolo profondamente che e' quello che vuole Dio , che tramare contro il re o l'ordine sociale e' come andare contro Dio .....................
Non credo che questo faccia parte della religione cristiana delle origini
In mezzo ci sta sempre la gerarchia della Chiesa cristiana che dovrebbe filtrare, obiettare , correggere ........
"Siamo tutti fratelli "e' una posizione netta
Strada facendo turandosi un poco il naso ti adegui ad una piu' comoda posizione grigia
lo storico che ti osserva ne deve prendere semplicemente atto e dirlo
RISULTATO
Io credo nella funzione sociale della STORIA, ed e' per questo che prendo una posizione sulla questione
Abbiamo alle spalle 70.000 anni di storia umana . di cui 2000 anni di Cristianesimo eppure dietro l'angolo vi sono ancora forti pensieri di barbarie
Il poeta :
Sei ancora quello della pietra e della fionda,
uomo del mio tempo........................
Ci sono delle basi da demolire
io sono pienamente convinto che il ceto nobiliare dal secolo XVI alla rivoluzione francese ha scritto una fantastoria parallela alla realta storica
E vorrei provare a dimostrarlo
Nello stesso tempo considero la filosofia nobiliare una cosa di origine barbarica con esaltazione della forza , della irragionevolezza , della guerra , dell'odio
Solo forse con questo Papa la Chiesa comincia a prendere le distanze ma prima e' stata del tutto connivente
Bisogna cominciare a costruire una societa' nuova mettendo in discussione queste cose
Nella natura del razziatore la voce che predomina e' la violenza , violenza che deve incutere paura
E viene tenuto in maggior conto il guerriero e la sua mancanza di timore della morte
Il disprezzo della vita altrui
di conseguenza lo stupro , la rapina , il bottino , il riscatto
la fedelta' al capo
la fratellanza col compagno d'armi
l'uomo pacifico e' disprezzato come un vile , che non e' capace di difendersi
Molte similitudini col regno animale dove la vita del branco e' regolata con principi molto simili
Jean Claude Maire Vigueur ha dimostrato come molte nostre idee sulla cavalleria medioevale fossero false e come in realta' la cultura del cavaliere fosse quella dell'odio e della sopraffazione, della vendetta
Non certo il protettore dei deboli o degli indifesi o degli orfani e delle vedove ( ne parleremo )
E la frase "comportamento cavalleresco" spesso sia una pesante mistificazione del vero
Dal Libro d'oro della nobiltà di Sarzana, ricopiato a mano nel 1763 dai fratelli Federico e Vincenzo Grossi (con disegno degli stemmi, e prima che l'originale venisse bruciato sulla pubblica piazza nel 1797), ristampato anastaticamente in 1110 esemplari a Sarzana nel 1991, sezione Origini del blasone, capitolo I:
..sia però quantosi vuole augusta la nascita, bisogna ognor sovvenirsi che la Nobiltà, considerata in origine da primi nostri Progenitori non ha fra gli Uomini quel gran divario, quanto talvolta si crede
Si Pater est Adam, et Mater est omnibus Æva,cur non sunt omnes nobilitate pares?'..."
Se il Padre è Adamo, la Madre per tutti è Eva , perché non tutti sono per Nobiltà uguali?
Gli uomini sono tutti uguali
Non sono tutti uguali per le loro abilità. Vi è chi è più intelligente chi più forte chi più coraggioso
Sono tutti uguali per le loro debolezze. Tutti si ammalano si deprimono soffrono invecchiano muoiono
I gagliardi gli astuti finiscono allo stesso modo dei gracili e degli scemi pasto ai vermi o al fuoco
Mi creda non esiste ( fortunatamente ) una razza eletta ( la natura non la prevede )
Siamo un granello combattivo nell' universo
Non penserà davvero che sia un titolo nobiliare avuto trecento anni fa da un nostro antenato a far la differenza
Non crederà davvero alla razza eletta o al diritto del sangue
IL MITO ( POCO CRISTIANO !!! ) DELLA NOBILTA'
DERIVA da paure ed abitudini
Da secoli di lenta coercizione fisica e psicologica , da secoli di rassegnazione ed infine di ammirazione verso il potere
Il POTERE e la CHIESA alleati , FORZA e SUPERSTIZIONE
C'e' voluta una rivoluzione e la ghigliottina e il sangue , per scuotere il giogo , ma non e' bastato a seppelirne il fascino in alcune menti fragili o inconsapevoli
E' CONUNQUE ILLOGICO CHE LA CHIESA CHE PROCLAMA L'UGUAGLIANZA DEGLI UOMINI ANCORA NON AUTODENUNCI UNA SUA ALLEANZA DI SECOLI CON L'INEGUAGLIANZA
by https://diventarenobile.weebly.com/cosegrave-la-nobiltagrave.html
spiega un concetto banale :
Nel mio lungo girovagare tra nobiltà e ordini cavallereschi, più volte ho avuto modo di ascoltare aristocratici avventori di improvvisati cenacoli nell'atto di dare dell'oggetto "nobiltà" definizioni che, quand'anche logicamente conseguenti a determinate impostazioni di vita, da subito mi parvero tratteggiare personalità evidentemente oppresse da una certa visione razzista dell'esistenza, o purtroppo affette da gravi e conclamati disturbi narcisistici della personalità tali da suggerire la frequentazione di Centri di Igiene Mentale piuttosto che di ordini cavallereschi.
Così, un certo marchese forse un poco confuso in merito alle differenze che passano tra un cane di razza e un essere umano, ebbe a sostenere che la nobiltà era quel gruppo di uomini che costituiva, a seguito di selezionati incroci, "il meglio che l'umanità potesse produrre per il governo di se stessa e la corretta gestione delle cose terrene".
Una certa contessa, poi, in preda ad evidente delirio mistico-razziale, riteneva normale affermare pubblicamente che i nobili sarebbero "un ceto di eletti da Dio". Così come Gesù Cristo era di stirpe nobile poichè di schiatta davidica e dunque discendente da un re, parimenti tutti i nobili sarebbero, secondo lei, indistintamente e per diritto di nascita chiamati a comandare a causa di una oggettiva superiorità divina che, tra le altre cose, risulterebbe immediatamente evidente nel gusto superiore, nel garbo, nell'educazione oltre che nella fisionomia delicata e nel biondismo così frequenti, diceva lei, tra gli aristocratici.
Ora, senza dover fondare la definizione di un tema così importante su casi umani degni delle migliori cliniche psichiatriche, comunque un certo qual senso di superiorità per diritto di nascita è chiaramente, anche se pudicamente, presente in tutti coloro che ci tengono a frequentare la nobiltà facendone parte.
................
La percezione di sè stessi assolutamente trionfalistica risulta poi viepiù incrementata dal fatto che la loro posizione presuntivamente superiore è ottenuta per nascita, dunque senza sforzo, senza pericolo che sia loro tolta da chicchessia, e senza che qualcun altro estraneo alle famiglie "buone e giuste perchè nobili" possa secondo loro acquisirla stante il fatto che "la nobiltà oggi è un ceto chiuso".
Ma è davvero un ceto così "chiuso"?
Per risolvere il problema dobbiamo tornare al punto di partenza. Che cos'è dunque questa cosa così ben custodita, da molti desiderata, e ancor più invidiata, chiamata "nobiltà"?
Cosa sia la nobiltà è presto detto: la nobiltà è uno "status", ossia una particolare posizione giuridica , acquisita in vari modi, e da cui possono discendere diritti e doveri. E' dunque una posizione sociale, variamente riconosciuta e tutelata dagli ordinamenti giuridici degli Stati, al pari di una qualunque altra posizione sociale ritenuta dai legislatori degna di essere, se non protetta, quanto meno considerata.
Da ciò appare evidente, anche al primo sguardo, la natura per nulla mistica o supereroica del nobile. Spogliato dei propri falsi convincimenti di una presunta oggettiva superiorità, nobile è il più delle volte colui che ha ereditato certi diritti dal proprio avo senza merito alcuno, secondo precise leggi di successione, così come una qualunque persona può ereditare dal proprio padre una proprietà immobiliare, o una macchina, o un qualunque diritto rientrante nel patrimonio giuridico del proprio dante causa.
Allo stesso modo di un qualunque diritto, poi, lo status di nobile può essere acquisito in vari modi tutti parimenti legittimi e fondati. La modalità più frequente oggigiorno, almeno in Italia, come dicevamo è quella per via successioria dal proprio avo, stante anche l'incommerciabilità dei titoli nobiliari conferiti nel nostro Paese. Questo vuol dire che, quasi sempre, in Italia è nobile colui che eredita il titolo o lo status nobiliare dal proprio padre, o comunque da un proprio parente prossimo.
Altro caso di nobilitazione, in verità assai infrequente, è l'investitura di un titolo nobiliare "ex novo". da parte di un sovrano legittimo attualmente sul trono e dunque a capo di una nazione riconosciuta dal consesso degli Stati, come è il caso della Spagna, del Regno Unito, del Belgio, In questi casi il titolo è acquisito originariamente, senza il passaggio da un dante causa che non sia il monarca creatore "ex novo", in forza dei propri diritti sovrani, di un nuovo titolato.
La terza modalità di acquisto di un titolo nobiliare è, udite, udite, un regolare contratto di compravendita. In Scozia, infatti, si conserva ancora oggi quello che fu uno dei più diffusi modi di acquisto di un titolo nobiliare prima della Rivoluzione Francese, ossia la vendita da chi un titolo ce l'ha a favore di un acquirente che non lo ha, ottenendone il corrispettivo di una somma di denaro come contropartita della cessione né più né meno diversamente di come noi facciamo di solito quando comperiamo una casa, un bene mobile o un qualunque altro diritto su un qualunque oggetto. In merito a questa specifica modalità di acquisizione della nobiltà, troverete a breve su questo sito una pagina appositamente dedicata ad indicare chiaramente procedura, prezzo, e nominativi di intermediari a cui rivolgersi se intenzionati a procedere.
Quest'ultimo sistema di acquisto della nobiltà, seppur declinato in vari modi e con alcuni limiti e necessari assensi dell'autorità monarchica a seconda delle epoche e dei vari ordinamenti statuali, chiarisce ancora di più, qualora ce ne sia bisogno, che la nobiltà non è nient'altro che uno status, un diritto, una posizione considerata dall'ordinamento, che taluni acquisiscono alla nascita, mentre altri la conquistano nel corso della vita.
Inoltre appare evidente la stretta connessione tra l'acquisizione dello status di nobile e il necessario investimento di denaro per ottenere tale status. Lo ripetiamo: quando ancora l'aristocrazia era un ceto dinamico ed aperto, l'idea di comperare un titolo era del tutto normale, e non suscitava affatto le risatine ignoranti e le strizzatine di occhi già normalmente piccoli e inespressivi a cui sovente, oggi, dobbiamo assistere quando qualcuno afferma in pieno diritto di avere comprato un regolare titolo nobiliare. E ciò è tanto vero che, volendo tralasciare la diffusissima pratica della compravendita di titoli nobiliari negli Stati di Antico Regime, ancora nella più recente legislazione nobiliare del Regno d'Italia erano previste salatissime imposte di registro per l'uso dei titoli nobiliari, segno evidente che senza esborso di denaro il più delle volte non c'è nobiltà!
Volendo tirare le somme del nostro ragionamento, la nobiltà non è niente di mistico e, soprattutto, è qualcosa che ancora oggi si può comperare, al pari di come è stata comperata nei secoli passati da molte di quelle famiglie da cui provengono, magari senza saperlo, le "contesse" e i "marchesi" di cui parlavamo all'inizio.
Chiarito ciò, e diradate un poco le fitte brume dell'ignoranza e del razzismo, nelle pagine seguenti di questo sito verrà indicato come, oggigiorno, si può diventare nobile in maniera del tutto legittima e giuridicamente fondata.
Con l'avvento della Repubblica nel 1948, nel nostro Paese i titoli nobiliari hanno perso ogni rilevanza legale, tuttavia si stima che ogni anno circa 20mila italiani siano disposti a investire somme considerevoli pur di avere l'illusione di “trasformarsi” in principe, duca, marchese, conte, visconte, barone, patrizio o cavaliere.
Insomma: pur non valendo un’acca, il titolo c’è chi ancora lo ostenta e chi, non avendolo, cerca di acquisirlo fintamente alimentando un ricco mercato internazionale.
by Adalgisa Marrocco
In Italia è legalmente e praticamente impossibile acquisire un titolo nobiliare, se non per discendenza ( ???) , e a tale richiesta stanno rispondendo siti internet stranieri.
Il più delle volte si tratta di piccole o grandi truffe.
E' piu' che curioso il fatto che gli Italiani risultano essere il popolo che di più aspira ad acquisire un titolo nobiliare e vantare cosi un titolo, anche privo di valore legale.
POI
LA NOBILTA OGGI CHIEDE DI AVER IL PORTAFOGLIO GONFIO
UN NOBILE SENZA SOLDI RISCHIA DI ESSERE MOLTO O UN POCO RIDICOLO COMUNQUE UN OGGETTO CURIOSO
COMUNQUE UN CONCETTO VUOTO MA MOLTO BEN INCULCATO NELLE ANIME SEMPLICI
tratto da Elite e Distinzione Pier Felice degli Uberti
Dall’albore dei tempi troviamo le prime riflessioni sull'uomo espresse nei miti, dove l'uomo primitivo, la natura, la vita, la storia e tutto ciò che lo circonda, appare come un turbinio di immagini senza senso e il mito diventa quindi un modo per ordinare e conoscere la propria realtà. Da sempre incontriamo un uomo che vuole essere diverso e distinto dagli altri che appartengono alla sua stessa società. Le grandi religioni presentano il maestro come un esponente della leadership: limitandoci a ricordare le religioni oggi esistenti incontriamo Buddha, discendente della casta dei guerrieri Sakya;Masè, un israelita della tribù di Levi, salvato dalla ?glia del faraone e reso parte della corte, a cui viene consegnata la Legge e af?dato il compito di condurre il popolo ebraico attraverso il deserto fino alla Terra Promessa; Gesù della tribù di Giuseppe, un discendente di re Davide; Maometto appartenente ad un importante clan di mercanti da cui discesero poi grandi dinastie; e persino nello Scintoismo la dea Amaterasu intraprende la conquista del regno terrestre inviando una serie di messaggeri sulla terra; e il dio del tuono, Take-mika-zuchi, conquista per lei il regno terrestre, il cui governo fu affidato al nipote della dea, Ninigi, antenato degli imperatori del Giappone, disceso sulla terra con cinque capi (antenati delle famiglie sacerdotali).
Da sempre dentro 1’uomo è insito il raggiungimento di una distinzione che lo renda superiore agli altri esponenti della società, e se l’appartenenza alla stirpe dei maestri delle religioni è limitatissima, al contrario troviamo dal1”epoca greca per un certo numero di famiglie l’aggregazione a forme organizzate come l’aristocrazia, ovvero una forma di governo nella quale poche persone (che secondo l'etimologia greca del termine dovrebbero essere i “migliori”) controllano interamente lo Stato. Il termine nei secoli diventò sinonimo di altre aggregazioni umane, e questa è stata assieme alla monarchia, tra le forme di governo più diffuse in Europa negli ultimi secoli, generalmente sotto forma di monarchia costituzionale, dove il potere del sovrano e controllato da un parlamento composto da soli nobili. Il desiderio di distinzione è ben rappresentato dal termine nobiltà che ha un duplice significato: indica sia uno status privilegiato riconosciuto dall’autorità, sia l'insieme dei soggetti che beneficiano di tale condizione. Il termine nobile deriva dal termine di lingua latina nobilis, che significa “onorevole”; la nobiltà è una aggregazione amplissima e a seconda delle epoche storiche può avere diverse connotazioni non sempre correttamente classificabili.
Nel tempo assistiamo al passaggio dalla nobiltà personale all’ereditaria, a quella chiusa a poche famiglie, alla trasformazione della nobiltà in una onori?cenza premiante generalmente ereditaria (da Napoleone). L'accesso alla nobiltà che era una classe aperta è ammesso a favore di alcune famiglie nuove, anche se in numero ristretto e secondo norme regolarmente stabilite. Un concetto di distinzione molto più aperto lo troviamo nella cavalleria, che, utilizzata soprattutto in età antica e nel medioevo, costituiva anche la classe nobiliare della società. La cavalleria medievale divenne un ideale di vita a cui gli uomini di quel tempo si ispiravano. Negli anni trenta del XX secolo si sostenne che all`inizio dell’XI secolo lo sviluppo e la diffusione di signorie di banno, incentrate sui castelli, e su rapporti reciproci avevano contribuito ad alimentare una crescente cerchia di specialisti della guerra, formati dai signori e dai loro vassalli. Il mestiere di cavaliere andò sempre più specializzandosi, circoscrivendosi a una élite ristretta che diede vita a una cerimonia di iniziazione del cavalierato, che contribuì alla percezione della cavalleria come gruppo limitato.
Marc Bloch in La società feudale, Torino, 1974, scrive: “Tra il XII e il XHI secolo essa, definendosi in un ceto chiuso a base ereditaria, passa dalla condizione di “nobiltà di fatto”, ovvero dall`organizzazione in forme aperte e ?uide, alla condizione di 'nobiltà di diritto”. Alla tesi di Bloch che sostenne che la cavalleria si fosse costituita come emanazione della condizione nobiliare, Jean Flori ha eccepito un'altra teoria, del tutto opposta, che considerava la cavalleria come una professione alla quale la nobiltà si avvicinò e della cui dignità, col tempo, si appropriò. Il mestiere del cavaliere era inizialmente stato riservato a persone di estrazione variegata e anche di umile origine, come dimostra l'etimologia del termine knight, derivante da cnith che designava il “servitore”.
Solo nel XIII secolo, anche attraverso la formazione di un’etica e di un codice di comportamento del cavaliere, il cavalierato e la carica nobiliare conoscono una chiara sovrapposizione. Fu in quest`epoca che si diffuse la pratica dell”adubement che assegnava alla cavalleria il significato di “ordine” ristretto ed esclusivo. La grande importanza della cavalleria lasciò una profonda traccia nella nostra società tanto che ancora oggi alcuni paesi (Italia compresa) usano il titolo di cavaliere come onori?cenza.
Riguardo alla popolazione l’Europa non ha radici di un solo tipo: l`antica e nobile civiltà celtica, la grande tradizione greco-romana, il Rinascimento, l'Illuminismo, la Rivoluzione francese hanno lasciato sul corpo del continente tracce profonde e importantissime, non inferiori a quelle prodotte dall`influsso giudaico-cristiano, ma per le elite le radici sono rappresentate dall'aristocrazia, dalla nobiltà e dalla cavalleria, tanto forti nella nostra storia, che però oggi nella società multimediale non e più chiaro cosa possano ancora rappresentare. Trattando questi argomenti dobbiamo limitarci solo al concetto di élite perché queste tematiche sono prive di interesse per le masse, ma al tempo stesso dobbiamo comprendere bene che l°aristocrazia, la nobiltà e la cavalleria del passato sono ormai estinte per il mutamento dei tempi avvenuto in l'Italia da almeno 70 anni, e sebbene con una percentuale di meno del 0,2% della popolazione, rivivono nella realtà dei fatti solo a livello di rievocazione storica, perchè i discendenti dell`aristocrazia e della nobiltà sono oggi ormai distanti dal peso sociale e dal vuoto “privilegio” di cui godevano durante il regno d'Italia.
......................................
in Italia ci sono oltre 7.500 famiglie nobili ( sangue blu) per un totale di 78mila persone, le quali si concentrano tra Firenze, Milano, Venezia, Roma e Napoli.
ALMENO DUE TERZI DI QUESTE HANNO MENO STORIA DA MOSTRARE DI QUELLA DELLA FAMIGLIA CONTADINA DEI FRATELLI CERVI , QUELLA DEI FRATELLI PARTIGIANI
IN DEFINITIVA LA NOBILTA ERA LA TAPPA FINALE DEL CONSEGUIMENTO DELL'ARRICCHIMENTO (SENZA BADARE TROPPO A COME LO SI ERA CONSEGUITO)
Osservo che spesso nei forum si chiedono notizie della nobile famiglia X
Questa domanda presuppone un errore , a meno che coscientemente non si vogliano notizie solo dei rami aristocratici
Non esiste la nobile famiglia X
Esiste una famiglia cognominata X discendente da un certo stipite che nell'albero ha rami nobili e rami plebei e non e' detto che i rami nobili abbiano maggior storia dei rami plebei
Era uso nei secoli XVII e XVIII recidere i rami poveri dall'albero genealogico : ci si vergognava di condividere lo stipite con gente che puzzava di stalla
Oggi ha poco senso, anzi....
il concetto di nobilta' e' un concetti abbastanza moderno posteriore a Carlo Magno
concetto che finisce per legarsi al possesso e al controllo ereditario di un territorio
Prima di allora vi era il concetto di valore guerriero e di antichita' della famiglia , quasi un debito di gratitudine che la legava ai padri fondatori : il patriziato
|
IL LUNGO CAMMINO DI UN CONCETTO CHE HA DOMINATO LA STORIA DEGLI ULTIMI SECOLI E NE HA INFLUENZATO LA VISIONE
IL GENERE UMANO AMBISCE ALLA DIVERSITA' UNO DEI BISOGNI FONDAMENTALI DELL'UOMO E' DI SENTIRSI IMPORTANTE
Con l'avvento della Repubblica nel 1948, nel nostro Paese i titoli nobiliari hanno perso ogni rilevanza legale, tuttavia si stima che ogni anno circa 20mila italiani siano disposti a investire somme considerevoli pur di avere l'illusione di “trasformarsi” in principe, duca, marchese, conte, visconte, barone, patrizio o cavaliere. Insomma: pur non valendo un’acca, il titolo c’è chi ancora lo ostenta e chi, non avendolo, cerca di acquisirlo fintamente alimentando un ricco mercato internazionale.
Se la gente sapesse cosa fu veramente la nobilta' questa perderebbe molto del suo fascino, e molti cesserebbero di desiderarla
GLI ITALIANI SANNO CHE COSA E' STATA REALMENTE LA NOBILTA' ? DIREI DI NO
la prima vera considerazione da fare e' il contenuto di violenza e di sopraffazione che contiene la parola e che ha contenuto per tanto tempo Poi si puo' ragionare sul piano filosofico e sociale
Io ritengo che definire la nobilta' sia una cosa impossibile , (Bartolo da Sassoferrato ) perche' e' un concetto variabile di luogo in luogo , di tempo in tempo , E' quasi impossibile che nella parola"nobilta" siano contenuti gli stessi concetti quando a pensarla e a pronunciarla sono due persone diverse A DIRE IL VERO SONO GLI STORICI AD AVER SPESSO ALIMENTATO LA CONFUSIONE
QUESTIONE DA SOFISMI IL CONCETTO DAL LATO PRAGMATICO QUESTIONE CHIARISSIMA : POTERE SOCIALE Infatti ritengo che definire la nobilta' sia una cosa impossibile essendo un minestrone di interessi sociali ed economici , come dimostrano i fatti , ma leggerla nella sua veste premiale sia piu' semplice La nobilta' fa sempre capo ad una fons honorum di cui segue il destino Cioe' quando vi e' uno Stato principesco internazionalmente riconosciuto questo ha una capacita' premiale insindacabile E uno e' nobile solo se e' riconosciuto tale dal Principe: investito o confermato Nessuno puo' autoproclamarsi nobile C'e' alla base un principio di fidelitas insoprimibile anche quando viene tenuto in cantone
E' la Fons honorum che ha il controllo del territorio , che fissa i paletti , che impone le eccezioni , che convalida le successioni E se la Fons honorum perde il controllo del territorio decade ogni sua concessione . E competera' alla nuova confermare , investire ex novo , togliere o ignorare
Insomma non c'e' mai continuita' automatica nel titolo nobiliare Uno che e' nobile in un luogo non e' nobile in un altro lugo Inoltre a dire il vero : i nobili degli stati preunitari ed erano confermati nel Regno d'Italia violavano il giuramento feudale di FIDELITAS
interessante questa interpretazione austriaca sulla materia :
Patriziato veneziano Patriziato veneziano_Renzo _De_Rosas
PER NON AVER PROBLEMI SOFISTICI io guardo solo alla storia familiare e considero la nobilitazione di un ramo di una famiglia come un episodio di una complessa vicenda che interessa un intero albero genealogico Quindi non sono interessato ai meccanismi della nobilitazione e tengo solo conto che un ramo da un certo momento aveva ufficialmente lo status del nobile , con i privilegi e gli oneri Ho sempre espresso l'opinione che gli uomini rispetto agli skill -abilita' non siano tutti uguali ( differenza di intelligenza--di forza--di potere--....... ) ma siano tutti uguali nel dolore , nella malattia, nella sofferenza ,nella delusione........
Anche la nascita del concetto e' opinabile I Longobardi non avevano il concetto E' col contato coi Franchi e poi coi Germani che inizia
ORIGINI DELLA NOBILTA' ITALIANA
Prima di tutto bisogna chiarire che la nobilta' italiana e' per la maggior parte di formazione molto molto recente e pochissime sono le famiglie che possono vantare un capostipite con funzioni dirigenti tra IX e XI secolo, con possessi feudali tra IX e XI secolo Per cui parlare di nobilta' feudale italiana e' prima di tutto parlare di un insieme quasi vuoto di famiglie La nobilta' italiana ha stipite per un certo numero di famiglie nel XII e XIII e XIV PER LA MAGGIORPARTE NEI SECOLI XVI E XVII e successivi
by tratto liberamente da TRECCANI Le aristocrazie di Giuseppe Albertoni - Storia della civiltà europea a cura di Umberto Eco (2014) Il contributo è tratto da Storia della civiltà europea a cura di Umberto Eco, edizione in 75 ebook
........................ Particolarmente significativo da questo punto di vista è il caso dei Franchi, che con le loro conquiste influenzeranno profondamente le strutture sociali altomedievali. Come altri popoli germanici, essi sono caratterizzati da una gerarchia basata sulla distinzione tra liberi, gli unici a costituire in senso proprio il populus, e i servi, persone in condizione di dipendenza, perlopiù prive di personalità giuridica.
Accomunati da un unico status giuridico, i liberi tra i Franchi e altri popoli “barbarici” non costituiscono, però, un gruppo omogeneo da un punto di vista sociale, dal momento che si differenziano in base ai possessi fondiari, alle capacità militari e, soprattutto, alla vicinanza al re. Sono proprio i liberi “prossimi” al re a costituire il gruppo sociale preminente, i “grandi” del regno, la cui identità aristocratica è determinata dalla funzione, ma non è definita da un punto di vista giuridico. Basti pensare, per esempio, che nella Legge salica (Pactus legis salicae), la legge dei Franchi promulgata da Clodoveo attorno al 510, non solo non compare alcuna nozione di nobiltà – non si dimentichi d’altra parte che lo stesso termine nobilis per tutto l’alto Medioevo è impiegato soprattutto in un’accezione assai generica, in riferimento perlopiù a qualità morali – ma non è previsto nemmeno alcun guidrigildo (valore patrimoniale della persona) che distingua i nobili dagli altri liberi. ...................... Composti da liberi di varia condizione sociale che si distinguono dai servi principalmente per il diritto/dovere di prestare servizio militare nell’esercito regio, i Franchi, come altri popoli “barbarici”, quando danno vita a un proprio regno in territori già parte dell’Impero romano d’Occidente, da un punto di vista politico-amministrativo si pongono in continuità con la tradizione precedente.
Nel Regnum Francorum, per esempio, molti esponenti dell’aristocrazia senatoria gallo-romana sono mantenuti nelle loro funzioni e non sono rari i casi di apparentamento con rappresentanti dell’aristocrazia franca. Anzi, è proprio il loro modello di aristocrazia a rivelarsi vincente e a essere assunto dai Franchi, tra i quali ben presto può appellarsi vir illuster, distinguendosi dagli altri liberi, solo chi detiene un ufficio (carica pubblica). Questi “uomini illustri”, che come i conti (comites) avevano compiti di giurisdizione civile e militare, costituivano un’aristocrazia di ufficio, superiore rispetto a quella dei liberi che a livello regionale erano riusciti ad assumere una posizione di preminenza soprattutto grazie alle loro proprietà fondiarie. È proprio tra questi “nobili di ufficio” che emerge una famiglia – i Carolingi – destinata a modificare, tra le molte cose, anche la composizione dello stesso ceto aristocratico.
L’età carolingia: un’aristocrazia “imperiale”
A partire dal VII secolo i Carolingi riescono a rendere ereditaria la principale carica del regno franco, quella di “maestro di palazzo” o “maggiordomo”, che prevedeva il controllo delle terre demaniali (fisco regio) e dell’esercito. Nella loro ascesa favoriscono l’allargamento del ceto eminente attraverso il vassallaggio, grazie al quale legano a sé numerosi guerrieri, uomini liberi perlopiù di condizione medioalta che, in cambio della fedeltà militare, ricevono dei beni fondiari a titolo vitalizio (“benefici”, solo dalla fine del secolo IX “feudi”) decisivi in molti casi per la loro ascesa sociale.
È tra questi fedeli che i Carolingi, assunto il titolo regio nel 751, scelgono le persone alle quali affidare importanti cariche (honores), pubbliche o ecclesiastiche. Ciò avviene in particolare nell’età di Carlo Magno quando gradualmente anche nel regno longobardo, conquistato nel 774, e nel ducato di Baviera, conquistato nel 788, i principali “uffici” sono assegnati a “fedeli” del re, appartenenti perlopiù a famiglie aristocratiche dell’area posta tra il corso del medio e basso Reno, della Mosa e della Mosella, dalla quale i Carolingi stessi provenivano. Si viene a costituire, in tal modo, un’aristocrazia “imperiale” assai ramificata, con beni e incarichi sparsi in regioni molto lontane tra loro, anche se di primaria importanza per l’identità familiare rimane il luogo d’origine. A questa aristocrazia appartengono, per fare solo alcuni esempi significativi, il prefetto di Baviera Gerold (morto nel 799) – esponente di un’importante famiglia del medio Reno – e il duca del Friuli Eric (morto nel 799), anch’egli di origini medio-renane, nominato da Carlo Magno al posto del duca longobardo Rotgaudo (morto nel 776), promotore di una drammatica sollevazione antifranca.
Un nuovo modello etico
Gerold ed Eric sono ricordati nelle fonti contemporanee per il loro eroismo – entrambi muoiono in guerra, nella difficile campagna contro gli Avari –, e per la loro fede cristiana, attestata da donazioni a importanti abbazie. In particolare Eric è celebrato dal patriarca del Friuli Paolino II di Aquileia, uno dei principali fautori della rinascita carolingia, in un celebre “lamento funebre”. Proprio alcuni intellettuali carolingi, come Paolino o Alcuino di York, in trattati e lettere elaborano dei principi etici per l’aristocrazia imperiale, alla quale è proposto un nuovo modello comportamentale, in cui la violenza è dichiarata lecita solo se volta alla difesa della cristianità. Non si dimentichi, d’altra parte, che tutti gli esponenti dell’alto clero in questa fase storica sono a loro volta di origine aristocratica. Lo stretto legame tra l’aristocrazia carolingia e la Chiesa è attestato dalle donazioni pie e dalla fondazione di chiese e abbazie “private”, volte a mantenere in vita la memoria familiare e ad ancorarla a un’istituzione ecclesiastica.
I clan familiari
L’aristocrazia imperiale carolingia è costituita da un numero relativamente ristretto di “clan familiari”, dalla struttura parentale fortemente ramificata, che raramente prevede diritto di primogenitura e che, pur in un quadro patrilineare, procede anche per via femminile quando i matrimoni creano parentele con gruppi familiari di maggiore importanza. In questi “clan” hanno rilevanza in particolare le parentele costituite per via orizzontale, tanto che la loro ricostruzione in base alla struttura dell’albero genealogico spesso può essere fuorviante, separando ciò che dai contemporanei era percepito come un legame coeso. La complessità di questi gruppi familiari è attestata dal fatto che sono perlopiù privi di un nome, assegnato loro solo dagli studiosi moderni. La memoria familiare si trasmette nell’onomastica, con la ripetizione in diverse generazioni dei nomi degli antenati e, non raramente, con l’“invenzione” di capostipiti illustri. Sarà da questi ampi clan parentali, la cui gerarchia è data anche da eventuali parentele con i Carolingi, che saranno scelti i re dei regni “eredi” dell’Impero carolingio.
Casate, castelli, cavalieri
Pur mantenendo una struttura ampia e ramificata, l’aristocrazia imperiale carolingia nella seconda metà del IX secolo inizia a perdere il suo carattere “internazionale” e ad ancorarsi territorialmente. Si tratta di un processo favorito dalla capacità che molti signori hanno di rendere ereditaria la loro carica, perlopiù quella comitale. Sono proprio le “dinastie comitali” nell’immediata età postcarolingia, caratterizzata dalla crisi del potere regio, ad assumere in molti casi l’effettivo controllo del territorio a livello regionale o locale. Il loro potere, però, spesso deve confrontarsi con quello di signori fondiari che, pur privi di ufficio, sono riusciti ad approfittare dell’indebolimento del potere pubblico per dar vita a proprie forme di dominio sul territorio (signoria territoriale). È in questo contesto di frammentazione dei poteri che si afferma una nuova aristocrazia, caratterizzata dalla dimensione locale, rappresentata visivamente dai molti castelli che proprio dal X secolo iniziano a costellare le campagne e che spesso alle nuove casate danno il proprio nome. Fondamentale per l’affermazione dei nuovi signori di castello si rivela la presenza di eserciti privati, fondati sul giuramento vassallatico. Il servizio richiesto ai vassalli si specializza sempre più nel combattimento a cavallo, che in questa fase assume una rilevanza crescente anche grazie alla diffusione di nuove tecniche militari, come la carica con la lancia in posizione orizzontale. Ciò permette l’emergere di una nuova élite militare, costituita da cavalieri che col loro servizio non raramente riescono a compiere un’importante ascesa sociale. Ben presto i cavalieri eminenti vengono a costituire un unico gruppo sociale con i signori di castello che, a loro volta, fanno proprie le tecniche di combattimento cavalleresche. Sarà proprio dall’incontro e dalla sovrapposizione tra la cavalleria e l’aristocrazia che si svilupperà la nobiltà del pieno e del basso Medioevo, la quale inizia a definirsi sempre più anche da un punto di vista giuridico, chiudendosi verso il basso, e ad assumere un’identità ben espressa dallo stemma e dal sigillo familiari.
Nobilta by Claudio Donati Enciclopedia delle scienze sociali (1996) Chi si proponga di fornire una definizione della nobiltà che ne consideri al tempo stesso le caratteristiche strutturali e l'evoluzione storica, deve preliminarmente prendere atto della pluralità di accezioni di tale concetto. Ad esempio, 'nobiltà' ha significato e continua a significare una qualità positiva di carattere spirituale, intellettuale, morale, ma anche fisica, propria dell'uomo e però estensibile a qualunque altra realtà (un animale, una pianta, una pietra preziosa, un luogo). Nell'ambito dell'antropologia politica, il concetto di nobiltà in questa accezione è stato spesso usato come sinonimo di aristocrazia, per indicare un ceto dominante ristretto ai 'migliori' per forza fisica, capacità intellettuali, ricchezze, attitudine al comando. In un senso più specifico e in connessione alla storia europea dall'antichità all'età moderna, col termine 'nobiltà' si intende una particolare condizione giuridica e sociale, legata al possesso spesso ereditario di onori e privilegi esclusivi, e per estensione l'insieme degli individui, delle famiglie e dei 'corpi' dotati di tale status privilegiato. A quest'ultimo significato farà riferimento la presente trattazione. Dalla nobilitas romana alla nobiltà cavalleresca del Medioevo Il termine nobilitas derivante dal verbo cognosco e perciò legato all'idea di notorietà comparve a Roma nel corso del IV secolo a.C. per indicare il gruppo politico dominante, costituito dalle famiglie i cui membri avevano raggiunto le cariche supreme della Repubblica. Si trattava in teoria di una élite aperta, per accedere alla quale bastava percorrere la carriera politica fino al vertice. In realtà per i cosiddetti homines novi non era facile farsi strada: è stato calcolato che più dell'ottanta per cento dei consoli uscirono da famiglie già consolari, e quindi appartenenti alla nobilitas. C'è inoltre da considerare che, oltre che a questa egemonia nell'esercizio del potere politico supremo, la nobiltà era associata all'idea di ricchezza. È stato tuttavia sottolineato dagli studiosi che il titolo di nobilis era a Roma puramente onorifico e non veniva regolato dalla legge; in altre parole, non esisteva un riconoscimento giuridico della condizione di nobiltà, che era determinata e definita solo dalla tradizione. Presso i popoli germanici, che diedero vita sulle rovine dell'Impero romano d'Occidente a quelle formazioni politiche comunemente note come regni romano-barbarici, non esisteva un concetto analogo alla nobilitas romana: la lingua tedesca conserva ancor oggi, per definire il nobile e la nobiltà, i termini antichi Edel e Adel, che non si prestano ad accostamenti etimologici con le forme latine e sembrano essere completamente isolati nell'ambito indoeuropeo. Queste differenze linguistiche erano presumibilmente una spia di situazioni politiche e sociali molto diverse: se a Roma la nobiltà comprendeva un gruppo di famiglie che per tradizione consolidata esercitavano le supreme magistrature dello Stato, presso i popoli germanici era decisivo, per la determinazione dello status di nobile che veniva a coincidere con quello di uomo libero, il carisma derivante dal valore guerresco e dalla capacità di mobilitare al proprio seguito un gruppo numeroso e solidale di compagni armati. L'incontro e il confronto con la mentalità e le situazioni romane e lo stanziamento in regioni già appartenute all'Impero d'Occidente determinò una parziale modifica della fisionomia originaria dei popoli germanici: a seguito di questa trasformazione, le aristocrazie militari assunsero il carattere di aristocrazie fondiarie, mentre l'antica struttura politico-militare delle assemblee di guerrieri progressivamente si disgregò nell'anarchia dei singoli potentati locali. Quel che tuttavia rimase costante per gran parte del Medioevo fu il principio di ascendenza germanica, in base al quale la professione militare era il segno distintivo della supremazia sociale. Nell'immagine tripartita della società, diffusa dai chierici a cominciare dall'XI secolo e destinata a lunga fortuna, agli oratores (chierici e monaci) e ai laboratores (contadini e ministeriali) erano contrapposti non i nobiles, ma i bellatores (cioè i guerrieri, definiti anche milites). Dunque, portare le armi significava automaticamente appartenere alla cerchia dei domini e dei loro seguaci, in contrapposizione alla massa dei rustici, all'imbelle vulgus disarmato e sottomesso al banno signorile. Da questo punto di vista un uomo d'armi, per quanto di origine modesta, finiva per acquisire un modo di pensare e uno stile di vita molto simili a quelli del signore di cui era al servizio. Ciò non significa che la nozione di militia, che indicava una professione, si confondesse e si identificasse immediatamente con quella di nobilitas, legata a una condizione: perché ciò avvenisse, occorrevano circostanze specifiche, che si verificarono tra il XII e il XIII secolo ed ebbero come teatro principale l'area francese e fiamminga. A questo riguardo, è significativo che in lingua d'oïl il termine noble non ebbe almeno fino al Duecento alcuna connotazione di tipo giuridico né alcun esplicito riferimento alla nascita e neppure un richiamo diretto all'esercizio delle armi. Come il corrispettivo latino nobilis, esso si limitava a indicare nel linguaggio comune una condizione sociale elevata: come sostenne lo storico francese Marc Bloch, il termine nobile indicava semplicemente "in mancanza di qualsiasi accezione giuridica precisa, una preminenza di fatto o di opinione, secondo criteri quasi sempre variabili". L'unico dato costante, derivato dalla tradizione romana, era il parallelismo tra nobiltà e ricchezza. Più confuso e non univoco era il rapporto con una ininterrotta e prolungata ascendenza di sangue, sia per i limiti della memoria genealogica, sia anche perché l'assenza di leggi in materia rendeva superflua la rivendicazione di un potere ereditario documentato. La svolta si ebbe appunto a partire dalla fine del XII secolo, grazie a una serie di fattori concomitanti: la compilazione delle coutumes, cioè delle raccolte di diritti consuetudinari delle singole regioni, in cui l'idea di una nobiltà giuridicamente definita in base alla nascita trovò una prima manifestazione organica; l'introduzione da parte della monarchia delle cosiddette patenti di nobiltà (lettres d'annoblissement), con cui si conferiva uno status privilegiato a uomini distintisi nel servizio regio; la fortuna delle opere aristoteliche, e in particolare della Politica, da cui era possibile trarre l'identificazione della nobiltà con la discendenza da antenati illustri e ricchi (virtus generis et antiquae divitiae, secondo una formula che ritroviamo nel Convivio di Dante); la diffusione della letteratura genealogica, in parallelo con la moda dei poemi cavallereschi. Questi ultimi erano a loro volta la manifestazione di quello che molti studiosi considerano il fattore decisivo della trasformazione duecentesca, cioè la diffusione e la formalizzazione dei riti della cavalleria attraverso i quali, e in particolare l'adoubement (consegna delle armi), la nobiltà trovò il modo di definirsi sul piano giuridico come una classe militare, animata da valori e ideali comuni, e dotata di privilegi trasmissibili ai propri discendenti. Più controversa è la funzione che, nella formazione dell'ideologia nobiliare-cavalleresca, avrebbe svolto la dottrina cristiana, e più in generale la cultura ecclesiastica. Ma le pur documentate e perduranti diffidenze e incomprensioni reciproche tra mondo dei chierici e mondo dei milites non possono oscurare un dato fondamentale: il fatto cioè che con le crociate (come scrisse lo storico austriaco Otto Brunner) "il vitale impulso dei ceti nobili all'espansione e alla conquista, che fino a quel momento si era consumato nelle lotte intestine, viene ora posto al servizio della cristianità". L'affermazione di una cultura cavalleresca che aveva come connotati distintivi la virtù e l'onore e si esplicava nella difesa del proprio sovrano, delle donne e dei poveri, nonché nella guerra santa contro gli infedeli, procedette dunque di pari passo con l'emergere e il consolidarsi di un ceto ereditario di milites, che nei riti cavallereschi, nel possesso del feudo e nel legame vassallatico trovava la sua legittimazione giuridica, e che proprio grazie alle sue funzioni militari rivendicava una serie di privilegi nei confronti dell''uomo comune'. Si può affermare in conclusione, sulla base di numerosi e convergenti studi relativi soprattutto all'area francese, che la nobiltà emerse come classe giuridicamente definita nella tarda età feudale e caratterizzò con la sua presenza la struttura politica e sociale dei secoli dell'antico regime. By Claudio Donati ---prima parte ------segue
Contraddicono questa ultima interpretazione sulla cultura cavalleresca i recenti studi di di Jean Claude Maire Vigueur Cultura dell'odio e della violenza..........
Un libro fondamentale , che con 10 euro cambiera' il vostro modo di vedere e capire un momento cruciale della storia d'Italia del centro-nord Nota bene : Storia che e' diversa da quella dell'Italia del sud e dal resto dell'Europa
Trascurando la civilta' egizia che vide nel Faraone un dio in terra La grande parentesi romana ci spinge a perlare di "aistocrazia" e non di nobilta' Goti e Longobardi premiavano il valore guerriero Il concetto di "nobilta" era un concetto del nord Europa Quindi anche il concetto di nobilta' e' un prodotto d'importazione perche' non esisteva il Longobardia L'Italia di quel periodo era fatta di un miscuglio longobardo romano goto.... in cui si distingueva l'uomo libero dal servo senza implicazioni di fedelta' vassallatica E dove probabilmente vi era una mobilita' sociale che poteva per il tempo essere notevole da una generazione all'altra attraverso attitudini guerriere Con Carlomagno, nonostante tra i Franchi esistesse un concetto di nobilta' , i Marchesi e i Conti erano semplicemente funzionari che amministravano una Marca o una Contea Di fatto l'epoca di Carlomagno e' caratterizzata da -----spopolamento ----incapacita' di controllo del potere centrale sui domini loci ----invasioni e razzie ungariche ----carestie ----politicamente Anarchia del potere e formazione di poteri locali : inesistenza di un potere centrale e domini loci . Non viene mai messo in discussione il potere dei potentati locali "italiani" ----In questo senso Carlomagno assomiglia ad un padrino mafioso. Si appoggia ai poteri dei "domini loci" in un patto di non aggressione e di accettazione dello stato quo ___Dalla caduta dell'Impero romano non vi sara' mai piu' un potere centrale in Europa Solo con l'avvento degli Ottoni e il consolidamento dei confini contro le invasioni inizia un inversione di tendenza dovuta alla percezione di una maggior sicurezza ------comincia una lenta crescita demografica ---- continua e si rafforza il potere dei domini loci con addirittura l'usurpazione di titoli di "comes" . Autoproclamazioni negli atti notarili esercito personale e razzie tra vicini . Gli incastellamenti iniziano intorno all'anno 1000 . Probabilmente il castello va esaminato sotto questa luce : le eta' delle invasioni ungare sono finite...................................... Inizia a entrare in ITALIA IL CONCETTO DI NOBILTA' CHE CI ERA ESTRANEO senza trovare contrasto in una religione cattolica in lotta coi Longobardi
Tre forze locali: Monarchie dinastiche in germe Vescovi Dominis loci : conti e visconti nel distretto cittadino
CENNI STORICI
Oltre ai Conti stabiliti da Carlo Magno, vi erano, al principio del secolo IX, molti possessori di terre feudali, ricevute cioé come in prestito dal re, i quali già esercitavano certi diritti di autorità quasi sovrana sopra le persone, o schiavi o servi o liberi contadini, che le abitavano. Costoro spiavano tutte le occasioni favorevoli per aumentare questi loro diritti, e per ragione della debolezza dei successori di Carlo Magno, e per gli avvenimenti che poi accaddero, riuscirono ad avere anch'essi, sopra gli abitanti dei loro feudi, autorità simile a quella dei conti e anche maggiore. Così si stabilì il sistema feudale o feudalesimo, che consiste nell'esservi una moltitudine di signori, ciascuno dei quali domina sopra una determinata porzione di terreni, cioè sopra un feudo, con obbligo verso il re di un atto di omaggio, di un determinato tributo (prestazioni) e di un contingente di soldati in caso di guerra (ost o cavalcata). Spesso poi coloro che avevano grandi feudi, ne davano porzioni ad altri, i quali diventavano debitori degli stessi obblighi verso di essi; e queste divisioni furono dette feudi minori, mentre quelli ricevuti immediatamente dal re dicevansi maggiori. Il re o colui che dava un feudo si chiamava caposignore; chi lo riceveva vasso o vassallo o feudatario o uomo o milite; l'atto con cui si conferiva il feudo dicevasi investitura e l'atto con cui il vassallo dichiarava e giurava la sua fedeltà al caposignore nell'investitura e in altre circostanze dicevasi omaggio, perché si dichiarava appunto homo, cioè uomo ligio del suo caposignore. Oltre agli obblighi sopra indicati, il vassallo doveva il servizio di giustizia o di corte, che consisteva nell'andare a sedersi alla corte di giustizia del caposignore, e nel sottomettersi egli stesso al giudizio di questa corte. II vassallo era infine obbligato a dare consiglio quando questo gli fosse stato richiesto: e, in casi eccezionali, il caposignore esigeva da lui soccorsi in denaro o aiuti. Se il vassallo mancava ai suoi obblighi, si rendeva colpevole di fellonia e incorreva nella confisca del feudo. Grandissimo dal IX secolo in poi divenne il numero dei feudi e delle loro varietà; s'infeudarono persino diritti, come quello di pesca, caccia e transito sui fiumi; si infeudarono cariche, sia civili, sia militari: s'infeudarono minuzie, come lo spigolare e il racimolare; che più? s'infeudò persino l'aria ad uso dei mulini a vento, creando il feudo in aria, o feudo volante. Le stesse terre allodiali, che cioè un libero possedeva veramente, divennero quasi tutte feudi; perché i loro possessori, vedendosi privi di quei cospicui diritti che erano annessi al feudo, cedevano liberamente o vendevano a qualche feudatario le terre, a patto di riceverle di nuovo da lui come feudo; così incontravano dei doveri verso quel loro signore, ma costui tutelava il possesso dell'allodio e i diritti feudali che con l'investitura aveva acquisito. L'allodio così cambiato in feudo dicevasi feudo oblato, a differenza degli altri che dicevansi dati. C'erano in principio solo feudi maschili, ma presto ve ne furono anche dei femminili, cioè che si potevano per successione trasmettere a femmine; anzi, poi questi si moltiplicarono, quando si usò assegnarli in dote nei matrimoni. Si aveva a questa maniera una grande scala feudale: a capo di essa era il re, poi venivano i duchi, poi i conti, poi i visconti, poi i baroni, poi i castellani, poi i valvassori, poi i valvassini, i cittadini, i villani, i semiliberi o aldiori e i servi o schiavi; la nobiltà e il potere si fermavano ai valvassori, gli altri formavano il popolo. L'autorità del re, per quanto fosse in primo posto e da lui derivasse per concatenazicne ogni autorità, era nulla, solo disponeva da padrone dei vassalli a cui immediatamente aveva dato feudi; il resto non aveva nulla a che fare con lui, poiché non contano alcune prerogative regali nel campo giudiziario: molti feudatari ignoravano spesso il nome del re, anzi contro di lui avevano diritto di portar guerra, se da lui non erano immediatamente stati investiti. Troppo note sono le cattive conseguenze del sistema feudale. Attribuendo a esso la sovranità a un numero grandissimo di signori, che non avevano nei loro domini altro freno, altro limite ai loro voleri che la coscienza;
Storia d'ITALIA....ANNI 795 - 814 d.C .....................................CARLOMAGNO IMPERATORE - L'ITALIA - VENEZIA
i sovrani usarono come strumento di governo il vassallaggio, già praticato nel mondo franco di re merovingi. Per stabilire una forma di controllo sui nobili franchi e per assicurarsi il loro sostegno militare, i sovrani avevano iniziato a legarli a se attraverso il vassallaggio, un contratto sancito da una cerimonia (l'omaggio), nella quale il vassallo (il nobile) giurava fedeltà al signore e disponibilità a prestare per lui servizio armato. Il signore in cambio gli dava protezione e gli concedeva un beneficio, che poteva essere l'assegnazione di un terreno oppure di un incarico da cui derivare un reddito. Nel corso degli anni, la natura delle cariche feudali aveva subito profonde modifiche. Inizialmente il beneficio (che non era, come si pensa, la concessione di terre bensì il compenso o la concessione patrimoniale elargita dal re-senior al vassallo) e l'ufficio (cioè la dignità) feudale venivano concessi solo nei termini temporali del legame vassallatico e, di conseguenza, alla morte del vassallo i suoi benefici tornavano nelle mani del sovrano che, di solito, le riassegnava ai discendenti dei vassalli. Si era, dunque, in presenza di un'ereditarietà di fatto, se non ancora di diritto, degli uffici feudali. il tempo lavorava a favore dei Conti e già nell'843, Carlo il Calvo, appena diventato re di Francia, era stato costretto a promettere di revocare un feudo non "in base al capriccio", bensì solo in seguito "ad un giudizio rispondente a giustizia ed equità". La situazione indeboliva il potere del sovrano, che si vedeva sottrarre funzioni pubbliche, tanto più quando ciò riguardava gli uffici maggiori (duca, marchese, conte), implicanti il governo delle province del regno. Risultano così comprensibili sia le spinte dei feudatari a vedersi riconoscere in diritto quanto già avveniva in fatto, sia le resistenze dei sovrani, timorosi di ulteriori limitazioni ai loro poteri. Il Capitolare di Quierzy è un testo normativo promulgato il 14 giugno 877 nella città di Quierzy-sur-Oise da Carlo il Calvo. Esso non istituì, come è di comune credenza, l'ereditarietà dei feudi, ma regolò in forma quasi del tutto ufficiale una pratica già diffusa: la possibilità di lasciare il beneficium, alla morte del vassallo, in eredità ai figli. Inoltre questo atto confermò come le funzioni di conte e vassallo fossero ben differenti l'una dall'altra. L'occasione a partire dalla quale il capitolare di Quierzy fu emanato fu quella di una spedizione militare dei franchi contro i saraceni: per mezzo di esso l'imperatore Carlo il Calvo intendeva assicurare la continuità del titolo beneficiario ai signori che avessero preso parte alla spedizione. Fino al loro ritorno, queste terre non sarebbero state affidate a nessun altro, ma in caso di morte durante l'impresa, sarebbero - per l'appunto - tornate al senior che avrebbe deciso come disporne. Non di rado accadeva che queste passassero ai figli dei vecchi possidenti e poi il re, al ritorno dalla guerra ne confermasse il titolo nella natura di beneficio. Tuttavia il capitolare garantiva soltanto al beneficiario in vita (e non ai suoi eredi) la solidità del possesso fondiario. Il capitolare di Quierzy, emanato da Carlo il calvo nell'877, sancì l'ereditarietà dei feudi maggiori, pratica già concretamente in uso da un certo tempo. Il poter succedere al padre consentiva ai figli di non perdere i beni immobili, mentre per i sovrani significava avere sempre uomini al proprio servizio. Carlo il calvo venne dunque incontro alle richieste dei grandi feudatari, che volevano essere rassicurati su quanto sarebbe accaduto mentre essi erano al seguito dell'imperatore. Il risultato dell'assemblea di Quierzy fu dunque un capitolare, che stabilì i limiti entro cui il reggente poteva muoversi, garantendo lo status quo fino al ritorno del sovrano. Con il capitolare dell’877, Carlo il calvo intendeva tutelare i diritti del sovrano e dare garanzie a coloro che stavano per intraprendere con lui una campagna militare. Alcuni articoli mostrano che il potere centrale si stava logorando, perché fra carica pubblica e beneficio privato si creava sovente una pericolosa confusione. Anche se questo documento non autorizza esplicitamente la trasmissione ereditaria dei feudi, rende però evidente che tale consuetudine era ormai diffusa. . Se muore un conte, il cui figlio è con noi, nostro figlio, insieme con gli altri nostri fedeli, scelga fra coloro che gli furono più intimi e più vicini colui che con i ministeriali della stessa contea e con il vescovo dovrà amministrare la contea predetta, fino a quando noi non ne saremo informati. Se invece avrà un figlio in età minore, questi, insieme con i ministeriali della contea e con il vescovo della diocesi in cui essa si trova, amministri la contea stessa, finché di questo non giunga a noi notizia. Se però non ha figli, nostro figlio, unitamente con gli altri nostri fedeli, scelga chi deve amministrare la contea insieme con i ministeriali della stessa contea e col vescovo, finché non giungano i nostri comandi. E a questo riguardo nessuno abbia a risentirsi se daremo la contea a chi crederemo opportuno, e non a colui che nell’intervallo l’ha governata. Analogamente si farà per i nostri vassalli. E vogliamo ed espressamente comandiamo che gli abati e i conti o anche gli altri fedeli nostri cerchino di seguire le stesse norme verso i loro vassalli. I vescovi e il conte più vicino curino, tanto per i vescovadi che per le abbazie, che alcuno non sottragga le cose o i beni delle chiese, e che nessuno impedisca che ad esse si facciano donazioni. Se alcuno oserà farlo paghi secondo le leggi umane, e quindi secondo le leggi ecclesiastiche dia riparazione alla chiesa che avrà danneggiato e paghi a noi una multa grave, secondo la misura della colpa e come a noi piacerà. Se qualcuno dei nostri fedeli, dopo la nostra morte, per amor di Dio e per amor nostro, vorrà rinunciare al secoloe avrà un figlio o parente che possa giovare allo Stato, gli sia data facoltà di trasferirgli le sue cariche, secondo che giudicherà meglio. E se vorrà vivere in pace nel suo allodio [terra posseduta in libera proprietà] nessuno osi cercare di impedirglielo, e null’altro gli si chieda che di essere pronto alla difesa della patria Per quanto riguarda la successione dei feudi, la nona disposizione del capitolare stabiliva che, nel caso fosse morto un conte il cui figlio si trovasse al seguito dell'imperatore o nella minore età, il reggente non avrebbe potuto nominare un successore, essendogli solo concesso di procedere ad un'amministrazione provvisoria della contea, fino al ritorno del re. Più in particolare le procedure erano le seguenti: In caso di morte di un conte il cui figlio si trovasse al seguito dell'imperatore, il reggente avrebbe dato l'incarico di amministrare provvisoriamente la contea ai parenti più prossimi del defunto, al vescovo della diocesi in cui si trovavano i territori in questione e ai ministeriali della contea stessa, fino a quando l'imperatore non avesse disposto in proposito; Se il conte defunto avesse avuto un figlio nella minore età, questi avrebbe amministrato provvisoriamente la contea, assistito dal vescovo e dai ministeriali; Se il conte fosse morto senza figli, il reggente avrebbe nominato un amministratore della contea, che avrebbe svolto il suo compito assieme al vescovo e ai ministeriali; Il re esprimeva poi la volontà che anche i conti e i signori ecclesiastici adottassero disposizioni simili nei confronti dei loro uomini. Nella decima disposizione si stabiliva inoltre che, dopo la morte del re, se uno dei feudatari avesse voluto ritirarsi in convento, avrebbe potuto liberamente lasciare i suoi honores ai figli o ai parenti. Quando la centralità del potere regio perse la propria efficacia nell'amministrazione del regno determinando un vuoto di potere, i signori resero ereditario il beneficio che avevano ottenuto dal sovrano Dal X secolo i benefici concessi ai vassalli in cambio dei loro servizi iniziarono a essere chiamati feudi e la cerimonia veniva chiamata investitura. A differenza del beneficio, il feudo implicava per il vassallo la giurisdizione non solo sulle proprietà che gli venivano affidate, ma anche sugli uomini che le abitavano e sui beni di questi ultimi. Tra il 10 e l'11 secolo i vincoli di fedeltà e di subordinazione si estesero ulteriormente: i vassalli potevano assegnare una parte dei loro feudi a vassalli minori. Si instaurò quindi una vasta rete di rapporti personali che andò a costituire il sistema feudale. Ciò favorì l’affermarsi di una concezione patrimoniale del feudo: i feudatari cominciarono a considerarlo parte del patrimonio familiare che poteva essere trasmesso in eredità ai figli. Il potere centrale, troppo debole, non era capace di contrastare ciò, quindi fu costretto a riconoscere ufficialmente l’ereditarietà dei feudi maggiori (quelli concessi dal sovrano i vassalli) attraverso il capitolare di Quierzy nell'877. I feudi minori furono resi ereditari nel 1037 con la Costituto de Feudis. Nel 1037 sotto l'imperatore Corrado II videro riconosciuti tale prerogativa attraverso un editto noto come l'Edictum de beneficiis (in età moderna battezzato come Constitutio de feudis) che decretava l'ereditarietà dei benefici minori. L'Edictum de beneficiis regni Italici, in seguito noto anche come Constitutio de feudis, è un documento[1] emanato sotto forma di costituzione imperiale dall'imperatore del Sacro Romano Impero, Corrado II il Salico, il 28 maggio 1037 a Cremona, in concomitanza con l'assedio di Milano. Il documento viene redatto allo scopo di smorzare le ribellioni dei vassalli italiani dell'imperatore e va a regolare il diritto di successione feudale per i feudi minori. In precedenza, il diritto di successione era regolato solo per i feudi maggiori, tramite il Capitolare di Quierzy emanato, nell'anno 877, dall'imperatore franco Carlo il Calvo. Nella Constitutio de feudis vengono estesi ai vassalli minori i benefici di cui godevano i grandi feudatari del sovrano, equiparando le gerarchie feudali.
EREDITARIETA' DEI FEUDI CONCESSI
ANNO 877 Il capitolare di Quierzy, emanato da Carlo il Calvo nell'877, sancì l'ereditarietà dei feudi maggiori, pratica già concretamente in uso da un certo tempo. Il poter succedere al padre consentiva ai figli di non perdere i beni immobili, mentre per i sovrani significava avere sempre uomini al proprio servizio.
ANNO 1037 L'Edictum de beneficiis regni Italici, in seguito noto anche come Constitutio de feudis, è un documento emanato sotto forma di costituzione imperiale dall'imperatore del Sacro Romano Impero, Corrado II il Salico, il 28 maggio 1037 a Cremona, in concomitanza con l'assedio di Milano. Il documento viene redatto allo scopo di smorzare le ribellioni dei vassalli italiani dell'imperatore e va a regolare il diritto di successione feudale per i feudi minori
Il feudo concesso non è revocabile se non per giusta causa e i feudatari minori possono ora venire giudicati da loro pari e far ereditare i loro possessi ai propri figli, anche se donne o minori. Viene mantenuto un vincolo di tutela dei feudatari maggiori sui feudi dei loro vassalli (così come viene mantenuto per il reggente sui feudatari maggiori) riconoscendo ai signori il diritto di fissare una tassa sull'eredità del feudo del vassallo a lui sottoposto, conservare il controllo del feudo fino alla maggiore età dell'erede, se minorenne, o fino a che, se donna, non abbia sposato un partito gradito.
Con l'ereditarieta' dei feudi siamo di fronte alla nascita di una Aristocrazia ereditaria quasi definibile come una proto-nobilta'
Concetto di nobilta' di Federico II Il rigido concetto di nobilta' di Federico II ........Errico Cuozzo .......Federiciana 2005
La nobiltà, alla quale si accedeva per diritto di nascita, portò al consolidamento di un ceto aristocratico che traeva dal possesso della terra a titolo feudale e dall'esercizio delle connesse potestà i mezzi necessari per esercitare la militia. Federico era consapevole di ciò. Ecco perché a partire dal 1221, per potere rafforzare la sua autorità nel Regno, procedette alla revisione di tutti i titoli di possesso relativi ai beni e ai privilegi feudali e, dopo avere fatto demolire, ovvero devolvere al demanio, le fortezze e i castelli costruiti abusivamente, disciplinò tutta la complessa materia feudale. Egli iniziò col provvedere a ridefinire il servizio militare dovuto dai singoli feudi, per poter così ricostruire l'esercito regio. Ripristinata la distinzione normanna tra feuda integra e feuda non integra, fissò in 20 once d'oro la rendita annua di un feudo integro e, sulla base di questo rapporto, rese possibile la commutazione del servizio militare dovuto per un feudo con un versamento in denaro proporzionato alla consistenza del feudo posseduto (adohamentum). La lacunosa documentazione di cui si dispone ci impedisce di cogliere nei particolari l'attuazione di questo importante provvedimento che, liberando i feudatari dall'obbligo di prestare, necessariamente attraverso l'invio di cavalieri e di uomini armati all'esercito del re, il servizio militare dovuto per i propri feudi, pose le premesse per cancellare quella connotazione squisitamente militare che re Ruggero II d'Altavilla aveva attribuito alla feudalità del Regno. Di questa riforma fridericiana abbiamo soltanto delle prove indirette. Innanzitutto la testimonianza di Andrea d'Isernia, che ricorda come "a principio enim statutum fuit quod feudum esset integrum, scilicet de viginti unciis" (Peregrina lectura. Commentarium in Constitutiones Regni Utriusque Siciliae […], a cura di G. Sarayna, Lugduni 1568, p. 223). Poi un ordine dell'imperatore, forse da datare al 1236, che si legge tra le Epistolae di Pier della Vigna. Federico, nel prescrivere alle città demaniali e ai feudatari del Regno di Sicilia la contribuzione dovuta per la guerra che si accingeva a intraprendere in Lombardia, afferma che egli ha coscientemente adottato una soluzione diversa da quella dei re normanni, suoi predecessori. Mentre costoro hanno quasi reso disa-bitato il Regno a causa delle innumerevoli spedizioni intraprese in Africa e nelle altre regioni, egli, che può contare sugli uomini forniti dalla Germania ("multas enim nobis personas Germania germinat"; Historia diplomatica, III, p. 930), dispensa i regnicoli dal servire personalmente nell'esercito regio e commuta quest'obbligo nel versamento di una somma di denaro.
Nobilta' ------------- parte2 by Claudio Donati Enciclopedia delle scienze sociali (1996)
Nobiltà e patriziati fra tardo Medioevo e prima età moderna Sarebbe tuttavia un errore isolare la nascita della nobiltà militare-cavalleresco-feudale decritta sin qui dal generale e grandioso processo di trasformazione che caratterizzò l'Occidente europeo nei secoli del tardo Medioevo e della prima età moderna. Per limitarci all'ambito istituzionale e sociale, due fenomeni non possono essere trascurati: l'emergere delle monarchie e dei principati territoriali da un lato, la fioritura delle città dall'altro. Già a metà Ottocento Alexis de Tocqueville aveva osservato che l'"antica costituzione dell'Europa", giunta a maturazione nel XIV secolo, era sì dominata dalla signoria e dal feudo, ma anche dalle istituzioni municipali e dalle corporazioni, e dall'incipiente potere dei monarchi e della loro amministrazione accentrata, oltre che dalla Chiesa che "si trovava naturalmente immischiata in tutte le vecchie istituzioni". Principi, nobiltà e città, insieme alle istituzioni della Chiesa cattolica, costituirono dunque a partire dai secoli centrali del Medioevo i grandi protagonisti della storia politica europea; e l'intreccio reciproco, spesso conflittuale, tra queste diverse componenti influenzò il corso degli eventi storici e contribuì all'evoluzione differenziata delle varie aree regionali tra il tardo Medioevo e la prima età moderna. Per quanto riguarda queste peculiarità regionali, e in particolare il rapporto tra nobiltà e città, meritano attenzione i casi della Germania e dell'Italia settentrionale e centrale.
A prima vista definire la nobiltà tedesca dai tempi degli imperatori sassoni all'inizio del XIX secolo sembrerebbe molto facile: essa comprendeva i vassalli immediati o mediati dell'imperatore, i quali nell'ambito dei territori del Sacro Romano Impero esercitavano una giurisdizione signorile su un numero più o meno vasto di sudditi. Questa formulazione, che richiama nella forma più nitida la struttura gerarchica feudale, non corrisponde però alla realtà effettiva della costituzione imperiale fra tardo Medioevo e prima età moderna. Intanto c'è da osservare che, dalla metà del XIV secolo, l'imperatore era eletto non da tutti i nobili dell'Impero, ma da un collegio di sette (cresciuti poi a nove) principi elettori ecclesiastici e laici (Kurfürsten); e se l'eleggibilità era in teoria estesa a qualsiasi vassallo imperiale, di fatto dal 1452 in poi, con una sola eccezione a metà del Settecento, la dignità imperiale fu sempre conferita a un membro della casa degli Asburgo. Questi elementi costituivano già di per sé una limitazione al principio dell'uguaglianza giuridica tra tutti i nobili dell'Impero, ulteriormente minata dall'egemonia detenuta nella Dieta imperiale dai principi territoriali (Reichsfürsten) a scapito dei semplici cavalieri (Ritter), signori di piccoli e talvolta minuscoli feudi, che erano portati ad arrotondare le loro magre e decrescenti rendite attraverso rapine e saccheggi a danno dei villaggi, delle città, dei monasteri circostanti. Ma il problema non si esauriva nella dicotomia tra grande nobiltà dei principi e piccola nobiltà dei cavalieri: infatti nell'ambito della Dieta imperiale esisteva un autonomo collegio delle libere città dell'Impero, dove sedevano i rappresentanti eletti di quei centri urbani che godevano per privilegio dello status di immediata dipendenza dall'imperatore. Una questione ricorrente della storia tedesca nei secoli dell'età moderna riguardò appunto la condizione dei cittadini che governavano tali città attraverso la partecipazione agli organi consigliari municipali, quelli che con un termine derivato dalla tradizione romana venivano detti patrizi (Patrizier): costoro erano nobili allo stesso titolo dei principi e dei cavalieri dell'Impero, oppure rappresentavano un'anomalia rispetto alla genuina costituzione germanica? I sostenitori di questa seconda posizione insistevano su due punti. In primo luogo, la forma di governo delle città libere, sia che fosse aristocratica sia che tendesse alla democrazia, escludeva il rapporto tra signore e sudditi, che era la base dell'intero edificio del Reich: e ciò poteva condurre a esiti traumatici, come dimostrava il caso delle città svizzere, che si erano sottratte all'ubbidienza imperiale e si erano date una struttura confederata. Inoltre, i patrizi altro non erano che discendenti di artigiani e mercanti, e talvolta essi stessi esercitavano queste attività ritenute indegne di un nobile: come tali dovevano essere ritenuti estranei al mondo nobiliare propriamente detto. Questo dualismo tra patriziato e nobiltà, reso più complicato dalla frattura confessionale del XVI secolo, segnò nel profondo la storia sociale dei territori dell'Impero almeno fino all'epoca della guerra dei Trent'anni, il cui esito portò a un declino sostanziale (pur con qualche significativa eccezione) delle città libere, dei patriziati e della cultura al tempo stesso aristocratica e borghese che questi impersonavano. Quanto alla piccola nobiltà dei cavalieri, malgrado il processo di concentrazione della ricchezza e del potere nelle mani dei grandi signori (Adelstand), e malgrado le fosse precluso l'accesso alle dignità maggiori dell'Impero (come gli stalli dei capitoli delle cattedrali, riservati all'Adelstand), essa non scomparve in quanto ceto distinto, e anzi continuò a rappresentare fino al tramonto dell'Impero una sorta di gruppo depositario del patriottismo tedesco e dei valori cavallereschi del Medioevo. In realtà, il Ritter, pur riconoscendo come naturale la superiorità di un grande nobile, al tempo stesso era consapevole e orgoglioso di appartenere, sia pure su un gradino inferiore, alla medesima scala gerarchica che aveva alla sua sommità l'imperatore della nazione germanica........................... by Claudio Donati ---Treccani
--------------------------
la civilta' (?) a nord delle Alpi e' una civilta' di campagne ( terre e anime che vivono su quelle terre ) la civilta' longobarda--italiana e' una civilta' di citta' ( dove vivono i Cives ) Credo ci sia molto da scoprire sui Longobardi e sul modi del loro insediamento e sul governo dei centri cittadini Puo' essere che i proto- Comuni comincino molto molto prima di quanto noi sappiamo oggi dimostrare E che difficilmente in Italia si possa parlare di forme di nobilta' guerriera ma si debba parlare solo di aristocrazia e ceto dirigente ( non ereditari ) nelle citta' ( insediamenti signorili (?) nelle campagne )
il brano che viene molto citato ( ma andrebbe esaminato nel contesto ) .....considerazioni di Ottone vescovo di Frisinga e di Raevino (1115 ca.- 1158), zio di Federico I Barbarossa (1152-1190), sorpreso dalle forme di controllo che i comuni cittadini esercitavano sui …diocesanos…suos… compresi i grandi signori e feudatari, i domini loci
I Latini… imitano ancor oggi la saggezza degli antichi Romani nella struttura delle città e nel governo dello Stato. Essi amano infatti la libertà tanto che, per sfuggire alla prepotenza dell’autorità si reggono con il governo di consoli anziché di signori. Essendovi tra essi tre ceti sociali, cioè quello dei grandi feudatari, dei valvassori e della plebe, per contenerne le ambizioni eleggono i predetti consoli non da uno solo di questi ordini, ma da tutti, e perché non si lascino prendere dalla libidine del potere, li cambiano quasi ogni anno. Ne viene che, essendo la terra suddivisa fra le città, ciascuna di esse costringe quanti abitano nella diocesi a stare dalla sua parte, ed a stento si può trovare in tutto il territorio qualche nobile o qualche personaggio importante che non obbedisca agli ordini delle città. Esse hanno preso anche l’abitudine di indicare questi territori come loro “comitati”, e per non mancare di mezzi con cui contenere i loro vicini, non disdegnano di elevare alla condizione di cavaliere e ai più alti uffici giovani di bassa condizione e addirittura artigiani praticanti spregevoli arti meccaniche che le altre genti tengono lontano come la peste dagli uffici più onorevoli e liberali. Ne viene che esse sono di gran lunga superiore a tutte le città del mondo per ricchezza e potenza. A tal fine si avvantaggiano non solo, come si è detto, per la saggezza delle loro istituzioni, ma anche per l’assenza dei sovrani, che abitualmente rimangono al di là delle Alpi ovviamente percepisce la cosa coi suoi occhi di germanico e parla di conseguenza ora come dicevo a nord delle Alpi gia' coi Merovingi si era imposta il sistema di controllo vassalatico da parte del capo nei confronti dello "esercito" in un concetto gerarchico basato sulla fidelitas che via via ingloba elementi cristiani che rendono la fidelitas elemento sacrale il problema non sta nella gerarchia che puo' anche essere un valore positivo il problema sta nella considerazione verso l'ignobile che viene considerato poco piu' di una bestia il profondo disprezzo.......... l'ideale cavalleresco si esplicita verso il proprio simile. ma il proprio simile per l'aristocratico non e' il villano che e' subumano E' questo disprezzo verso l'ignobile che l'aristocrazia europea e dell'Italia meridionale si portera' dietro fino alla rivoluzione francese Sono le arti vili e meccaniche...... E quando si rafforzera' il connubio Trono--Altare...........
Nobilta' ------------- parte3 by Claudio Donati Enciclopedia delle scienze sociali (1996)
Diversa fu l'evoluzione del rapporto tra nobiltà e città nell'Italia settentrionale e centrale, e particolarmente in Toscana, dove le famiglie cittadine affermatesi nel corso della fioritura comunale del XII-XIII secolo furono in grado, come ha scritto lo storico italiano Marino Berengo, di "proporsi e imporsi come unica possibile classe dirigente e assorbire, senza scorie e strascico di ricordi, la vecchia nobiltà" di ascendenza signorile-feudale. In gran parte d'Italia nobiltà e patriziato vennero dunque a coincidere in un omogeneo ceto di governo urbano. Le pur importanti sopravvivenze, soprattutto nelle zone montane, di signorie rurali, non bastavano a oscurare l'immagine caratterizzante il paesaggio politico italiano dalle Alpi al Tevere: un fitto reticolo di città autonome, governate da magistrature di tipo collegiale, la cui giurisdizione si estendeva sui territori circostanti, detti generalmente contadi. Il dominio politico ed economico delle città si espresse sul piano culturale in una ideologia peculiare, che pur senza spregiare del tutto i paradigmi cavallereschi dominanti nei secoli centrali del Medioevo, rivendicava il primato della virtù, intesa come partecipazione alla vita civile, cioè al governo della repubblica, e come volontà di arricchimento attraverso la mercatura, cioè il commercio, le attività finanziarie e assicurative, l'industria manifatturiera. Non meno importante fu il contributo dei giuristi, legati alle istituzioni comunali urbane, nel dare una definizione di nobiltà che, per la limpida chiarezza dei termini adoperati e al tempo stesso per la straordinaria adattabilità a situazioni politiche e sociali differenti, godette di una lunga e meritata fortuna. Al perugino Bartolo da Sassoferrato (XIV secolo) va ascritto il merito di aver introdotto nella sfera del diritto il concetto di consuetudo loci, grazie al quale la nobilitas politica et civilis era propria di chi, sulla base dello statutum vigente in un determinato luogo, possedeva una qualitas in grado di porlo al di sopra degli honestos plebeios; tale qualità poteva essere conferita per la prima volta oppure riconosciuta come già esistente da chi deteneva il principatum, categoria che, agli occhi di Bartolo, non comprendeva solo l'imperatore, i re e i principi, ma anche un populus dotato della potestà di promulgare proprie leggi. Qui sorgeva però un problema, che non era solo terminologico, ma derivava dalle origini e dalle vicende di molti Comuni italiani: come mai nelle leggi di città come Firenze o Bologna coloro che venivano definiti nobili o magnati erano esclusi dall'accesso alle magistrature urbane e, per poter accedere al governo municipale come appartenenti alla nobilitas politica et civilis, dovevano rinunciare al proprio cognome originario, cioè alla propria condizione originaria di nobili? La questione non poteva essere risolta attraverso il ricorso al linguaggio giuridico: essa rimandava infatti al processo storico che aveva visto contrapposti molti Comuni italiani ai castellani del territorio (i magnati), la sconfitta dei quali aveva determinato un curioso sdoppiamento semantico del termine nobile, oggetto di disdegno e di ostracismo se applicato ai medesimi magnati, e viceversa qualifica d'onore per i cittadini che avevano distrutto le basi del potere delle signorie rurali. Insomma, in uomini fortemente segnati dalle tradizioni comunali (oltre che a Bartolo, si pensi a Dante Alighieri) un concetto come quello di nobiltà conservava una certa ambivalenza semantica. Nel corso del XIV e del XV secolo, il consolidarsi al potere in gran parte delle città italiane di omogenee oligarchie mercantili-terriere uscite vittoriose dallo scontro con il 'popolo minuto' degli artigiani; la formazione di Stati regionali che superavano la dimensione puramente urbana della politica e dell'amministrazione; l'affermarsi di dinastie signorili che, pur senza distruggere le tradizioni patrizie, amavano indulgere ai modelli culturali della nobiltà cavalleresca e feudale d'oltralpe (basti ricordare i Gonzaga, gli Estensi, i Montefeltro): tutti questi fattori portarono a un progressivo attenuarsi dell'antica contrapposizione tra cittadini e magnati, mentre il concetto di nobiltà assumeva ovunque una connotazione indiscutibilmente positiva. Forse questo quadro risulta un po' troppo schematico, in quanto per definizione il particolarismo italiano richiede un'attenzione costante alla specificità delle singole situazioni locali: su questo punto erano molto sensibili i letterati umanisti del Quattrocento, precisi nel mettere a fuoco le diversità esistenti, in materia di consuetudini, di leggi e di comportamenti quotidiani, tra le varie nobiltà d'Italia, dal patriziato marittimo di Venezia, ai mercanti-banchieri fiorentini e senesi, ai baroni latifondisti del Lazio e del Napoletano. E tuttavia, malgrado le differenze, le nobiltà italiane presentavano sullo scorcio del XV secolo alcuni connotati comuni e peculiari, determinati dall'influenza ovunque esercitata dai modi del vivere civile, cioè dal perdurare (sia pure in forme attenuate) del modello di organizzazione politica e sociale che era stato proprio del mondo comunale-urbano. Monarchie, guerre e nobiltà tra XV e XVI secolo
Patriziato genovesePatriziato genovese per dr Guido Castelnuovo
Patriziato genovese Patriziato genovese_Andrea_Lercari
Patriziato venezianoPatriziato veneziano_Marino_Berengo
Patriziato veneziano Patriziato veneziano_Renzo _De_Rosas
Quando esiste una Fons honorum la nobilta' e' sempre riferita a questa :questa concede conferma toglie a suo arbitrio ..... sorga un cavaliere......sorga un nobile....fellonia........ detta le regole E la cosa lascia pochi dubbi perche' possiamo e dobbiamo fare riferimento ad una volonta' sovrana che e' padrona del territorio Ma quando non esiste una Fons honorum come nel caso di una Repubblica ( che puo' avere solo un sistema premiale ) che succede ? L'articolo spiega che la visione comune in questo caso ( per Venezia , Firenze, Genova , Lucca......) e che il patriziato assume nobilta' per l'atto stesso del governare e questo anche se il patrizio e' di origine popolare e mercantile Quindi , nella definizione, quando cessa il governare in realta' cessa la nobilta'----un po' contradditoria la cosa ma sembra funzionare cosi ( Quindi una visione del tutto particolare del concetto di nobilta' : nobilta' a tempo ) la percezione dei patrizi veneti e' di essere nobili , pur avvertendo la differenza con la nobilta' del Dominio : tipo i Da Canossa----- ma di fatto , pur se poco avvertita, questa differenza tra le due specie di nobili c'e' Lo stesso si potrebbe dire per Genova dove gli Alberghi atti a comandare hanno visto l'ammissione anche di famiglie potenti e ricche ma chiaramente popolari e mercantili ) A maggior ragione per Firenze che con gli Ordinamenti di Giustizia ha statutariamente escluso tutta la "nobilta' consolare " ed ammesso al governo solo il "Popolo" E' di questo esercitare le arti vili e meccaniche ( comune a parte dei tre patriziati ) che bisogna tenere conto Quando i Gondi fiorentini ( alcuni rami ) si stabiliranno definitivamente in Francia per essere ammessi nella nobilta' francese dovranno abbandonare la mercatura e appoggiarsi solo al mestiere delle armi , e al favore del Re e della Chiesa Aver la percezione di essere o ritenersi nobili e' un autoproclamazione se non si da un fondamento giuridico alla cosa. E il fondamento giuridico e' in questo caso "il governare lo Stato" Cessando di governare ? : Il problema nel caso di Firenze ( Real politik ) e' completamente trascurato per complessi motivi politici quando viene instaurato il Principato ( i Medici governano quella che mi pare formalmente rimarra' una Repubblica fino mi pare al congresso di Vienna : nonostante la proclamazione del Ducato prima e del Granducato poi ----questo perche' nelle condizioni di resa a Carlo V la Repubblica viene esplicitamente mantenuta e Alessandro viene proclamato ambiguamente Duca della Repubblica fiorentina ) Nel caso di Venezia il problema si pone solo col passaggio della Repubblica agli Austriaci e con la rinuncia del Gran Consiglio a governare
Lo stesso giorno in cui aveva scritto a Bartholdy la lettera che abbiamo ricordato prima, il 29 settembre 1808, Foscolo ne aveva diretta un'altra più breve, e anch'essa di ripensamento autobiografico, a Giambattista Giovio: «Quantunqu e da più e più anni la mia famiglia non abbia di nobile e di patrizio che il nudo nome, io stim o i patrizi e disprezzo i nobili. Ed è per me vero patrizio d'una città chi ha terre da far fruttare, se polcri domestici da venerare, lari da difendere, ed antenati da imitare i quali, per lungo ordine d'anni, abbiano o arricchita la loro patria con l'industria, o celebrata con le vi rtù e con l'ingegno, o protetta col sangue. Ma i titoli, i feudi e gli stemmi che ogni principe può dare e può tôrre e che ogni soldato straniero, o mercatante fortunato, o letterato cortigiano può assumere n È paesi conquistati o usurpati, e che può tramandare a' suoi nepoti, sono a' miei sguardi ricami sopra sucida tela»
E' una questione di quantita' e di dimensioni. All’inizio del Trecento l’ Europa non arrivava ai 70 milioni di abitanti. Verso la fine del secolo, la penisola italiana era abitata da quasi 8 milioni e mezzo di persone. Nel XIV secolo, Milano era comunque la città più popolosa d’Europa con oltre 150mila abitanti. Più di Parigi, unica città europea a superare i 100mila. Gabriella Piccinni, autrice di “Medioevo” ( Bruno Mondadori Editore ) parla a ragione di “metropoli italiane”: Firenze e Venezia infatti all’epoca avevano già più di 100mila abitanti. Ma era tutta la penisola a essere urbanizzata più del continente. Sei città del centro nord contavano tra i 40mila e i 50mila abitanti: Bologna, Verona, Brescia, Cremona, Siena e Pisa. Roma, sede del papato, in quegli anni aveva solo 30mila abitanti. Appena qualche migliaio in più di Perugia, che sfiorava i 25mila. Come Padova, Pavia, Parma, Mantova, Piacenza, Napoli, L’Aquila e Messina, Ancona e Ascoli Piceno. La bella Ferrara, come Forlì, Reggio nell’Emilia, Ravenna e Rimini non arrivava ai 15mila residenti. In Andalusia, Cordova e Granada, popolate da arabi, orientali, ebrei, europei e africani, dopo la “reconquista” scesero di colpo sotto i 50mila residenti. Qualche centinaio di abitanti in meno della prospera città fiamminga di Gand e di Colonia, che allora era la più ricca e popolosa delle città tedesche. La russa Velikij Novgorod, capitale di un vasto stato tra il Baltico, il mar del Nord e gli Urali, non arrivava ai 50mila abitanti. Salonicco, con 55mila abitanti era il centro più popoloso della Grecia. All’alba del XIV secolo, Londra era abitata da appena 35mila persone. E in tutta l’Inghilterra soltanto York, Norwich e Bristol superavano i 10mila abitanti. https://www.festivaldelmedioevo.it/port ... lle-citta/ Nel basso Medioevo gran parte delle realtà urbane sono città per statuto giuridico, ma il loro spessore demografico ed economico è assai scarso. Intorno alla metà del XIV secolo nell’Impero germanico si contano circa 3000 città: solo 200 hanno una popolazione superiore ai 1000 abitanti e 20 tra i 10 e i 15 mila abitanti. Una situazione non molto dissimile si riscontra in Inghilterra, in Francia, nella penisola iberica.
Nobilta' ------------- parte4 by Claudio Donati Enciclopedia delle scienze sociali (1996) Se l'ascesa economica e politica delle città fu uno dei processi più importanti che caratterizzarono la storia d'Europa a partire dai secoli centrali del Medioevo, non minore attenzione dev'essere riservata alla formazione, tra il XV e il XVI secolo, dei cosiddetti Stati moderni, caratterizzati sia da dimensioni territoriali sconosciute alle monarchie feudali dei secoli precedenti, sia da una crescente concentrazione dei poteri giudiziari, militari e fiscali nelle mani dell'amministrazione regia. Un tale sviluppo infatti presenta molteplici intrecci con la storia dei ceti nobiliari. Qui ci soffermeremo brevemente sul rapporto tra la costituzione di grandi eserciti statali e il ruolo svolto da quella che, durante il Medioevo, era stata per definizione la classe dei guerrieri armati: due esempi ci aiuteranno a mettere in evidenza l'importanza di tale relazione. In Francia, con una serie di riforme attuate nel corso del Quattrocento dopo la fine della guerra dei Cent'anni, la monarchia cercò di dar vita a un grande esercito regolare stipendiato, costituito in parte da truppe mercenarie straniere, in parte da milizie nazionali (le ordonnances) arruolate nelle varie province del regno; a questa fanteria si affiancava la tradizionale cavalleria pesante dei nobili feudatari, i gentilshommes eredi dei milites del Medioevo, che servivano il re in base ai principî della fedeltà vassallatica. Per far fronte alle spese necessarie al pagamento e al mantenimento dei mercenari e delle milizie nazionali, fu istituita nel 1439 la taille royale, un'imposta diretta cui furono soggetti tutti i sudditi laici della monarchia, tranne appunto i gentilshommes; in tal modo proprio l'esenzione ereditaria dalla taille rappresentò da questo momento e fino alla Rivoluzione l'elemento fondamentale per definire i confini della nobiltà francese e distinguerla dal 'terzo stato' dei roturiers, che invece erano soggetti a quell'imposta. Nella penisola iberica le guerre condotte dai sovrani cristiani di Castiglia e d'Aragona per la reconquista dei territori soggetti ai Mori, che si conclusero nel 1492 con la fine del regno musulmano di Granada, rappresentarono un fattore decisivo per la definizione dei caratteri nazionali della nobiltà. Infatti i nobili spagnoli del Cinquecento erano giuridicamente coloro che potevano dimostrare la propria purezza di sangue (limpieza de sangre), cioè la discendenza dai 'vecchi cristiani' o hidalgos che avevano combattuto contro gli infedeli; tutti gli altri, i marranos, che non andavano in guerra, avevano nelle loro vene sangue musulmano o ebreo. In tal modo nella Spagna del Cinquecento il carattere militare tipico di gran parte delle nobiltà europee assunse un connotato di esclusivismo confessionale e razzistico, con conseguenze importanti anche sul piano culturale e sociale. Infatti, dato che musulmani ed ebrei vivevano nelle città e per lo più si dedicavano al commercio e al prestito, prese forza l'idea che discendere da un contadino fosse la miglior prova di appartenenza ai 'vecchi cristiani'. Ciò favorì il successo della figura del 'soldato gentiluomo', il nobile-contadino castigliano arruolato nei tercios che combatteva per l'ingrandimento della corona di Spagna, per la propagazione della fede cattolica, ma anche per il proprio arricchimento personale, che gli avrebbe consentito di acquistare una signoria con giurisdizione o l'abito di un ordine cavalleresco, entrando così nella sfera socialmente più elevata del mondo nobiliare. Sul tema del rapporto tra carriera delle armi e nobiltà un itinerario molto diverso da quello delineato per la Francia e per la Spagna fu quello percorso dall'Inghilterra. Infatti quella che era stata una delle più bellicose aristocrazie feudali dell'Europa cristiana mutò profondamente i propri connotati dopo l'avvento della dinastia dei Tudor, che pose termine alle sanguinose lotte intestine tra fazioni contrapposte, e in seguito al prolungato disimpegno dell'esercito inglese dalle guerre combattute nel continente europeo. Così, se all'avvento al trono di Elisabetta I metà dei nobili titolati (chiamati peers o lords) poteva ancora vantare almeno un'esperienza guerresca, verso il 1640 pochissimi dei loro eredi possedevano qualche forma di preparazione militare. Viceversa, durante quel periodo molti nobili inglesi si erano rivolti ad attività commerciali e imprenditoriali e anche alle professioni liberali. Per questo nel tardo Cinquecento risultava assai difficile definire il confine giuridico e sociale tra i veri e propri nobili e quanti erano considerati tali dall'opinione comune nella misura in cui vivevano in modo non dissimile dai primi. La parola-chiave era gentleman: se nei secoli XIV e XV essa era servita a definire sia i figli minori dei lords, che non potevano fregiarsi del titolo attribuito al solo primogenito, sia il gradino inferiore della nobiltà minore dei knights (cavalieri), nella seconda metà del Cinquecento era definito gentleman, come scrisse William Harrison nella sua Description of Britain (1587), "un uomo di nobili sentimenti, conosciuto grazie alla sua famiglia, al suo sangue, o perlomeno alla sua situazione sociale", acquisita tramite l'insegnamento nelle università, l'esercizio della medicina o dell'avvocatura, il servizio nell'esercito o nell'amministrazione pubblica. I gentlemen costituivano dunque un gruppo (la gentry) non facile da definire: si trattava dello strato inferiore di una nobiltà che aveva al suo vertice il re, i membri della famiglia reale e una sessantina di lords, oppure dello strato superiore di una borghesia di mercanti, professionisti, intellettuali, ufficiali dello Stato e proprietari-coltivatori?
Nobilta romana......................................................Nobilta' romana nel medioevo di Sandro Carocci
Nel 1532, quando Firenze diventa signoria ufficialmente, avviene il passaggio da signoria de facto (o mascherata) a signoria vera e propria. Clemente VII – un papa Medici – nipote di Lorenzo il Magnifico, nomina Alessandro de’ Medici (probabilmente un suo figlio illegittimo) duca di Firenze e “gonfaloniere perpetuo” della Repubblica, abolendo la vecchia costituzione della città e garantendo alla famiglia un titolo nobiliare ereditario che conferma il ruolo di signori della città di Firenze. È così che si compie il processo storico che trasforma la Repubblica di Firenze in un ducato, ossia in una signoria.
Nobilta' ------------- parte5 by Claudio Donati Enciclopedia delle scienze sociali (1996)>
Sul tema del rapporto tra carriera delle armi e nobiltà un itinerario molto diverso da quello delineato per la Francia e per la Spagna fu quello percorso dall'Inghilterra. Infatti quella che era stata una delle più bellicose aristocrazie feudali dell'Europa cristiana mutò profondamente i propri connotati dopo l'avvento della dinastia dei Tudor, che pose termine alle sanguinose lotte intestine tra fazioni contrapposte, e in seguito al prolungato disimpegno dell'esercito inglese dalle guerre combattute nel continente europeo. Così, se all'avvento al trono di Elisabetta I metà dei nobili titolati (chiamati peers o lords) poteva ancora vantare almeno un'esperienza guerresca, verso il 1640 pochissimi dei loro eredi possedevano qualche forma di preparazione militare. Viceversa, durante quel periodo molti nobili inglesi si erano rivolti ad attività commerciali e imprenditoriali e anche alle professioni liberali. Per questo nel tardo Cinquecento risultava assai difficile definire il confine giuridico e sociale tra i veri e propri nobili e quanti erano considerati tali dall'opinione comune nella misura in cui vivevano in modo non dissimile dai primi. La parola-chiave era gentleman: se nei secoli XIV e XV essa era servita a definire sia i figli minori dei lords, che non potevano fregiarsi del titolo attribuito al solo primogenito, sia il gradino inferiore della nobiltà minore dei knights (cavalieri), nella seconda metà del Cinquecento era definito gentleman, come scrisse William Harrison nella sua Description of Britain (1587), "un uomo di nobili sentimenti, conosciuto grazie alla sua famiglia, al suo sangue, o perlomeno alla sua situazione sociale", acquisita tramite l'insegnamento nelle università, l'esercizio della medicina o dell'avvocatura, il servizio nell'esercito o nell'amministrazione pubblica. I gentlemen costituivano dunque un gruppo (la gentry) non facile da definire: si trattava dello strato inferiore di una nobiltà che aveva al suo vertice il re, i membri della famiglia reale e una sessantina di lords, oppure dello strato superiore di una borghesia di mercanti, professionisti, intellettuali, ufficiali dello Stato e proprietari-coltivatori? Come vedremo nel prossimo capitolo, la risoluzione di questo dilemma, che ha suscitato nell'ultimo cinquantennio un vivace dibattito tra gli storici inglesi, appassionava gli stessi contemporanei e non era certo limitato alle isole britanniche. L'ideologia del gentiluomo Dalla metà del Cinquecento ai primi decenni del secolo seguente godette di una eccezionale fortuna editoriale una trattatistica incentrata sull'idea di nobiltà e sulle caratteristiche proprie dell'uomo nobile. Le opere a stampa che ci sono pervenute costituiscono, d'altra parte, una percentuale limitata di quanto in quel periodo fu scritto e dibattuto sull'argomento: è dunque lecito concludere che le discussioni sulla nobiltà rappresentarono in quell'epoca un argomento capace di appassionare e coinvolgere le persone acculturate dell'intera Europa. Quanto si è accennato a proposito del termine di gentleman nell'Inghilterra dei Tudor può fornire una prima spiegazione: nel corso del Cinquecento la crisi della nobiltà in quanto classe egemone di tradizione signorile e cavalleresco-militare e il parallelo emergere di una nuova élite legata agli uffici, alle professioni liberali, alle università, costrinse a ripensare i criteri in base ai quali definire la classe dominante di un paese. Come ha scritto lo storico inglese Lawrence Stone, la crisi dell'aristocrazia "implicò un fondamentale riadattamento in quasi tutti i campi del pensiero e dell'azione per adeguarsi a un ambiente in rapida trasformazione". È però interessante osservare come il grande dibattito sulla nobiltà e sul gentiluomo avesse il suo primo sviluppo non in Inghilterra o in Francia, cioè nelle roccaforti della nobiltà feudale, ma in quell'Italia che era stata una delle aree più caratterizzate dalla presenza dei patriziati urbani, e da qui si diffondesse nel resto d'Europa. È dunque necessario cercare di capire i motivi di questo apparente paradosso. La catastrofe del sistema politico italiano basato sull'equilibrio tra gli Stati regionali, in seguito alle guerre di cui l'intera penisola fu teatro a partire dalla spedizione del re di Francia Carlo VIII nel 1494, ebbe ripercussioni molto importanti anche sul modo di considerare la nobiltà che si era affermato in Italia dai tempi dei Comuni. Il confronto obbligato con le istituzioni e le consuetudini delle altre nazioni, che si erano rivelate tanto superiori sul piano militare, suscitò dubbi e ripensamenti sulla bontà del vivere civile negli eredi della tradizione comunale e patrizia, e in particolare in scrittori politici fiorentini come Niccolò Machiavelli, Francesco Guicciardini, Paolo Vettori. Per ricostituire un ordine gravemente turbato, e non solo dalle guerre (basti pensare al contemporaneo insorgere dei movimenti di dissenso religioso legati alla Riforma protestante), occorreva elaborare un nuovo modello politico e culturale. Sul piano politico il processo più importante fu quello delle cosiddette serrate o chiusure dei consigli, che coinvolse l'intero panorama dell'Italia urbana, dalle città ai borghi minori e fin ai villaggi, dal Piemonte alla Marca pontificia, dal Veneto alla Puglia. Grazie a questa separazione di ceto, l'accesso ai consigli e l'esercizio dell'amministrazione locale furono riservati a quanti potevano dimostrare di vivere nobilmente (more nobilium) e ai loro discendenti; la vita nobile comportava l'astensione da lavori manuali, d'ora in avanti considerati disdicevoli. Queste misure politiche si collegavano, traendone forza, agli esiti del grande dibattito culturale cui presero parte i migliori intellettuali italiani del Cinquecento. I punti d'arrivo di questa riflessione possono essere così sintetizzati: il cosiddetto governo largo e populare, cioè la partecipazione di tutti i cittadini alla vita politica, era una fonte di disordine continuo, in quanto sfociava inevitabilmente nelle lotte tra fazioni contrapposte; occorreva perciò separare il popolo dalla nobiltà, e riservare a questa sola le magistrature; per definire chi fosse il nobile o, come si preferiva dire, il gentiluomo, criteri fondamentali erano il possesso dell'onore derivante dalla virtù degli antenati, un armonioso equilibrio tra forza fisica e capacità di conversare, l'astensione dall'esercizio delle arti vili e meccaniche. Le difficoltà sorgevano al momento di definire il significato e i reciproci rapporti tra i concetti di onore, virtù, arti vili, nobiltà, popolo: se ci si fosse rifatti alla storia e alle tradizioni dell'Italia comunale, sarebbe stato difficile raggiungere il consenso sull'idea che il commercio o l'esercizio del notariato e della medicina fossero arti vili, così come sarebbe apparso incongruo escludere dalla nobiltà i cittadini. Lo sforzo dei trattatisti del Cinquecento consistette nell'attenuare le contraddizioni, nell'astenersi prudentemente dal richiamo alle vicende storiche, nel negare la possibilità di alternative diverse dal modello oligarchico che si voleva imporre, e nel fornire così (pur senza rinnegare completamente il criterio della consuetudo loci che consentiva di introdurre nel quadro generale una serie di eccezioni) un'idea di gentiluomo coerente, omogenea e applicabile a Milano come a Bologna, a Firenze come a Napoli. Ciò era in sintonia da un lato con le tendenze prescrittive, gerarchiche e disciplinatrici della cultura della Controriforma, e dall'altro con la volontà delle classi superiori della penisola di presentare all'esterno un'immagine di ordine capace di smentire la diffusa rappresentazione di un'Italia in preda alle discordie civili. Un tale sforzo di sistemazione concettuale, con la connessa ricerca di criteri universali per definire la nobiltà, favorì la fortuna di questa trattatistica al di fuori dei confini della penisola, come testimoniano le innumerevoli traduzioni in francese, in inglese, in tedesco, e la presenza di questi libri nelle biblioteche nobiliari di tutta l'Europa. Uno dei più celebrati prodotti di questa letteratura sul gentiluomo fu certamente il Libro del cortegiano (1528) di Baldassar Castiglione, che, benché cronologicamente anteriore alla fioritura di tale genere, godette di una larga fortuna italiana ed europea soprattutto nella seconda metà del secolo, e dunque merita di essere accostato a opere più tarde, come il Galateo (1558) di Giovanni Della Casa, Il gentiluomo (1571) di Girolamo Muzio, La civil conversazione (1574) di Stefano Guazzo, i Discorsi (1585) di Annibale Romei (cui si deve una delle più fortunate definizioni di nobiltà: "un bene di fortuna che all'uomo accade nella sua prima origine, fabbricatogli dalla onorevolezza dei suoi maggiori e dallo splendore della patria, per il quale meritamente si suppone ch'egli sia molto più atto alla virtù del nato di mecanico in patria vile"), il Trattato della nobiltà (1603) di Lorenzo Ducci. Si ricordi che un Leit-motiv del dialogo del Castiglione era l'idea che il perfetto gentiluomo, pur riconoscendo nell'esercizio delle arti militari la sua professione principale, non s'identificava completamente con l'uomo d'armi: egli doveva infatti possedere altre qualità, come la grazia, che si esprimeva nella capacità di conversare e derivava da un lungo e faticoso studio.In conclusione, questo modello italiano di gentiluomo, capace di conciliare onore e virtù, vita di corte e partecipazione al governo della città, armi e lettere, poteva essere esportato in tutta Europa, in quanto veniva incontro alle esigenze di classi dominanti un po' incerte e disorientate di fronte alle grandi trasformazioni della prima età moderna. La nobiltà degli uffici: il caso francese Se la ricerca e la proposta di una sintesi tra cultura cavalleresco-militare e umanesimo civile ebbero in Italia uno sviluppo lineare e in un tempo relativamente breve approdarono all'accettazione concorde del modello del gentiluomo, altrove questo processo fu molto più tormentato e si trascinò a lungo in mezzo a conflitti profondi. Ad esempio, nella Francia del Cinquecento il crescente peso numerico e sociale dell'apparato burocratico dipendente dalla monarchia, che (a differenza che nell'esercito) non coincideva con il ceto dei milites medievali, creò una sorta di dicotomia tra due aristocrazie diversissime per storia, idealità e prospettive. I magistrati regi (come ha osservato lo storico americano George Huppert) "sono figli o nipoti o pronipoti di mercanti; e personalmente sono capitalisti, prestatori di denaro, usurai. Appartengono poi a una professione, quella legale, il cui status sociale è non ben definito. Quando esercitano la loro professione, ricevono ricompense e onorari per il loro lavoro e, d'altra parte, non vanno a caccia di gloria sul campo di battaglia, né indulgono a divertimenti come la caccia e lo scialo fastoso. Per tutti questi aspetti, la loro condotta non presenta i tratti tipici della condotta dei nobili. Ma è pur vero che non sono direttamente impegnati in attività commerciali e che possiedono feudi signorili e possedimenti terrieri". Ma allora questi ufficiali (officiers), detti anche 'togati' (robins), erano nobili o no? La questione rimase aperta fino all'inizio del Seicento, quando un editto di Enrico IV stabilì che, per fruire di una nobiltà ereditaria, erano necessarie due generazioni successive nell'esercizio di una serie di cariche che venivano dettagliatamente specificate; a tali cariche erano connessi molti privilegi, il più significativo dei quali era l'esenzione dalla taille. In tal modo era ufficialmente riconosciuta l'esistenza di una nobiltà di creazione regia e legata alle cariche, che dal punto di vista legale non differiva dalla nobiltà antica di quelli che continuavano a essere definiti gentilshommes de race, il che ci sembra molto significativo, in quanto (come s'è visto) l'analogo termine di gentleman aveva nell'Inghilterra del tardo Cinquecento una valenza semantica molto diversa. La creazione nel 1615 della carica di 'giudice d'armi', col compito di verificare gli ascendenti delle famiglie per poter concedere a chi ne aveva diritto i privilegi connessi alla condizione nobiliare, sancì il principio che solo la monarchia, e non la fama e la memoria collettiva, poteva legittimare e riconoscere la nobiltà di un individuo. Questo orientamento, che ebbe una espressione celebre nelle inchieste araldiche e genealogiche promosse nella seconda metà del Seicento dal ministro Colbert, tipico esponente della noblesse de robe, si scontrò con vivaci resistenze da parte dei gentilshommes. Questi ultimi non comprendevano soltanto il ristretto gruppo dei 'grandi', formato dalle famiglie di coloro che da secoli coadiuvavano il re nelle maggiori dignità militari ed ecclesiastiche della monarchia ed erano chiamati 'cugini del re' (alti prelati, marescialli di Francia, governatori delle province), ma anche i piccoli nobili provinciali (i cosiddetti hobereaux o gentilshommes campagnards), che avvertivano con disagio lo stridente contrasto tra il proprio sempre più scarso potere politico ed economico e l'orgoglio del proprio passato legato al mito della conquista franca. Sviluppato da Étienne Pasquier negli anni sessanta del Cinquecento e ulteriormente arricchito da molti eruditi secenteschi e del primo Settecento, il più celebre dei quali fu sicuramente Henri de Boulainvilliers autore di un Essai sur la noblesse de France (pubblicato postumo nel 1732), questo mito postulava che gli unici nobili francesi degni di questo nome erano i discendenti dei Franchi guerrieri che avevano conquistato le terre della Gallia, instaurando una separazione con la popolazione conquistata, dalla quale discendeva la gente comune (i roturiers). Dunque i gentilshommes de race godevano di un diritto storico incontestabile a esercitare il comando: per cui si configurava come una vera rottura nella storia di Francia la politica svolta a partire dal XV secolo dalla monarchia, che aveva sovvertito le gerarchie fissate al tempo della conquista attraverso la creazione di nobili tratti dalla sfera ignobile dei roturiers. Viceversa, i fautori della nobiltà degli uffici, come il giurista Charles Loyseau autore del Traité des ordres (1613), sostenevano, anche sulla base della legislazione regia in materia, che non esisteva alcuna differenza di grado fra redditieri, giuristi, medici, finanzieri di recente nobilitazione, e i gentiluomini poveri di campagna, che senza alcuna prova documentaria pretendevano di discendere in linea diretta dai milites del Medioevo, dai paladini di Carlo Magno e addirittura dai guerrieri franchi. Di fronte a queste tesi contrapposte, gli storici si sono chiesti se le due nobiltà finissero per fondersi in un gruppo unico oppure continuassero a rimanere distinte, e in questo secondo caso, se fosse riconosciuta dall'opinione comune la superiorità della nobiltà di vere o presunte ascendenze cavalleresco-feudali (noblesse d'épée) su quella degli uffici (noblesse de robe). Secondo François Bluche, non esisteva differenza tra le due nobiltà, sia perché entrambe godevano dei medesimi privilegi giuridici, sia perché la monarchia attribuiva la stessa importanza al servizio prestato nell'amministrazione e a quello prestato nell'esercito, sia soprattutto perché furono frequenti i matrimoni 'misti' tra famiglie di gentilshommes e di robins. Secondo Roland Mousnier, invece, il dato innegabile di una comune condizione giuridica non può annullare il peso della mentalità, il fatto cioè che la grande nobiltà di spada considerava semplici borghesi anche funzionari regi del calibro di Colbert e Louvois; quanto ai matrimoni, dato che vi erano coinvolti per lo più uomini della nobiltà di spada e donne della nobiltà di toga, essi non implicavano l'amalgama tra i due gruppi, in quanto presso la nobiltà francese vigeva un regime patrilineare e dunque il ruolo delle donne nella determinazione della nobiltà era trascurabile. La questione resta aperta. Ci pare necessario aggiungere che bisogna evitare di credere che l'ordinamento della società francese, e in particolare il ruolo in esso ricoperto dalla nobiltà, si mantenesse costante nel tempo. Nei conflitti civili che sconvolsero a più riprese la Francia, alla fine del Cinquecento con le guerre di religione e alla metà del Seicento con le 'fronde' dei principi e dei parlamenti, affiorava costantemente, insieme ad altri motivi, la non risolta contraddizione tra una struttura nobiliare di tipo feudale-vassallatico, che proprio in Francia aveva avuto la sua terra d'elezione, e una nuova struttura nobiliare gerarchica e burocratica, contrassegnata da un corpo ereditario di funzionari regi sempre più coscienti e orgogliosi del proprio ruolo nell'organizzazione politica del regno. Un organo di legittimazione sovranazionale della nobiltà: l'ordine di Malta Come si è visto nei capitoli precedenti, la nobiltà europea presentava origini e caratteristiche molto diversificate tra Stato e Stato, tra le varie regioni, province e città all'interno di uno stesso Stato, e anche nell'ambito di una stessa area geografica. Per questo risultarono molto importanti quelle istituzioni che, nel corso del Cinquecento e del Seicento, svolsero la funzione di legittimazione sovranazionale, sovrastatale e sovralocale delle diverse nobiltà. Qui ne prenderemo in esame una in particolare, la cui influenza si manifestò soprattutto nell'area confessionale cattolica. Tra le diverse religioni cavalleresche sorte all'epoca delle crociate, quella che in età moderna godette della maggiore rinomanza fu quella degli ospitalieri di san Giovanni di Gerusalemme, meglio noti col nome di cavalieri Gerosolimitani o di Malta. L'isola a sud della Sicilia, infatti, già parte del regno di Aragona, fu concessa in feudo da Carlo V nel 1530 all'ordine, che nel 1522 aveva dovuto abbandonare Rodi conquistata dai Turchi; a Malta affluirono molti cavalieri dalla Francia, dalla penisola iberica, dall'Italia, distinguendosi nella difesa dell'isola dall'assedio della flotta ottomana nel 1565. Da quel momento la religione di Malta godette di grande fama presso i nobili dell'Europa cattolica, e mantenne un carattere internazionale, testimoniato dal fatto che nel periodo 1530-1797 la suprema carica di gran maestro fu tenuta da 12 francesi, 9 spagnoli, 4 italiani, 2 portoghesi e 1 tedesco; inoltre sia a Malta sia sulle navi coesistevano cavalieri di diverse nazionalità. Si consideri poi che, in seguito a una serie di riforme degli statuti dell'ordine attuate nella seconda metà del Cinquecento e nei primi decenni del Seicento, furono fissate regole molto precise e rigorose per la concessione dell'abito di cavaliere da parte delle otto lingue in cui l'ordine era diviso (Francia, Alvernia, Provenza, Italia, Aragona, Castiglia-León, Inghilterra, Alemagna). Il candidato doveva sottoporsi alle cosiddette prove di nobiltà, che consistevano in un esame condotto da commissari dell'ordine presso i luoghi d'origine del candidato stesso e dei suoi avi, per accertare i due criteri imprescindibili per essere accettati tra i cavalieri maltesi: l'astensione da parte del candidato e dei suoi antenati dall'esercizio di arti vili e meccaniche, e la presenza di una formale separazione di ceto tra nobiltà e popolo nel luogo d'origine dell'aspirante cavaliere e dei suoi ascendenti, i quali naturalmente dovevano risultare membri della nobiltà. È da osservare che nelle diverse lingue erano previste modalità differenziate di espletamento delle prove: ad esempio, ai candidati della lingua di Alemagna era richiesta la nobiltà dei sedici quarti, cioè fino ai trisavoli compresi, mentre ai futuri cavalieri d'Italia bastava provare la nobiltà dei quattro quarti, cioè dei genitori e dei nonni paterni e materni. Ma nel complesso l'uniformità prevaleva sulle differenze: come per i candidati delle altre lingue, anche a quelli italiani e ai loro avi era interdetto l'esercizio del notariato e della mercatura, che pure fino a un recente passato erano stati considerati in molte città della penisola professioni onorevoli e degne di essere praticate da un cittadino ascritto al consiglio; l'unica eccezione riguardava i gentiluomini delle città di Genova, Firenze, Siena e Lucca. Inoltre in occasione delle prove l'obbligo di produrre scritture autentiche, e di non accontentarsi delle deposizioni orali dei testimoni, era un fortissimo deterrente per numerosi aspiranti dalle origini nebulose. Insomma, l'accesso all'ordine di Malta veniva a costituire una sorta di legittimazione per chi non voleva fondare la propria nobiltà sulla consuetudo loci, cioè su una fama riconosciuta solo localmente, ma intendeva vedersi riconosciuto universalmente come gentiluomo. Si comprende allora perché la documentazione delle prove per l'accesso all'ordine maltese fosse conservata gelosamente negli archivi familiari e prodotta in tutte le occasioni in cui fosse necessario dimostrare l'indiscutibile nobiltà del proprio casato. La famiglia nobile, il suo patrimonio, le entrate e le spese Rispetto alle nobiltà medievali, quelle dei secoli dell'età moderna presentano una caratteristica peculiare: la documentata continuità delle famiglie lungo l'arco di più secoli. In parte si tratta, appunto, di un problema di documentazione: mentre per l'età medievale sono andati quasi per intero distrutti gli archivi nobiliari, per l'età moderna se ne conserva un numero non trascurabile. Questo stato delle fonti, d'altra parte, non è frutto del caso: fu appunto in età moderna, in seguito alla formalizzazione dei criteri di accesso alla nobiltà sia nelle repubbliche oligarchiche sia nelle monarchie, che si avvertì con sempre maggior forza da parte delle famiglie la necessità di conservare la documentazione del proprio passato illustre. Ma la miglior conservazione degli archivi familiari non basta a spiegare la durata nel tempo delle famiglie nobili: questa fu dovuta soprattutto all'introduzione di particolari forme di trasmissione ereditaria, miranti a evitare la divisione e la dispersione dei patrimoni per poterli far pervenire nella loro interezza a un membro della famiglia preventivamente designato. Fondamentale fu, a tale riguardo, la generale diffusione, soprattutto dalla seconda metà del Cinquecento in poi, dell'istituto del fedecommesso, mediante il quale un privato poteva vincolare per testamento i propri beni immobili ai discendenti per una o più generazioni o spesso all'infinito (in perpetuum). Il fedecommesso era spesso collegato a un altro istituto, presumibilmente di origine spagnola, il maggiorascato (mayorazco) o primogenitura, mediante il quale unico beneficiario del patrimonio familiare indiviso era il primogenito maschio. L'introduzione di queste consuetudini successorie in gran parte delle nobiltà europee, secondo tempi e modalità che variarono da zona a zona, ebbe come conseguenza l'inferiorità sociale, giuridica ed economica dei figli maschi minori (cadetti) e di tutte le figlie femmine. Ma al tempo stesso l'inalienabilità del patrimonio e la sua concentrazione in un unico erede comportarono spesso per quest'ultimo l'obbligo di garantire il mantenimento a tutta una serie di aventi diritto, espressamente indicati nel testamento del capofamiglia: fratelli minori, sorelle, madre vedova, zii e zie dal lato paterno, e così via. Questo dovere poteva essere inteso in due sensi diversi: o come obbligo di provvedere una volta per tutte alla sistemazione dell'avente diritto, o come mantenimento in casa vita natural durante. Nel primo caso rientrano le doti matrimoniali per le figlie e le sorelle, che costituivano una delle voci d'uscita più onerose della famiglia nobile. Nei paesi cattolici la dote poteva anche essere monastica: in questo secondo caso si trattava di una somma data a un monastero come tassa d'entrata della novizia; e dato che l'esborso era di regola di entità molto inferiore rispetto a quello necessario per accasare una donna nobile, si comprende perché rinchiudere le figlie e le sorelle in un monastero fosse considerato una soluzione molto vantaggiosa per il bilancio domestico. Per i maschi cadetti l'uscita dalla famiglia offriva più numerose alternative: la carriera militare, che rimase per molta parte della nobiltà europea lo sbocco più naturale e consono alle tradizioni del ceto; l'abito religioso, soprattutto all'interno di quegli ordini più vicini a un modo di pensare aristocratico, come i benedettini, i teatini e soprattutto i gesuiti; la carriera ecclesiastica secolare, per raggiungere le più alte dignità in patria o presso la curia romana. Un istituto giuridico che segnala lo stretto legame instauratosi durante l'antico regime tra nobiltà e mondo ecclesiastico fu il giuspatronato laicale: chi deteneva questo diritto (un singolo nobile, oppure i membri di una consorteria parentale) poteva designare un membro della propria famiglia come fruitore della rendita legata a un beneficio ecclesiastico, cioè a un ufficio sacro riservato a un chierico, come un canonicato, una parrocchia, una cappella. In tal modo la fondazione di un giuspatronato rappresentava per una famiglia nobile un vero e proprio investimento economico di lungo periodo, perché consentiva il mantenimento dignitoso di un maschio della famiglia per più generazioni; si potrebbe dire, in conclusione, che un beneficio di giuspatronato laicale era una specie di fedecommesso a favore dei figli cadetti. Finora ci siamo occupati degli istituti giuridici di trasmissione ereditaria dei patrimoni nobiliari. Ma da che cosa erano costituiti tali patrimoni? Pur senza voler minimizzare le peculiarità regionali, un dato pare essere stato comune alle nobiltà dell'Europa d'antico regime: il ruolo fondamentale della terra. L'identificazione fra terra e nobiltà, che è stata sostenuta da molti storici, economisti e sociologi, risulta pienamente condivisibile, se si vuole intendere che le classi dominanti europee del Medioevo e della prima età moderna ebbero come carattere comune e peculiare il dominio sulla terra e sugli uomini che la lavoravano. Allo stesso modo si può giustamente sostenere che fino al Settecento, e in molte regioni - soprattutto, ma non solo, dell'Europa orientale - anche nell'Ottocento, i grandi proprietari terrieri furono in maggioranza nobili. Sarebbe invece riduttivo ritenere che durante l'antico regime l'agricoltura fosse l'unica fonte di ricchezza della nobiltà, perché i patrimoni di molte famiglie mostrano una notevole varietà nelle voci di entrata: ai prodotti derivanti dalla conduzione diretta delle terre, alla rendita fondiaria in denaro e in natura, alla rendita feudale che proveniva dai diritti di natura signorile-feudale di antica origine o ripristinati coattivamente tra XVI e XVII secolo, si affiancavano infatti: i profitti e le quote di compartecipazione ad attività industriali, commerciali, armatoriali, assicurative e bancarie; le rendite finanziarie derivanti dall'investimento in titoli del debito pubblico e da un'intensa attività di piccolo e grande prestito; gli stipendi, le pensioni, i donativi legati al servizio di corte presso un sovrano o ad altri incarichi pubblici retribuiti. Malgrado l'entità e la varietà di tali entrate, una delle caratteristiche proprie dei nobili che emerge con maggiore chiarezza dalle fonti documentarie è la loro propensione all'indebitamento. La spiegazione di questo apparente paradosso va cercata, più che nell'economia, nella storia della mentalità: l'esigenza di mantenere una vita consona al proprio status, in grado di dimostrare la superiorità rispetto ai non-nobili e l'uguaglianza coi pari grado, comportava un livello di spese di lusso che, in presenza di congiunture sfavorevoli, poteva creare nei bilanci familiari cospicui deficit. Tra queste spese una delle più gravose, soprattutto a partire dal tardo Cinquecento, riguardò la costruzione, il restauro e l'abbellimento di edifici di abitazione in città e in campagna. Il palazzo urbano e la villa erano infatti il simbolo tangibile del potere e della durevole preminenza di una famiglia; alcune arterie urbane (come via Toledo a Napoli, o la Strada Nuova a Genova, o il Canal Grande a Venezia) o certi quartieri (come il Marais a Parigi) divennero una sorta di monumento vivente della supremazia nobiliare. Un'altra categoria di spesa molto importante era costituita dagli alimenti; questo tipo di consumo era accresciuto dalla presenza della servitù e dal frequente passaggio di invitati per i quali si amava fare sfoggio di abbondanza e di ricercatezza di cibi. Accanto al vitto deve essere considerato il vestiario, nonché l'acquisto di gioielli e ornamenti vari. Tutto ciò era simbolo della condizione sociale; e infatti le spese per il vitto e per l'abbigliamento non riguardavano solo i membri della famiglia nobile in senso stretto, ma si estendevano alla famiglia allargata che comprendeva i domestici e i servitori. C'erano poi le spese per i mezzi di trasporto, in particolare cavalli e carrozze; le spese per l'istruzione dei figli (che per le nobiltà nordiche comprendeva il grand tour, cioè un periodo di soggiorno in Francia e in Italia) e per le doti delle figlie; le spese per le cure mediche, per i servizi legali, per i funerali e le sepolture, cui vanno aggiunte le elargizioni di tipo caritativo, che incidevano sui redditi nobiliari in misura certo enormemente inferiore rispetto ai salassi provocati da un vizio che era comune a ricchi e poveri: il gioco. Questo flusso inarrestabile di spese poteva essere esiziale per il patrimonio di una famiglia nobile, qualora fossero venuti a mancare alcuni redditi su cui si faceva conto per coprire l'indebitamento: ad esempio, la perdita del favore di un sovrano poteva azzerare la voce di entrata costituita da pensioni e donativi. Tuttavia se molte famiglie rischiarono la rovina, relativamente poche scomparvero in seguito a indebitamento. Piuttosto, l'eventuale insolvenza del nobile provocava un danno più grave e difficilmente rimediabile agli artigiani e ai mercanti che erano stati suoi fornitori di beni e servizi, e che raramente riuscivano a recuperare quanto era loro dovuto. D'altra parte, la propensione al lusso e all'ostentazione della nobiltà fu alla base delle imponenti dimensioni assunte dal gruppo dei servitori, che nel caso delle grandi famiglie dell'aristocrazia feudale o cittadina potevano superare la cinquantina o addirittura avvicinarsi al centinaio. Tra i servitori, alcuni erano più strettamente legati all'economia della casa, altri avevano soprattutto la funzione di rendere palese la posizione di prestigio della famiglia. La servitù comprendeva quindi il maestro di casa o maggiordomo, il guardarobiere, il sovrintendente alla tavola, il cuoco, il giardiniere, lo stalliere, il palafreniere, lo staffiere, ma anche il segretario, il bibliotecario, il precettore, il cappellano. La legislazione sulla nobiltà nel Settecento Da quanto si è detto in precedenti capitoli, risulta evidente la persistenza lungo i secoli dell'età moderna di una varietà di criteri atti a legittimare la nobiltà di una famiglia e di un individuo, ma anche la difficoltà da parte delle autorità statali di imporre norme universalmente valide ed effettivamente osservate in materia di nobiltà all'interno del territorio sottoposto alla loro sovranità. Da qui deriva la difficoltà per lo studioso odierno di dare un'attendibile valutazione quantitativa della nobiltà nei diversi Stati europei nel corso di quei secoli. Si può dire che in alcune aree (come la Spagna, l'Ungheria, la Polonia) i nobili costituivano una percentuale della popolazione relativamente elevata, compresa forse tra il 5 e il 10%; mentre in Francia e in Svezia la percentuale doveva essere nettamente inferiore, fra l'1 e il 3%. Ma come estendere il calcolo all'Italia, dove potevano legittimamente definirsi nobili perfino le famiglie dei centri minori (i borghi e le terre), in cui si fosse attuata una separazione di ceto nell'accesso ai consigli? È corretto o meno comprendere anche queste famiglie tra quelle della nobiltà italiana? E che dire dell'Inghilterra, dove l'entità numerica dei nobili varia in modo macroscopico a seconda che si calcolino solo i lords e la nobiltà in possesso di un titolo acquistato (come quello di baronet, introdotto al principio del Seicento dal re Giacomo I), oppure anche i semplici gentlemen? Questa medesima difficoltà riguarda pure il Settecento, anche se progressivamente si impose in quel secolo la volontà da parte dei governi di riconoscere senza ombra di equivoco chi fosse nobile, e dunque potesse legittimamente godere di tutta una serie di privilegi (primo fra tutti quello fiscale) nell'ambito dello Stato. Come ha scritto lo storico francese Jean-Pierre Labatut, "nel secolo XVIII si fece sistematica la politica intesa a eliminare dai ranghi della nobiltà quei nobili che vantavano la loro appartenenza all'ordine senza averne sufficiente titolo". Così ci si sforzò di far funzionare meglio, dove già esistevano, o di creare ex novo dove non se ne aveva traccia, gli uffici araldici, preposti a questa funzione di controllo e registrazione; e inoltre furono emanate leggi che definivano senza ambiguità le condizioni richieste per il legittimo possesso dello status nobiliare. Da questo punto di vista risulta di notevole interesse il caso degli Stati regionali italiani, dove (a parte qualche eccezione, come i domini dei Savoia) era mancata fino alla metà del XVIII secolo una legislazione che precisasse senza equivoci i criteri di accesso alla nobiltà su base non locale, ma appunto statale. Esamineremo qui due casi, quello toscano e quello napoletano. È del 1750 la legge sulla nobiltà e cittadinanza per il granducato di Toscana, che un quindicennio prima era passato dal governo di casa Medici a quello di Francesco Stefano di Lorena, marito di Maria Teresa d'Austria e dal 1745 imperatore germanico. Il primo articolo della legge elencava coloro che, per essere riconosciuti come veri nobili, dovevano presentare documenti autentici a una deputazione di ministri granducali che li avrebbe iscritti in un libro d'oro: "tutti quelli che posseggono o hanno posseduto feudi nobili, e tutti quelli che sono ammessi agli ordini nobili, o hanno ottenuto la nobiltà per diplomi nostri o de' nostri antecessori, e finalmente la maggior parte di quei che hanno goduto e sono habili a godere presentemente il primo e più distinto onore delle città nobili loro patrie". Nell'ordine, dunque, la legge elencava i feudatari, che in Toscana erano in stragrande maggioranza di creazione granducale (cioè di epoca successiva alla metà del Cinquecento), i membri degli ordini cavallereschi, e in particolare dell'ordine di santo Stefano creato dal granduca Cosimo I de' Medici nel 1562, coloro che avevano ottenuto diplomi di nobiltà dallo stesso Cosimo e dai suoi successori, e infine i patrizi delle città maggiori (Firenze, Siena e altre cinque) che potevano vantare origini risalenti all'epoca repubblicana, quando la nobiltà in Toscana si estrinsecava nella partecipazione alle magistrature supreme di una città. In tal modo questo articolo della legge del 1750 capovolgeva il tacito ordine di precedenza, conservatosi anche dopo il passaggio dalle forme comunali e repubblicane di governo a quelle principesche, in virtù del quale la vera nobiltà toscana continuava a essere quella che discendeva dai cittadini di governo al tempo delle libertà comunali. Ma in un successivo articolo della legge era espressamente salvaguardata la peculiarità sociale dei ceti dominanti toscani, in quanto si diceva che in nessun modo avrebbero derogato alla nobiltà la gestione di case di negozio o banchi di cambio, l'immatricolazione nelle arti della lana o della seta, la professione medica, l'avvocatura, la pittura, la scultura, l'architettura civile e militare. Una simile esplicita equiparazione tra nobiltà e professioni borghesi non era certo una novità per le consuetudini toscane: la novità consisteva nel fatto che il documento che la riportava non era una consulta giuridica o un trattato letterario, ma un testo legislativo promulgato da un sovrano lorenese-austriaco. In conclusione, l'importanza di una legge come questa risiedeva da un lato nel riuscito compromesso tra una visione gerarchico-feudale propria dei nuovi ministri stranieri e le tradizioni delle famiglie patrizie toscane, e dall'altro nell'affermazione rigorosa che la fonte del riconoscimento della nobiltà risiedeva nell'autorità del sovrano. Nel regno di Napoli, che dal 1734 era governato da un ramo dei Borbone di Spagna, un dispaccio regio del 1756 distinse la nobiltà in tre classi. Al vertice si collocava la nobiltà generosa, comprendente sia le famiglie che possedevano feudi da almeno due secoli (e cioè dall'epoca di Carlo V, precedente all'ondata di infeudazione che aveva caratterizzato la politica spagnola nel Napoletano soprattutto dalla seconda metà del Cinquecento in poi), sia gli ammessi ai consigli nobili delle città regie (cioè la cosiddetta nobiltà di seggio o di piazza), sia coloro che potevano dimostrare la discendenza da un avo che "per la gloriosa carriera delle armi, della toga, della chiesa o della corte avesse ottenuto qualche distinto e superiore impiego o dignità", e soprattutto la continuità nella famiglia di un modo di vita nobile senza alcuna caduta nell'esercizio di arti meccaniche e ignobili. C'era poi la nobiltà per privilegio, che il sovrano concedeva per servizi prestati allo Stato in impieghi giudiziari, militari o di corte. Infine, la nobiltà legale ossia civile, riconosciuta a chi poteva dimostrare per sé, il padre e l'avo di aver vissuto "sempre civilmente con decoro e comodità" e di godere presso il pubblico della nomea di uomini onorati e da bene. Una tale divisione non era fine a se stessa, ma si collegava alla riforma dell'esercito: i cadetti dei reggimenti provinciali, destinati a diventare capitani o alfieri, potevano essere reclutati solo tra i nobili generosi; per essere ammessi negli altri corpi di fanteria e cavalleria bastava la nobiltà per privilegio; per diventare cadetti nelle truppe era sufficiente la nobiltà civile. È importante osservare che, per essere accolti in uno dei tre gradi, erano richieste prove legali in larga parte coincidenti con quelle previste per l'ammissione all'ordine dei cavalieri di Malta; in tal modo, quelli che erano stati criteri sovranazionali e sovrastatali per il riconoscimento della nobiltà diventavano parte integrante della legislazione con cui uno Stato definiva i confini e i gradi della propria nobiltà nazionale. Gli elementi che accomunano queste due leggi, e tante altre emanate nello stesso volger d'anni, sono soprattutto tre: il costante richiamo al diritto-dovere del monarca di fissare i criteri di nobilitazione; la validità di queste norme per tutto il territorio di uno Stato, col conseguente superamento sia della consuetudo loci sia dei patti bilaterali tra il sovrano e una specifica città o provincia a lui subordinata; l'affermazione del principio che la nobiltà era una classe della società. Su quest'ultimo punto vale la pena di soffermarsi, perché segna una svolta epocale non solo per quanto concerne la nobiltà, ma per l'intera storia costituzionale dell'Europa d'antico regime. La nobiltà da classe della società a premio del merito personale Come è emerso in più occasioni nel corso di questa esposizione, il concetto di nobiltà teorizzato, divulgato e comunemente accolto dal Medioevo al Seicento aveva connotazioni non solo politiche, economiche e sociologiche, ma anche etiche e talvolta antropologiche. In altre parole, il nobile si definiva e si distingueva dagli altri uomini non solo per il suo potere di comando, per la sua ricchezza e per l'appartenenza a un gruppo omogeneo, ma anche per una virtù legata al sangue, che lo rendeva indiscutibilmente degno e meritevole di una serie di privilegi. Come ha scritto lo storico inglese Michael L. Bush, "privilegio e nobiltà erano così strettamente connessi, che la seconda non era pensabile senza il primo"; mentre il già citato Labatut ha ricordato che "la legittimità della nobiltà poggiava sulla convinzione che dovesse esistere un ordine in cui la disuguaglianza costituiva una necessità dell'organizzazione sociale: e ciò era un fatto voluto da Dio". Una serie di processi politici e culturali, maturati tra la fine del Seicento e la metà del Settecento, epoca che è stata felicemente definita della 'crisi della coscienza europea', misero in discussione anche l'intangibilità di questo legame tra privilegio e nobiltà. Molti uomini di lettere e di scienze di quei decenni, spesso di origine nobile, tra i quali ci limiteremo a ricordare per la Francia il signor de Fénelon, e per l'Italia il marchese veronese Scipione Maffei, sostennero che i nobili dovevano meritarsi i loro privilegi attraverso l'impiego in funzioni svolte per utile pubblico. In altre parole, il nobile poteva giustificare la sua esistenza sociale in quanto imprenditore agricolo, scienziato, medico, professore di università, non più in quanto appartenente a un ordine privilegiato grazie a due qualità ereditarie come la virtù e l'onore. Quest'idea, sia pur fieramente contrastata dai difensori dell'ordine tradizionale, fu un caposaldo della riflessione di alcune tra le più importanti correnti culturali settecentesche. Oltre ai nomi notissimi di Voltaire e Montesquieu, ricorderemo la scuola fisiocratica, che identificò la classe dei nobili con quella dei proprietari, primi motori dell'accrescimento del prodotto netto dello Stato; o il giuseppinismo austriaco, che considerava come campo proprio della nobiltà la pubblica amministrazione; o ancora il gruppo degli illuministi lombardi, tra i quali Pietro Verri (che era un patrizio milanese) identificò la nobiltà con la classe dei direttori "che rappresentano la maestà del sovrano, i tribunali, i giudici, i soldati, i ministri della religione", mentre Alfonso Longo scrisse che la nobiltà meritava di sopravvivere solo se si fosse conformata all'"ordine naturale più vantaggioso alle società politiche". Assumere un tale punto di vista poteva però comportare anche una critica radicale della situazione esistente: se il criterio doveva essere quello dell'utilità sociale e del servizio pubblico, che senso aveva continuare a credere in un onore ereditario? Il barone d'Holbach espresse con chiarezza questa posizione, auspicando in un'opera pubblicata nel 1776 che il legislatore "accordasse la nobiltà, le dignità, le decorazioni di ogni specie soltanto a coloro che si facessero notare per le loro personali qualità". Non c'è dunque da stupirsi se, dati questi precedenti, la questione della nobiltà fosse all'ordine del giorno fin dagli esordi della Rivoluzione in Francia. Nel suo famoso opuscolo del 1789 l'abate Sieyès scriveva che "l'ordine dei nobili non trova posto nell'ordine sociale; esso non solo è un peso per la nazione, ma non potrebbe nemmeno farne parte. Una tale classe è senza dubbio, per il suo 'non fare nulla', estranea alla nazione". Il celebre preambolo della seduta dell'Assemblea nazionale del 4 agosto 1789 avrebbe proclamato che "non esistono più nobiltà né aristocrazia, né distinzioni ereditarie né distinzioni di ordini, né regime feudale, né giustizie patrimoniali, né alcuno dei titoli, denominazioni e prerogative che ne derivano, né alcun ordine di cavalleria, né alcuna delle corporazioni o distinzioni per le quali era necessario provare la propria nobiltà, o che implicavano delle distinzioni di nascita, né qualunque altra superiorità che non sia quella dei pubblici funzionari nell'esercizio delle loro funzioni". Questo principio così solennemente affermato conteneva in sé un'idea destinata a grandissima fortuna, anche presso i nobili che, superata la bufera rivoluzionaria, sarebbero stati riaccolti nell'amministrazione napoleonica: l'idea del merito. Come scrisse nel 1815 Giandomenico Romagnosi a bilancio dell'epoca appena trascorsa, "non si può ammettere la nobiltà [·^^] come un ordine dello Stato", o come una base organica della monarchia nazionale rappresentativa; l'unica nobiltà da conservare era quella personale e vitalizia "per affezionare e premiare le persone le quali più delle altre influiscono su lo Stato o per i loro meriti o per la loro possidenza". Tra la metà del Settecento e l'epoca napoleonica si era dunque consumata la plurisecolare vicenda dell'egemonia nobiliare in Europa. Ciò dipendeva da vari fattori: oltre a quelli ricordati nelle pagine che precedono, val la pena di ricordare il controllo sempre maggiore assunto dalle nuove strutture degli Stati su ambiti di potere prima controllati dai nobili, come la giustizia locale, e per i paesi cattolici il venir meno del potere economico e giurisdizionale della Chiesa di Roma, che per molti aspetti aveva costituito fin dal tardo Medioevo uno storico alleato dei ceti nobiliari.Giunti al primo Ottocento, la storia della nobiltà in Europa si potrebbe considerare esaurita. Ma un simile punto di vista non terrebbe conto di una interpretazione oggi molto in auge, secondo la quale fino al 1848, o addirittura fino al 1914 (come ha sostenuto tra gli altri lo storico americano di origine tedesca Arno J. Mayer) i nobili "permearono dei loro valori l'apparato statale [...] occupando posizioni-chiave nei nuovi eserciti e burocrazie". Questo fenomeno si inseriva nel quadro di un più generale neofeudalesimo, che si accompagnò alla permanenza dell'antico regime fino alla prima guerra mondiale. La tesi è suggestiva, ma difficilmente potrebbe essere accolta per l'intera Europa in queste forme estremizzanti. Anche se in gran parte degli Stati la nobiltà conservò fino agli ultimi decenni dell'Ottocento e oltre una larga quota del possesso fondiario, e partecipò al servizio statale soprattutto nell'esercito e nella diplomazia, ciò non dipese da un legame organico e riconosciuto (salvo forse che in Prussia e in Russia) tra nascita, ricchezza, signoria fondiaria e potere nello Stato. Come ha scritto con efficacia il già citato Otto Brunner, "nel secolo che seguì il 1848 fu ancora possibile essere un 'aristocratico', un 'signore', un 'gran signore', ma soltanto per l'atteggiamento interiore, lo stile di vita, le relazioni personali con altri. Nessuno ormai da tempo era più signore dei sudditi per diritto proprio". Con un'immagine pregnante aveva espresso un'idea simile, nella prima metà dell'Ottocento e dunque poco dopo il tramonto dell'antico regime, il grande romanziere Honoré de Balzac: "oggi non c'è più una nobiltà, c'è soltanto un'aristocrazia".
La politica nobiliare del Regno d'Italia 1861-1946...........GIORGIO RUMI Publications de l'École Française de Rome Année 1988
|
Segnamoci questa data del 955 in cui l'uomo che diverra' Ottone I di Sassonia sgominò a Lechfeld, il 9 agosto, un grande esercito di Ungari
in questi anni effettivamente inizia la ricostruzione europea
Ricostruzione che avverra' sotto forme sociali molto diverse in modo particolare nella nostra Italia centro settentrionale

Ora l'Italia dovra' vedersela con gli imperatori tedeschi
Ma ancora una volta possiamo notare come il controllo del territorio era di fatto estremamente scarso . E i signori feudali italiani ebbero per tempi molto brevi un effettivo controllo del Territorio e come le CITTA' fossero nuovamente pronte a riprendere uno spazio politico
Ma che ne e' del potere pubblico intorno al 1000
Che succede in Toscana tra il 955 ed il 1113 anno in cui muore Matilde
Con la locuzione lotta per le investiture si fa riferimento allo scontro tra Papato e Sacro Romano Impero che si protrasse dal 1073 fino al 1122, riguardante il diritto di investire (cioè di nominare) gli alti ecclesiastici e il Papa stesso.
Durante il Medioevo l'investitura era un atto con il quale, attraverso un rito detto omaggio, un signore, il senior, conferiva a un'altra persona, il vassus, un possesso o un diritto, il beneficium. Nell'XI secolo i sovrani laici ritenevano una loro prerogativa il potere di nominare vescovi e abati di loro scelta, e quindi investirli spiritualmente, come conseguenza di aver affidato a loro dei beni materiali. Tale consuetudine dava al potere temporale una supremazia su quello spirituale e ciò si era tradotto in un profondo fallimento del clero, non in grado di svolgere la propria funzione.
La controversia tra Papato e Imperatore fu determinata dalla preminente influenza a mano a mano assunta dall’imperatore nella promozione dei chierici alle dignità ecclesiastiche, alle quali invece secondo le norme canoniche dovevano essere designati soltanto mediante libera elezione dal clero e dalla comunità dei fedeli. Già con Carlomagno il potere regio aveva cominciato a intervenire nella nomina dei vescovi e degli abati. Successivamente, con la creazione della feudalità ecclesiastica, sviluppatasi soprattutto in Europa occidentale durante i regimi dei sovrani della casa di Sassonia (imperatore Ottone I), l’ingerenza dei laici nelle cose ecclesiastiche aumentò ancor più mediante la pratica, connessa con il conferimento del beneficio feudale, dell’i. (donde la denominazione, appunto, di lotta per le i.): questa si mostrò fattore determinante della corruzione e della simonia ecclesiastica, che apparvero così legate istituzionalmente alla sottomissione delle cose ecclesiastiche alle compromissioni del gioco politico. Il Papato, scaduto di prestigio e ridotto al rango di una forza in cui si facevano valere agenti di potere locale, ebbe, il più delle volte, a subire l’iniziativa dell’Impero, che, talora, si rivelò di fatto moralizzatrice, pur perseguendo finalità politiche contingenti.
I primi tentativi di un movimento di riforma della vita ecclesiastica presero le mosse dall’abbazia di Cluny in Borgogna, già nel 10° sec.; ma solo verso il 1050, per impulso specialmente dell’opera svolta nella cancelleria papale da Ildebrando di Soana (poi papa Gregorio VII), la lotta contro la simonia e il più generale problema delle investiture divenne argomento di misure disciplinari e di decisioni canoniche.
Sotto il pontificato di Niccolò II, nel Concilio Lateranense del 1050, il problema della riforma della Chiesa fu posto in termini nuovi: sganciamento del Papato dalla preponderante influenza dell’Impero da un lato, ed eliminazione dell’ingerenza laica nelle cose ecclesiastiche dall’altro. Mentre infatti si stabilì che il pontefice d’allora in poi fosse eletto, con esclusione di un intervento diretto imperiale, dal collegio dei cardinali, si fece aperto divieto a chiunque di ricevere una chiesa dalle mani di un laico; divieto ribadito da Alessandro II nel 1063 e, con esplicito riferimento ai vescovi, da Gregorio VII nel 1075.
Con il decreto gregoriano comminante la scomunica ai contravventori, laici ed ecclesiastici, delle norme disciplinari statuite dal Concilio Lateranense del 1059, e insieme con l’affermazione, su un piano teorico, della volontà accentratrice di Gregorio VII nel Dictatus papae, la lotta delle investiture entrò nella sua fase decisiva, che fu condotta senza esclusione di armi, materiali e spirituali.
Durante il lungo e drammatico contrasto tra papa Gregorio VII e l’imperatore Enrico IV, il problema dell’investitura ecclesiastica da parte del laicato divenne un aspetto di quello generale dei rapporti tra Impero e Papato, dei rispettivi limiti e delle loro interferenze.
La lotta, proseguita anche dai successori immediati di Gregorio, Vittore III (1086-87) e Urbano II (1088-99), sempre contro l’imperatore Enrico IV, si attenuò durante il pontificato di Pasquale II (1099-1118), il quale nel 1111 a Sutri si dichiarava disposto alla rinuncia di ogni beneficio feudale a vantaggio di vescovi e abati, in cambio di una vera libertà della Chiesa, in tal modo resa indipendente dall’ingerenza del potere imperiale: rinuncia, tuttavia, che restò lettera morta, per l’opposizione dei contrastanti interessi, subito insorti violentemente a impedirne l’attuazione.
La lotta per le investiture e' disputa che oppose, dall’ultimo quarto dell’11° sec. sino al concordato di Worms (1122), il papato e l'Impero per la preminenza nel conferimento (l'investitura) delle dignità ecclesiastiche di vescovo e abate ai chierici.
I primi movimenti intesi ad ottenere una maggior indipendenza della Chiesa si ebbero già all'inizio del 900 all'interno dell'ambiente monastico, ma fu nel secolo successivo che una vera riforma si diffuse in tutta la Chiesa. L'apice di suddetta riforma si ebbe durante il pontificato di papa Gregorio VII (iniziato nel 1073), il quale, fervente sostenitore del primato papale sopra qualsiasi altro potere, entrò duramente in conflitto con l'imperatore Enrico IV di Franconia, dando inizio alla lotta per le investiture. Lo scontro ebbe risvolti gravi e inediti, con l'imperatore che arrivò ad ordinare al pontefice di dimettersi dal proprio ruolo e questi, per tutta risposta, giunse a scomunicare e deporre il primo. Celebre il viaggio che Enrico intraprese nel 1077 per chiedere perdono a Gregorio VII, ospite in quel tempo della contessa Matilde di Canossa, affinché gli togliesse la scomunica e quindi ripristinasse il dovere di obbedienza da parte dei suoi sudditi, già sollevati contro di lui. Il pontificato di Gregorio terminò tuttavia nel peggiore dei modi: venne eletto un antipapa, Clemente III, mentre il pontefice morì in esilio a Salerno sotto la protezione del normanno Roberto il Guiscardo.
Il confronto perdurò anche con i successori di Gregorio VII, per poi terminare nel 1122, quando papa Callisto II e l'imperatore Enrico V si accordarono con la stipula del concordato di Worms. L'accordo prevedeva che la scelta dei vescovi ricadesse sulla Chiesa e che poi essi prestassero giuramento di fedeltà al monarca secolare; si andava affermando il diritto esclusivo della Santa Sede ad investire le cariche ecclesiastiche con l'autorità sacra, simboleggiata dall'anello vescovile e dal bastone pastorale;
oltre a riaffermare i deliberati del 1059 in ordine alla libertà dell’elezione papale (peraltro osservati raramente nello stesso periodo della lotta), escluse qualsiasi intervento laico dall’investitura spirituale; se nel regno di Germania l’imperatore conservava la possibilità di influire sulle elezioni alle sedi episcopali e abbaziali, tale possibilità era esclusa invece in Italia e in Borgogna. Con la lotta per le investiture il Papato iniziò il processo di svincolamento dalla tutela del potere imperiale, diventando l’unico e sovrano regolatore e giudice dell’ordinamento interno della Chiesa; infatti gli imperatori del Sacro Romano Impero rinunciarono al diritto di scegliere il pontefice.
l'imperatore conservava solo il diritto di presiedere alle elezioni di tutte le alte cariche ecclesiastiche e di arbitrare le controversie.
PREMESSA Solo nel 877 il vescovo Guibodo ricevette in dono da Carlomanno la corte regia di Parma, questa donazione fu un atto di ringraziamento da parte del re al vescovo che aveva parteggiato per il padre di Carlomanno, Ludovico II il Germanico,nella sfortunata lotta per il titolo di imperatore.
Ebbe così inizio il potere temporale dei vescovi su Parma e Guibodo decise subito di dotarsi di un consiglio che lo affiancasse nella gestione degli affari spirituali e temporali, per questo il 29 dicembre dello stesso anno alla presenza dei vescovi delle città limitrofe annunciò la nascita del Capitolo della Cattedrale di Parma.
Nell’891 Guido II di Spoleto, imperatore (891-894) e re di Italia (889-894) istituì la marca di Lombardia e vi incluse i comitati di Parma, Piacenza, Reggio e Modena. In quella fase storica, tuttavia, si stava realizzando la trasformazione del potere comitale in quello politico episcopale.
Tuttavia occorre considerare che la donazione di Carlomanno era a titolo personale per cui Guibodo nel suo testamento del 892 predispose che i beni passassero prima alla consanguinea Vulgunda e infine ai canonici del capitolo della Cattedrale.[15] Il possesso dei beni venne confermato a Guibodo da Arnolfo di Carinzia nel 894, quindi alla morte del vescovo, avvenuta nel 895 dC, i canonici del Capitolo della cattedrale, dopo la parentesi di possesso dei beni da parte di Vulgunda, esercitarono il potere temporale sulla corte regia di Parma e su tutti i territori limitrofi che erano stati donati a Guibodo.
I beni confermati al capitolo, oltre che alla corte regia di Parma, constavano di un vasto territorio della bassa parmense che andava grossomodo da Caput Parioli a nord di Fontanellato spingendosi alle porte di Soragna, comprendendo il territorio di San Secondo e Palasone sino a spingersi a Sacca di Colorno. I territori assegnati a Parma comunque erano inferiori a quelli che possedevano allo stesso tempo altri episcopati e questo è dovuto al fatto che il potere temporale del vescovo arrivò in ritardo rispetto ad altri luoghi, ciò comportò un dominio a macchia di leopardo sul territorio essendo molti feudi del parmense già assoggettati al potere temporale di altri enti ecclesiastici
Alle origini del Comune italiano come realtà istituzionale e politica
http://www.secondanavigazione.net/Ottone%20a%20Uberto.html
Il testo che segue è un documento importante che bisogna conoscere per studiare le origini storiche e il significato istituzionale dei Comuni italiani. Il testo è del 962, precede quindi di un secolo la nascita attestata dei Comuni, ma illumina su una condizione indispensabile per la loro genesi.
Si tratta del diploma concesso da Ottone I al vescovo di Parma. In esso l’imperatore concede al vescovo l’immunità dal potere dei conti che esercitavano la loro signoria nelle campagne circostanti. In sostanza questo significa che la città dove il vescovo risiede, non sarà più sottomessa al potere pubblico dei conti, ormai incontrollabili dal potere imperiale e tendenti a signoreggiare anche con arbitrio sugli abitanti delle campagne. La città, diventando autonoma dal potere comitale, acquisisce un’autonomia giuridica. Adesso è il vescovo che assume il potere pubblico nella città. Gli abitanti di questa cominciano a considerare il vescovo non come un signore-padrone (questo tipo di signoria era quella del conte di campagna), ma come un funzionario pubblico legittimato dall’imperatore. Il vescovo riveste un potere giuridico, fondato sul diritto e non sull’arbitrio, e funzionale al benessere pubblico. I cittadini sottomessi a un potere riconosciuto e legittimato si sentono più liberi degli abitanti di campagna, ormai ridotti alla condizione servile quale che fosse il loro status originario.
Ottone I a Uberto vescovo di Parma, 962
In nome della santa e individua Trinità, Ottone, imperatore Augusto per disposizione della divina Provvidenza… Sia a conoscenza di tutti i fedeli della santa Chiesa e nostri, tanto presenti come futuri, la solerzia, come Uberto, vescovo della chiesa di Parma, presentandosi alla nostra clemenza ha chiesto che noi, giovando alla sua chiesa, al modo dei nostri predecessori, lo arricchissimo di quelle cose che spettavano al regio potere e alla pubblica funzione, e specialmente di quelle per le quali la sua chiesa veniva lacerata da parte del comitato, cioè che noi trasferissimo le cose e i servi tanto di tutto il clero di quello stesso vescovato in qualunque luogo si trovino, quanto di tutti gli uomini che abitano dentro la medesima città dalla nostra giurisdizione alla giurisdizione e dominio e distretto della santa Chiesa, così che abbia la potestà di deliberare e decidere tanto sulle cose e sui servi del clero sopraddetto, quanto anche sugli uomini che abitano dentro la stessa città e le cose e i servi loro, come se fosse presente il conte del nostro palazzo. Noi, considerando e valutando l'utilità per la dignità dell'impero sopraddetto e per tutti i mali che spesso accadono fra i conti di uno stesso comitato ed i vescovi della medesima Chiesa, perché sia eliminata interamente ogni passata lite e scisma e perché lo stesso vescovo con il clero a lui affidato viva pacificamente e attenda senza alcuna molestia alle preghiere, tanto per la salvezza nostra come per la stabilità del regno e di tutti coloro che vivono nel nostro regno, concediamo e permettiamo e dal nostro diritto e dominio trasferiamo nel di lui diritto e dominio completamente e gli affidiamo le mura della stessa città ed il distretto ed il teloneo [imposta sul mercato]ed ogni altra pubblica funzione tanto entro la città quanto fuori da ogni parte della città per lo spazio di tre miglia attorno, segnato e determinato nella linea di confine con pietre terminali… e le strade regie e il corso delle acque e tutto il territorio coltivato e incolto ivi giacente e tutto ciò che è di pertinenza dello Stato. Inoltre concediamo anche che tutti gli uomini abitanti nella città e nel territorio sopraindicato, ovunque abbiano beni ereditari o acquisiti, o dei servi, tanto nel comitato parmense, quanto nei comitati vicini, non corrispondano alcuna prestazione ad alcuna persona del nostro regno, né osservino il placito di chiunque se non del vescovo di Parma che sarà in carica in quel momento, ma abbia il vescovo della stessa chiesa licenza, come se fosse il conte del nostro palazzo, di definire, deliberare e decidere di tutte le cose e dei servi tanto di tutti i membri del clero dello stesso vescovato, quanto anche di tutti gli uomini che abitano entro la predetta città, con contratto di affitto, di livello ovvero di precaria, ovvero castellani e così trasferiamo dal nostro diritto e dominio nel suo diritto e dominio…
Il potere Temporale concesso a Uberto e' fondamentalmente legato a questa concessione che sancisce una sorta di nascita legale di una sorta di proto--Comune con un'autorita' che si estende fuori le mura in maniera circoscritta alle tre miglia
E vi e' una sorta di spartizione del comitato tra la citta' ed i conti del territorio ( e siamo sempre a parlare dell'enorme difficolta' a gestire il territorio da parte dell'impero costretto nonostante la forza degli Ottoni ad accettare il ricatto dei potentati locali )
UBERTO
ante 951-Parma dicembre 980
Dal 951 al 980 occupò la carica di Cancelliere di Berengario e di re Adalberto, poi di arcicancelliere dello stesso Adalberto e, dopo essere stato eletto Vescovo di Parma, di Arcicancelliere dell’Impero e d’Italia sotto Ottone il Grande e sotto Ottone II. La prima volta Hubertus cancellarius compare quando Berengario e re Adalberto confermarono da Pavia il 17 gennaio 951 al monastero di San Sisto in Piacenza le corti di Guastalla, Campo Miliacio, Cortenova, Sesto, Luzzara, Villola e Pegognaga con ogni dipendenza e il monastero di Cotrebbia. Da Pavia, come capo effettivo della cancelleria, sottoscrisse diversi diplomi, riconfermando possessi e diritti, il 23 gennaio e il 22 settembre e da San Marino il 26 settembre dello stesso anno. Dopo alcuni anni lasciò la carica di Cancelliere ma riappare come tale in diplomi di Berengario e di Adalberto sottoscritti in Verona il 13 gennaio 958, in Pavia il 18 luglio dello stesso anno e il 25 ottobre 958 o 959. Berengario e Adalberto, da Ravenna, il 24 aprile 960 donarono al loro fedele Guido alcune corti in Toscana addivenendo alle preghiere del conte Amizo e di Huberti episcopi nostrisque dilecti fidelis, che sottoscrisse il diploma come cancelliere. Uberto, dunque, già eletto Vescovo della Chiesa parmense, tuttavia continus a coprire l’alto ufficio di Cancelliere. Come Vescovo e Arcicancelliere di re Adalberto, compare ancora in un diploma da Arezzo del 28 febbraio 961, con la sottoscrizione ad vicem Huberti episcopi et archicancellarii, e come Cancelliere di Berengario e di re Adalberto in un diploma da Verona del 30 maggio 961. Dopo che Berengario mosse guerra ad Adalberto Attone presso Canossa, i signori italiani, ormai stanchi dei continui conflitti, chiamarono l’Imperatore alla Dieta convocata in Milano e nell’ottobre 961 vennero deposti Berengario e Adalberto. Ottone I, eletto re d’Italia nel novembre, si portò poco dopo a Roma, ove il 2 febbraio 962 fu incoronato imperatore da papa Giovanni XII. Il 13 febbraio confermò solennemente alla Santa Sede tutti i possessi concessi da Pipino, Carlo Magno e da altri. Il patto ottoniano col Pontefice fu firmato da Uberto, che si trovava a Roma: Signum Hucberti Parmanensis ecclesie episcopi.
Il privilegio è ritenuto originale dal Baronio, dubbio invece dal Muratori. Nonostante la risoluzione presa dal re Ugo al fine di assicurare Uberto e la sua Chiesa da ogni prepotenza, tuttavia i conti del contado continuarono a molestarlo. Uberto non tardò a esporre i bisogni della sua Chiesa al nuovo imperatore, pregandolo di provvedere perchè in avvenire non fosse più minacciata da alcuno. L’Imperatore, da Lucca, il 13 marzo 962 concesse a Uberto presulis nostri karissimi fidelis le più ampie immunitl. L’Imperatore cedette a Uberto ogni diritto e il pieno dominio della cittl, le mura, il teloneo, il distretto e ogni pubblica funzione regia tanto sulla cittl che fuori per un raggio di tre miglia determinato dalle ville e castelli seguenti: a oriente di Beneceto, Casello e Coloreto, a mezzodo di Porporano, Alberi e Vigheffio, a sera di Vicofertile, Fraore ed Eia, a nord di Baganzola, Casale Pancarano e Terabiano, con tutte le loro adiacenze e pertinenze. Cedette inoltre le vie regie, il corso delle acque, il territorio adiacente e ciò che apparteneva alla pubblica cosa. Ordinò poi che gli uomini della città o abitanti entro i confini sopraindicati fossero chiamati in giudizio dal solo Uberto per ragioni di eredità o di lite, il quale avrebbe giudicato tamquam noster comes palatii. Il solo Uberto avrebbe potuto decidere, definire e deliberare intorno alle cose e alle famiglie, tanto dei chierici che di tutti gli uomini residenti nella terra dello stesso Vescovado, mentre nessun marchese, conte e visconte avrebbe potuto esercitare qualsiasi pubblica funzione. Concesse a Uberto la potestà di eleggere e ordinare i notai, i quali, dovendo discutere le cause dello stesso vescovado, avrebbero ricevuto i testamenti senza alcuna proibizione o controversia del conte del contado. Se non si fosse potuto giudicare senza contrasto, concedimus ejusdem episcopi vicedomino ut sit noster missus, avendo la potestl di deliberare, definire e giudicare tamquam noster comes palatii. Uberto si trovò presente a Pavia a un placito del 27 settembre 962 dato dal marchese Oberto, conte di palazzo. Si sottoscrisse Hubertus Ep. interfui. Uberto fu tenuto in grande estimazione da Ottone I, che a San Leo il 10 maggio 963 concesse un privilegio ai canonici di Arezzo consultu et interventu venerabilis episcopi Huberti fidelis nostri. Uberto fu a Roma con l’Imperatore nell’autunno del 963. Si trovò presente al sinodo romano del 4 dicembre convocato per deporre il papa Giovanni XII (Liutprando, Storia di Ottone I). Secondo Raterio, vescovo di Verona, in quel congresso Uberto fu reputato degno di governare la Chiesa di Dio. L’Imperatore lo delegò suo messo a giudicare in Toscana con il marchese Oberto, conte di palazzo. A Lucca il 9 agosto 964 Uberto, quale missus domni Imperatoris, fu presente al giudizio presieduto dal marchese Oberto, che riconobbe i diritti della Chiesa di Reggio. Il 24 dicembre si trovò di nuovo a Roma e fu presente quando Ottone confermò la donazione fatta ad Adelaide, badessa del Monastero di Santa Maria Maggiore presso l’antico palazzo imperiale, da Fazio, suo nipote. Uberto dovette certamente essere assai dotto e stimato, se meritò l’amicizia di Raterio, vescovo di Verona, il quale non solo gli dedicò il suo trattato (De contemptu Canonum, scritto nel 964) ma volle anche donare alla Chiesa parmense certi terreni che possedeva nel contado. Ottone elevò Uberto alle più alte cariche: lo nominò suo Arcicancelliere del Regno d’Italia (2 dicembre 966-28 marzo 973) e lo elesse anche Arcicancelliere dell’Impero, nella quale altissima carica rimase dell’8 luglio 967 al 29 giugno 968. Come capo delle due cancellerie dovette accompagnare ovunque la Corte e trattare delle cose pubbliche italiche e germaniche. Dopo un anno o poco meno dalla sua elezione, si determinò a rinunciare al cancellierato germanico. Il 2 dicembre 966, in Pisa, Ottone I concesse, precibus Huberti episcopi dilecto, fidelique nostro, le più ampie immunità a Pietro, vescovo di Volterra.
E' in questo diploma che Uberto compare la prima volta con la qualifica di Arcicancelliere: ad vicem Uberti archicancellarii. A Monte Veltraio il 12 giugno 967 Uberto intervenne come missus nel giudizio presieduto dal marchese Oberto, conte di palazzo, per una lite tra il monastero di Santa Fiora e Sant’Andrea e i Valcheri. Da Ravenna, Ottone nel 968, su richiesta di Uberto, concesse il permesso di istituire il mercato alla insula Pergamensis nel luogo detto di San Sisinio, nel giorno della festa, e di edificare in una certa altra localitl un porto per la sicurezza delle barche veneziane, chioggiote e ferraresi. Dovendo Ottone passare in Calabria, lo accompagns durante il viaggio a Fermo il 2 novembre assistette, presente l’Imperatore, alla sentenza su di una controversia tra l’abate del monastero di Santa Croce e il vescovo della stessa cittl. Se Ottone I il 23 dicembre dello stesso anno privilegis con suo diploma il monastero detto Casa aurea, confermandone i beni che gil possedeva, ciò si dovette interventuque nostri dilectissimi fidelis Huberti scilicet Parmensis ecclesie presulis. L’Imperatore il 18 aprile 969, alle istanze di Uberto, concesse al nobile Ingone e ai suoi figli Uberto, Ribaldo e Oberto parecchie proprietl in diversi contadi d’Italia (in quello di Parma, le corti di Tortiano, di Stadirano e di Vicofertile). Da Bovino il 1I maggio (a lui era ricorso Uberto, nostram adiisse clementiam) l’Imperatore confermò al monastero della Santissima Trinitl e all’abate Adamo, nel luogo detto l’Isola di Pescara o Casa Aurea, i beni e i possessi. Il 20 maggio, presso Conca in Romagna, sempre per l’intervento di Uberto, l’Imperatore riconfermò alla Chiesa di Asti tutti i diritti e i possessi gil conferiti per il passato dai re e imperatori suoi antecessori. Ancora su preghiera di Uberto e Diederico, vescovo metensis, Ottone il 22 aprile 972, da Roma, concesse ad Azo, abate del cenobio di Santa Sofia di Benevento, la conferma dei beni dei quali era in possesso. Ottone il Grande morì il 7 maggio 973 e al governo dell’impero restò il figlio Ottone II. Di Ottone II Uberto fu Arcicancelliere dell’Impero dal 25 ottobre 967 sino al 16 febbraio 968 e Arcicancelliere del Regno d’Italia dal 6 ottobre 968 sino al 12 febbraio 980. Probabilmente Uberto rinunciò alla carica effettiva di Cancelliere d’Italia perchè, già avanti negli anni, non gli era più possibile seguire l’Imperatore ogniqualvolta scendeva in Italia. Invece la carica onorifica di Arcicancelliere gli consentì di rimanere presso l’Imperatore come consigliere: summus consiliarius. Alla morte di Guido, vescovo di Modena e abate di Nonantola, i monaci elessero loro Abate Uberto e Ottone ne confermò l’elezione nel febbraio 970: Hubertus per dei misericordiam Sancte parmensis Ecclesie episcopus, seu aba monasterii sancti Silvestri sito Nonantula qui per electionem Monachorum ipsius Monasterii et jussionem dominorum Imperatorum aba existit.
FONTI E BIBL.: N.Pelicelli, Vescovi della Chiesa Parmense, 1936, 93-99; A. Schiavi, Diocesi di Parma, 1940, 237.
.....considerazioni di Ottone vescovo di Frisinga e di Raevino (1115 ca.- 1158), zio di Federico I Barbarossa (1152-1190), sorpreso dalle forme di controllo che i comuni cittadini esercitavano sui …diocesanos…suos… compresi i grandi signori e feudatari, i domini loci I Latini… imitano ancor oggi la saggezza degli antichi Romani nella struttura delle città e nel governo dello Stato. Essi amano infatti la libertà tanto che, per sfuggire alla prepotenza dell’autorità si reggono con il governo di consoli anziché di signori. Essendovi tra essi tre ceti sociali, cioè quello dei grandi feudatari, dei valvassori e della plebe, per contenerne le ambizioni eleggono i predetti consoli non da uno solo di questi ordini, ma da tutti, e perché non si lascino prendere dalla libidine del potere, li cambiano quasi ogni anno. Ne viene che, essendo la terra suddivisa fra le città, ciascuna di esse costringe quanti abitano nella diocesi a stare dalla sua parte, ed a stento si può trovare in tutto il territorio qualche nobile o qualche personaggio importante che non obbedisca agli ordini delle città. Esse hanno preso anche l’abitudine di indicare questi territori come loro “comitati”, e per non mancare di mezzi con cui contenere i loro vicini, non disdegnano di elevare alla condizione di cavaliere e ai più alti uffici giovani di bassa condizione e addirittura artigiani praticanti spregevoli arti meccaniche che le altre genti tengono lontano come la peste dagli uffici più onorevoli e liberali. Ne viene che esse sono di gran lunga superiore a tutte le città del mondo per ricchezza e potenza. A tal fine si avvantaggiano non solo, come si è detto, per la saggezza delle loro istituzioni, ma anche per l’assenza dei sovrani, che abitualmente rimangono al di là delle Alpi
I Comuni :
una propria autonomia
il potere di nominare i consoli e successivamente il podestà .
battono una propria moneta
amministrano la giustizia
gestiscono internamente i tributi e hanno potere su il territorio circostante
Credo che ad un certo punto la storia di una parte d'Italia e la storia d'Europa ( anche l'Italia meridionale ) prendano cammini fortemente diversificati Un ininterrotto cammino feudale in Europa ( Francia , Spagna , Germania meno Inghilterra e Paesi bassi Italia meridionale ) che con volti diversi arriverra' alla rivoluzione francese Un cammino basato sulla centralita' politica della CITTA' nell'Italia del centro nord e al conseguente lungo abbandono del sistema feudale per una scelta COMUNALE Una scelta questo separatismo molto moderna ma inadatta a tempi dove la forza e la violenza era il fattore predominante Una scelta che crea istituzioni ricche di fermenti sociali culturali economici ma anche deboli sul piano militare Una scelta che insieme all'azione della Chiesa papista ( fortemente mobilitata contro qualunque azione unitaria ) rendera' impossibile unire le forze per conservare l'indipendenza della penisola , e che non sara' nemmeno in grado di evitare dissanguanti lotte intestine Come i capponi di Lorenzo Tramaglino ............... “Lascio poi pensare al lettore, come dovessero stare in viaggio quelle povere bestie, così legate e tenute per le zampe, a capo all’in giù, nella mano d’un uomo il quale, agitato da tante passioni, accompagnava col gesto i pensieri che gli passavan a tumulto per la mente. Ora stendeva il braccio per collera, ora l’alzava per disperazione, ora lo dibatteva in aria, come per minaccia, e, in tutti i modi, dava loro di fiere scosse, e faceva balzare quelle quattro teste spenzolate; le quali intanto s’ingegnavano a beccarsi l’una con l’altra, come accade troppo sovente tra compagni di sventura.” Purtroppo le alterazioni storiche fatte dalle famiglie dirigenti nei vari secoli con la scusa del lustro familiare hanno costruito una storia parallela che oggi bisogna smontare elemento per elemento per renderla effettivamente utile al riscontro della MACROSTORIA
Insomma viene seguito anche qui lo schema comunale che inizia sotto la guida del Vescovo , sotto gli occhi degli Attonidi ( quelli si MARCHIO ) , ed intorno alla morte di Matilde prende la sua strada autonoma
Gli uomini d'intelligenza superiore o di abilita superiore ( che sovente hanno cambiato la nostra vita quotidiana ) sono migliaia e migliaia
eccone alcuni di cui ho ricavato l'estrazione sociale consultando Wikipedia
Quindi voi potete aggiungerne molti molti altri
Interessante e' la suddivisione in:
PLEBEI
Leonardo Bonacci detto il Fibonacci Assieme al padre Guglielmo dei Bonacci, facoltoso mercante pisano e rappresentante dei mercanti della Repubblica di Pisa (nell'epistola di dedica a Michele Scoto si legge che il padre era publicus scriba pro pisanis mercatoribus) nella zona di Bugia in Algeria, passò alcuni anni in quella città, dove studiò i procedimenti aritmetici che studiosi musulmani stavano diffondendo nelle varie parti del mondo islamico. Qui ebbe anche precoci contatti con il mondo dei mercanti e apprese tecniche matematiche sconosciute in Occidente. Alcuni di tali procedimenti erano stati introdotti per la prima volta dagli indiani, portatori di una cultura diversa, e talora più avanzata, rispetto a quella occidentale. Proprio per perfezionare queste conoscenze Fibonacci viaggiò molto in Egitto, Siria, Sicilia, Grecia arrivando a Costantinopoli, alternando presumibilmente il commercio con gli studi matematici. Molto dovette ai trattati di Mu?ammad ibn Musa al-Khwarizmi, di Abu Kamil Shuja? ibn Aslam e di altri maestri, persiani e arabi, senza però essere mero diffusore della loro opera. Ritornato in Italia, la sua notorietà giunse anche alla corte dell'imperatore Federico II. Il matematico e l'imperatore si incontreranno a Pisa, presumibilmente nell'estate del 1226[.
Gauss nacque a Braunschweig, nel ducato di Brunswick-Lüneburg (al secolo facente parte del Sacro Romano Impero, oggi situato invece nello stato federato tedesco della Bassa Sassonia), il 30 aprile del 1777, figlio unico di una famiglia di bassa estrazione sociale e culturale
Niccolò Copernico nacque a Torun, in Polonia, nella Prussia reale il 19 febbraio del 1473. Il padre, Niklas Koppernigk (Mikolaj Kopernik in polacco), era un mercante polacco di lingua tedesca,
Giovanni Keplero Nato in una famiglia di umili origini venne avviato dai genitori alla carriera ecclesiastica. Infatti il 16 ottobre 1584 entrò nel seminario di Adelberg, trasferendosi il 26 novembre 1586 nel seminario superiore a Maulbronn
Giotto nacque a Colle di Vespignano, un borgo situato nella valle del Mugello (oggi una frazione del comune fiorentino chiamato Vicchio), con ogni probabilità nel 1267, in una famiglia di piccoli possidenti terrieri (Bondone era appunto il padre) -------da notare quanto documenta il dr Paolo Piccardi
Dante degli Alighieri . Dante apparteneva agli Alighieri, una famiglia di secondaria importanza all'interno dell'élite sociale fiorentina che, negli ultimi due secoli, aveva raggiunto una certa agiatezza economica.
Giovanni Boccaccio nacque tra il giugno e il luglio del 1313 da una relazione extraconiugale del mercante Boccaccino di Chellino con una donna di umilissima famiglia di Certaldo, presso Firenze
Francesco Petrarca nacque il 20 luglio 1304 ad Arezzo da ser Petracco, notaio, ed Eletta Cangiani (o Canigiani), entrambi fiorentini
Louis Pasteur nacque nella regione del Giura francese. Suo padre, Jean Pasteur, era un conciatore, veterano delle guerre napoleoniche.
Michelangelo Buonarroti I Buonarroti di Firenze facevano parte del patriziato fiorentino !!! ??? All'epoca della nascita di Michelangelo, la famiglia attraversava però un momento di penuria economica
Charles Robert Darwin Nacque a Shrewsbury, città del Regno Unito nella contea dello Shropshire, quinto dei sei figli di Robert Darwin (1766-1848), medico generico del paese con una positiva carriera professionale, e Susannah Wedgwood (1765-1817), ereditiera di una famiglia benestante di imprenditori attivi nell'industria della ceramica
René Descartes Il suo biografo Pierre Borel, credeva invece che fosse nato nella casa che i Descartes possedevano a Châtellerault,[12] nel Poitou: entrambe le case esistono ancora e del Poitou erano originari gli avi del filosofo, che non erano però nobili.
Ludovico Antonio Muratori Nato nell'allora Ducato di Modena e Reggio da famiglia contadina in una casa a tre piani a ridosso del locale castello di Vignola, ancora visitabile e adibita a scuola di musica, sin da fanciullo dimostrò una forte passione per gli studi
Albert Einstein nacque a Ulma il 14 marzo del 1879 da una benestante famiglia ebraica, figlio di Hermann Einstein, proprietario di una piccola azienda che produceva macchinari elettrici, e di Pauline Koch.
William Harvey Figlio di Thomas e Joan Harvey, William fu il primo di nove figli, sette maschi e due femmine. Il padre era un uomo d'affari impegnato nel commercio con l'estero e, grazie all'agiatezza economica derivante da tale professione, il giovane William poté subito dedicarsi agli studi e alla sua passione per la medicina.
Galileo Galilei nacque il 15 febbraio 1564 a Pisa, primogenito dei sette figli di Vincenzo Galilei e di Giulia Ammannati. Gli Ammannati, originari del territorio di Pistoia e di Pescia, vantavano importanti origini; Vincenzo Galilei invece apparteneva a una casata più umile, per quanto i suoi antenati facessero parte della buona borghesia fiorentina
La data di battesimo di William Shakespeare a Stratford-upon-Avon risulta essere il 26 aprile 1564; la trascrizione nel registro parrocchiale riporta: Gulielmus, filius Johannes Shakespeare. È probabile che William abbia lavorato come apprendista nel negozio del padre; è stato messo in rilievo come Shakespeare abbia fatto riferimento a svariati tipi di pelle e ad altre conoscenze tipiche dei conciatori
Raffaello Sanzio nasce a Urbino «il 28 marzo o il 6 aprile dell'anno 1483, il Venerdì Santo a ore tre di notte, d'un Giovanni de' Santi, pittore non molto eccellente, ma sì bene uomo di buono ingegno et atto a indirizzare i figliuoli per quella buona via che a lui, per mala fortuna sua, non era stata mostra nella sua gioventù»
John Dalton nasce a Eaglesfield, nei pressi di Cockermouth, nel Cumberland. Fu allievo di suo padre (che faceva il tessitore) e di John Fletcher, un quacchero che gestiva una scuola privata in un villaggio vicino.
Giambattista Vico Nato a Napoli nel 1668 da una famiglia di modesta estrazione sociale – il padre, Antonio Vico, era un povero libraio, mentre la madre, Candida Masulla, era figlia di un lavorante di carrozze
Robert Hooke nacque nella cittadina di Freshwater, nell'Isola di Wight, da una famiglia di medie condizioni (il padre, John, era curato della locale parrocchia).
Evangelista Torricelli nacque a Roma (ma, fino al 1987, si è ritenuto che fosse nato a Faenza) da genitori romagnoli, Gaspare Ruberti, un tessitore originario di Bertinoro (nell'odierna provincia di Forlì-Cesena), e Giacoma Torricelli, originaria di Faenza. Rimase orfano in tenera età e trascorse l'infanzia e l'adolescenza a Faenza, dove fu iniziato allo studio dallo zio materno, Gian Francesco Torricelli (Don Jacopo, monaco camaldolese), parroco di S. Ippolito, che curò la sua educazione primaria
Dmitrij Ivanovic Mendeleev nacque a Tobol'sk in Siberia, l'8 febbraio 1834, da Ivan Pavlovic Mendeleev (direttore del ginnasio della città) e Maria Dimitrievna Mendeleeva (nata Kornil'eva), donna intelligente ed energica che si occupava dell'educazione dei figli di cui Dmitrij era il quattordicesimo e ultimo. Suo nonno, Pavel Maksimovic Sokolov, era stato un pope.
Alfred Nobel Lontano discendente dello scienziato e scrittore svedese del XVII secolo Olaus Rudbeck[ e membro della famiglia Nobel (eminente dinastia di industriali svedesi), nacque da Immanuel Nobel, detto "il Giovane", a sua volta inventore e ingegnere, e da Karolina Ahlsell. Il padre, dopo una bancarotta, si trasferì con moglie e figli a San Pietroburgo, in Russia, nel 1838, dove riuscì a risollevare le economie di famiglia, entrando nell'industria degli armamenti russi.
Luigi Galvani nacque il 9 settembre del 1737 a Bologna[2] da Domenico Galvani e Barbara Foschi, donna di buona famiglia bolognese. Galvani e il suo fratellastro maggiore, Francesco, trascorsero un'infanzia serena e piuttosto agiata, di cui si hanno poche notizie, in una casa della via oggi detta via Guglielmo Marconi a Bologna.
Gregor Johann Mendel aveva due sorelle, una maggiore, Veronika e una minore, Theresa[3]. I suoi genitori erano Anton Mendel e Rosine Schwirtlich, contadini di Hyncice, in Moravia, Repubblica Ceca, ai tempi chiamata Heinzendorf e facente parte dell'Impero asburgico.
Caravaggio, pseudonimo di Michelangelo Merisi I genitori si sposarono il 14 gennaio 1571 e, con la protezione e l'aiuto del marchese di Caravaggio e conte di Galliate Francesco I Sforza, che fece anche da loro testimone di nozze, si trasferirono a Milano. Alcuni storici affermano che Fermo Merisi appartenesse al gruppo dei magister, uno dei maestri-architetti addetti ai cantieri delle chiese milanesi. È dunque ipotizzabile che la famiglia vivesse presso gli alloggi delle maestranze della "Fabbrica del Duomo di Milano", delle quali faceva probabilmente parte anche Fermo Merisi. Altre ipotesi invece, avanzate dallo storico Maurizio Calvesi, sosterrebbero che Fermo Merisi fosse, in realtà, un semplice maestro di casa al soldo degli stessi marchesi della città di Caravaggio residenti a Milano, e che esercitasse «sia pure modestamente, il mestiere di architetto»
Johannes Gutenberg nacque a Magonza dal mercante Friele (Friedrich) Gensfleisch zur Laden, nato intorno al 1350, e da Else Wyrich, che Friedrich aveva sposato in seconde nozze nel 1386. Non si conosce la data certa della nascita di Johannes, ma è citato come maggiorenne in un documento del 1420.I Gensfleisch erano una delle famiglie patrizie della città, addetti alla lavorazione del metallo e del conio. Nel 1430 Johannes Gutenberg decise di trasferirsi a Strasburgo per motivi politici, e qui lavorò come apprendista orafo, occupandosi in particolare del conio delle monete.
Isaac Newton Nacque a Woolsthorpe-by-Colsterworth, nel Lincolnshire, il 25 dicembre 1642 (secondo il calendario giuliano, allora in uso in Inghilterra ), in una famiglia di allevatori. Suo padre, anch'egli di nome Isaac (1606-1642) e piccolo proprietario terriero, morì tre mesi prima della sua nascita; egli, sul proprio testamento, disegnò un uccello come suo segno distintivo al posto della firma, nonostante sapesse scrivere. Tre anni dopo sua madre, Hannah Ayscough (1623-1679), si risposò con un agiato chierico di nome Barnabas Smith
Martin Lutero (in tedesco Martin Luther;Martin Lutero nacque a Eisleben (nell'odierno Land di Sassonia-Anhalt) nella notte del 10 novembre 1483, «undici ore dopo il tramonto», cioè verso le cinque del mattino. I suoi ascendenti erano contadini: «Sono figlio di contadini», ricorda il riformatore in uno dei suoi Discorsi a tavola, aggiungendo che «ci sono stati però contadini che sono diventati re e imperatori».
Jehan Cauvin , noto in italiano come Giovanni Calvino nacque il 10 luglio 1509 a Noyon, in Piccardia, dove il padre Gérard si era trasferito dalla vicina Pont-l'Évêque nel 1481. Gérard Cauvin, già segretario di cancelleria, fu avvocato del vescovo di Noyon, poi funzionario delle imposte e ancora segretario del vescovo, col quale ebbe così gravi contrasti da essere scomunicato; morì nel 1531. La madre, Jeanne Lefranc, ebbe altri tre figli: il maggiore, Charles, che morì nel 1536 e, dopo Jean, Antoine, che visse a Ginevra con il fratello, e François, morto in tenera età. Jeanne morì nel 1515 e il vedovo Gérard si risposò, avendo altre due figlie, una delle quali, Marie, visse anch'essa a Ginevra con i fratellastri.
Andreas van Wesel, italianizzato in Andrea Vesalio (Bruxelles, 31 dicembre 1514 – Zante, 15 ottobre 1564) Nacque a Bruxelles il 31 dicembre 1514 da famiglia benestante e tradizionalmente legata alla professione medica. Suo bisnonno era stato medico di Maria di Borgogna e docente all'Università di Lovanio, suo nonno lavorò anche lui come medico per Maria di Borgogna e scrisse una serie di commentari agli Aforismi di Ippocrate e in ultimo suo padre, anch'egli di nome Andrea, fu medico e farmacista per l'imperatore Carlo V. Con queste premesse, fu abbastanza naturale che quando Vesalio divenne uno dei più conosciuti medici e anatomisti europei, gli fu offerto l'incarico di medico personale dell'imperatore presso la corte spagnola
Leon Battista Alberti (1404 - 1472)
Andrea Palladio (1508 - 1580) Andrea nacque nel 1508 a Padova, nella Repubblica di Venezia, da una famiglia di umili origini: il padre Pietro, detto "della Gondola", era mugnaio e la madre Marta, detta la Zota ("la zoppa"), una donna di casa.
-----------------------
NOBILI
Filippo Brunelleschi (1377 - 1446)
Robert Boyle Nato a Lismore Castle (castello situato nel territorio di Lismore), nella contea di Waterford, Irlanda, fu il settimo figlio maschio e quattordicesimo figlio di Richard Boyle, I conte di Cork.
Amedeo Avogadro Nacque nell'agosto 1776 in una famiglia di antica nobiltà piemontese, da Anna Vercellone di Biella e da Filippo Avogadro, conte di Quaregna e di Cerreto, il quale fu Senatore del Regno di Sardegna e alto magistrato.
Alessandro Volta nacque a Como, nel Ducato di Milano, da donna Maddalena dei conti Inzaghi. Il padre, don Filippo Volta, discendeva da una famiglia di Loveno che dal 1536 viveva nella porzione meridionale del palazzo (situato nell'attuale via Volta) dove avvenne la nascita dello stesso Alessandro
Giacomo Leopardi Nacque nel 1798 a Recanati, nello Stato pontificio (oggi in provincia di Macerata, nelle Marche), da una delle più nobili famiglie del paese, primo di dieci figli
Antoine Lavoisier Nato il 26 agosto 1743 a Parigi, Antoine Laurent Lavoisier frequentò il Collège des Quatre-Nations dal 1754 al 1761, studiando chimica, botanica, astronomia e matematica
Maria Salomea Sklodowska-Curie nasce nel 1867 a Varsavia, in una Polonia all'epoca sotto la dominazione dell'Impero russo. Figlia di Wladyslaw Sklodowski (1832-1902) e di Bronislawa Boguska (1834-1878), è l'ultima di cinque figli e figlie, fra cui Bronislawa, che collaborerà con lei più tardi. La sua famiglia proviene da una classe sociale orgogliosa del suo ruolo nel proprio Paese, appartenente alla piccola nobiltà terriera degli szlachta
----------------------
CONCLUSIONI
Il nostro PRIMO STEP da risultati molto interessanti
Che in un certo qual modo sono contrastanti con la giusta considerazione che era piu' facile per un nobile accedere al sapere e all'esercizio del sapere
Noi siamo figli di alcuni secoli di una "cultura nobiliare" che ha tentato ( riuscendoci ) di imporre alcuni pregiudizi
Una cultura antitetica al lavoro :
il disprezzo delle "arti vili e meccaniche"
Ma se guardo ai risultati del mio piccolo censimento la nobilta' non sembra brillare per particolari doti di intelligenza , anzi.....
visto che dalle fila dei plebei spuntano astri di prima grandezza
Il fatto non ha molta logica
Fortunatamente l'intelligenza non puo'essere confinata in un ceto
Il fatto dipende sicuramente dalla pigrizia nell'uso corretto del cervello
L'intelligenza ha bisogno di stimoli
La pancia piena e' piu' propensa a sedersi in una sana e tranquilla digestione
Rimane vero che la stragrande maggioranza dei GENI ( genialita') proviene da chi le "arti vili e meccaniche" le praticava e praticamente risolveva problemi
E' fondamentale questa considerazione per costruire anche per il passato un rapporto corretto col lavoro umano
Perche' noi siamo figli di una cultura ( la cultura nobiliare ) che aveva e ha tramandato uno scorretto rapporto col lavoro e la fatica
Col suo disprezzo pseudo-guerriero per le arti vili e meccaniche cioe' in definitiva per la laboriosita' umana
Chi oggi lavora in un "ente inutile" cioe' chi non fa niente di utile per la comunita' ma anzi intralcia il lavoro di altri difficilmente confessera' la propria inutilita'
Anzi si dara' da fare per giustificare il suo "lavoro"
Ecco la cultura nobiliare dei secoli XVI XVII XVIII XIX
Ecco giustificare ed esaltare le guerre e la morte dei poveri cristi a favore degli interessi dei ricchi
Ecco esaltare la "nobilta' " come bene preziosissimo ed ornamento del mondo
Poi ci si sono messi (come sempre collusi col potere ) anche i preti ad educare alla accettazione e alla rassegnazione
A CHE E' SERVITA LA NOBILTA' SE NON A SPARGERE SANGUE E DOLORE E A SANCIRE DISUGUAGLIANZE SENZA GIUSTIFICAZIONE ?
MA BADATE BENE NEMMENO LA DEMOCRAZIA E' TUTTORA ESENTE DALLE CASTE, DAL NEPOTISMO,DALLE AMICIZIE, DAI FAVORI
MENTIRE COME UN GENEALOGISTA FALSIFICAZIONE DELLA STORIA FAMILIARE https://www.iagiforum.info/viewtopic.php?f=3&t=24270&p=258982&hilit=origine+nobilta#p258982
by Sannita1998 , lunedì 13 settembre 2021,
.............Strettamente parlando non sono un esperto della storia della Nobiltà Italiana oppure un genealogista, ma un semplice appassionato di storia che si é spesso interessato e appassionato a quali siano le "origini" delle nobiltà Italiana. Per origine intendo le origini etniche e come queste etnie
si siano distribuite nelle varie zone del Paese.
Si può certamente affermare che la nobiltà Italiana abbia origini etniche molto piú eterogenee rispetto alla Nobiltà di altre nazioni europee, come la Francia o soprattutto la Germania, e tale eterogeneità é riflessa nella stessa popolazione Italiana.
Nel Piemonte per esempio, per quanto riguarda la "noblesse d'épée, prevale l'origine Franca, grazie alle nobili famiglie giunte al seguito di Carlo Magno. In epoca moderna poi, con un processo simile a quello della vicina Francia, vi é l'ascesa di una classe di burocrati che formerà una "noblesse de robe".
Nel Centro Italia il panorama sembra ancora più complesso:in regioni come la Toscana, l'Umbria e le Marche si può a mio avviso fare un utile distinzione tra le città più o meno grandi, ed i piccoli paesini con il contado. Nel periodo medioevale in quasi tutti i centri urbani dell'Italia centrale, il potere militare e civile é stato sottratto in maniera più o meno violenta alla vecchia classe feudale, a cui si é sostituita una nobiltà "borghese" formata da mercanti, artigiani, medici, giuristi, che in seguito rafforzò il proprio potere con l'acquisto di proprietà fondiarie, costituendo una nobiltà a tutti gli effetti e dando vita a regimi oligarchici /patriziali. Potremmo dunque parlare di una vittoriosa riscossa degli autoctoni Italici contro la componente Germanica rappresentata dai vecchi feudatari, destinati a decadere o scendere a patti con la nuova realtà? Nel contado e nei paesini più piccoli al contrario, e soprattutto nelle zone interne appenniniche, la componente Germanica/feudale, sia essa di origine Longobarda oppure Imperiale, é riuscita a tenere saldamente le redini del potere, subordinando la componente Italica più o meno fino alla Rivoluzione Francese.
Nel Sud la situazione é ancora diversa. Dapprima, nel Ducato di Benevento, la nobiltà é ovviamente Germanica, che però in buona parte decade con l'invasione dei Normanni, i quali stabiliranno saldamente il potere delle proprie famiglie, conservandolo anche durante la dominazione Angioina e Spagnola, periodi in cui si aggiungeranno ovviamente famiglie Francesi e Spagnole.
La componente autoctona qui non trova alcun accesso all'alta nobiltà, alla grande aristocrazia, ma si accontenterà di compiere una timida ascesa al patriziato provinciale.
In ultimo mi viene in mente la nobiltà Veneziana, in cui fin da subito é unicamente la componente Italico-Bizantina ad essere dominante, e l'aristocrazia Veneziana in ogni suo aspetto sembra conservare decisamente un anima Bizantina, costituendo a mio avviso un unicum nel panorama della penisola Italiana.
....................mi piacerebbe mi chiariste meglio questo tema che trovo molto affascinante.
La macrostoria negli ultimi venti anni e'molto cambiata nei metodi di ricerca e nelle conclusioni
Gli storici oggi sono molto piu' attenti nell'esame dei documenti coevi conservati negli archivi
E sono divenuti molto attenti alla microstoria intesa come storia familiare e genealogie ( e qui si sgretolano migliaia di storie familiari inventate )
Tenga conto che era prassi comune nelle famiglie nobili inventare origini antiche e quasi mitologiche
Purtroppo la storia ancora raccontata nei nostri istituti scolastici e' una storia in ritardo con le nuove ricerche ( quando non gia' in ritardo con le vecchie )
E ci sono molti presunti storici che scrivono ancora una storia da giornaletto spacciandola per divulgazione, privandola cosi della sua funzione di memoria di una collettivita
Quindi di quella stessa utilita' che ha la memoria ( esperienza ) per l'individuo
Quindi quando legge di una famiglia che ha radici nei Romani nei Longobardi , nei Franchi ,nei Normanni , ........si metta sul chi vive e cerchi di esaminare le fonti coeve , e verifichi se i documenti sono stati falsificati o sono autentici . se si utilizzano omonimie .....................
Questo non vuol dire che non ci siano famiglie che possano dimostrare legami coi Longobardi o coi Franchi o coi Normanni ( coi Romani e' una bestemmia ) ma sono veramente poche
Tenga poi conto che quando si parla di Longobardi , di Franchi , di Normanni bisogna capire i numeri che sono in gioco
Si parla per i Longobardi di un numero di 100,000 --400 000 tra donne e uomini che si spargono in un Italia che per quanto spopolata da carestie e pestilenze ( la piccola glaciazione. citta' ridotte a poche migliaia di persone ) quei tre o quattro milioni di persone doveva almeno ancora contenere
Non ci e' affatto chiaro la capacita' di controllo che potevano esercitare i Longobardi sul territorio e dove
E se alla fin fine si affidassero ad elementi locali per la riscossione delle tasse
Prenda con le molle tutti gli studi genealogici fatti dagli eruditi dal 1500 in poi
Anche prima
Tenga conto che Dante Alighieri seguendo Giovanni Villani fissa i cognomi a Firenze intorno al 1050 , ma viene smentito dall'esame fatto oggi dagli studiosi sui documenti coevi
Infatti i documenti mostrano l'inesistenza del cognome a Firenze fino a un periodo tra il 1150 e il 1200. ( Un individuo colto che vive nel 1300 sbaglia di molto su avvenimenti che erano relativamente poco distanti da lui )
Quindi le varie ipotesi sulla nobilta' italica risentono molto di convinzioni radicatesi a lungo andare : la storia della menzogna ripetuta che col tempo diventa una verita'
E' comunque quasi sempre la ricchezza la principale causa in Italia della nobilitazione di uno o piu' rami familiari. Quindi quasi sempre bisogna seguire i cicli di arricchimento e impoverimento delle famiglie per studiare la nobilitazione.
Sannita1998 ,
........ dovremmo iniziare davvero a dubitare di tutto? Intendo dire, ammettiamo anche che molte famiglie abbiano falsificato documenti, per attribuirsi origini piú antiche e piú nobili (d'altronde é ciò che fanno attualmente tantissime persone non nobili), per questo dovremmo dubitare anche degli ultimi elementi certi?
Per esempio dubitare che la nobiltà Italiana delle origini abbia un'origine Germanica.
La nobiltà senatoria era stata sterminata, esiliata o degradata dai barbari germanici, che si erano sostituiti ad essa. I cognomi poi, i primissimi cognomi, appartenevano solo a famiglie nobili e mostrano chiaramente un origine germanica, sottolineata anche dal fatto che i membri di queste stirpi seguissero leggi longobarde.
Il fatto che le famiglie che possono far risalire le proprie origini al XI-XII siano pochissime, a mio avviso non toglie il fatto che quasi tutte queste famiglie siano di origine germanica
Quello che voglio dire e' che inizialmente prevale il ceto dirigente longobardo ma poi prima lentamente poi sempre piu' rapidamente i popoli si confondono
Non e' piu' o bianco o nero le cose cominciano a mescolarsi in sfumature di grigio
Emergono nuovi ricchi che entrano nel ceto dirigente
Dall'entrata dei Longobardi in Italia nel 568 alla caduta del loro predominio 774 passano un numero di anni tali che i due popoli si mescolano
Noi siamo gli eredi non di Roma ma di quel misto di mondo latino e longobardo determinatosi in quei quasi 200 anni
I nomi che legge sui documenti significano pochissimo
antroponimia longobarda in Toscana Nicoletta Francovich Onesti Un poco piu' significativa e' la legge che gli individui dichiarano di seguire , ma anche qui in duecento anni possono essere successe tante cose ( ricordo : Parigi val bene una messa )
Insomma credo che attualmente con la scarsa documentazione di cui disponiamo nessuno possa affermare certezze del mondo intorno al 900--1000
( E' pur vero che si stanno intensificando gli studi specie archeologici sul periodo longobardo )
Tenga conto che il ceto dirigente e' fragile e subisce un ricambio rapido
Se hai molti figli la ricchezza e il potere si fraziona pericolosamente
Se limiti i figli corri il rischio dell'estinzione genealogica
Poi ci sono i rovesci di fortuna
--------------
In definitiva
Veniamo da una lunga tradizione che vedendo nei Longobardi e nei Franchi i popoli vincitori ( stereotipi ) volle creare il mito delle famiglie del ceto dirigente ( eliminiamo questa parola nobili che richiede precise contestualizzazioni storiche ) discese dai germani vincitori
In realta'dopo un certo periodo esistono solo dei popoli che possono esser considerati confusi tra loro (anche tenendo conto dei numeri iniziali )
Stefano Gasparri.............La storiografia italiana ha sempre rifiutato l’eredità barbarica. I Longobardi, in particolare, sono sempre stati ritenuti i più barbari di tutti. Questo per molti motivi: per le polemiche dell’età del Risorgimento, per la natura cattolica della storiografia italiana (i Longobardi erano nemici dei papi) e per il grande peso della cultura classica, che ha sempre ritenuto non solo l’età longobarda, ma in generale il medioevo come un periodo di negazione delle radici romane dell’Italia. Per questo motivo è stata sempre negata la fusione fra Longobardi e Romani. Ma la storiografia più recente ha mostrato che nell’VIII secolo la fusione fra Longobardi e Romani era ormai avvenuta: l’intera popolazione libera del regno identificava se stessa come longobarda.
E quando arriva Carlo quello che gli basta sono i tributi ed un atto formale di sottomissione e il controllo dei confini
Quindi la maggior parte dei potentati locali rimangono gli stessi del Regno d'Italia longobardo cioe' Italiani frutto di una complessissima fusione tra popoli
mi pare maledettamente logico il dubitare
La realta' che il professore Stefano Gasparri , oltre al fatto che noi siamo i Longobardi i Goti i Romani , ci mostra ci fa capire che in molti usano e impongono la storia per scopi che con la storia non c'entrano e quindi la manipolano per creare diritti ed opinioni e per far dimenticare abusi . Cioe' gli storici del passato non sono sfuggiti alla trappola
Nel nostro caso lo stesso assunto di partenza era in un certo modo scorretto , il termine "nobilta" come tanti altri termini ha un intrinseco significato diverso di luogo in luogo , e nello stesso luogo di tempo in tempo
Non c'e' continuita' di contenuti tra la nobilta' feudale e la nobilta italiana del novecento
Ad alimentare queste idee gli antichi cronisti
Era il modo del cronista di spiegare in maniera quasi miracolistica eventi che non gli erano chiari , dando lustro alla propria citta' ed ai propri concittadini
Ecco il Villani alimentare una di quelle leggende toscane che servono da usato canovaccio leggendario ( come la presenza in citta' di Carlo Magno o la conseguente creazione di cavalieri ) Guai a scambiarle per vere
Cosi ecco Uberto barone ottoniano , venuto dalla Sassonia , per dar origine agli Uberti fiorentini, famiglia che non potevano non aver avuto origini notabili ed illustri ...........
Giovanni Villani ...................Questo Otto amendò molto tutta Italia, e mise in pace e buono stato, e abatté le forze de' tiranni; e al suo tempo assai de' suoi baroni rimasono signori in Toscana e in Lombardia. Intra gli altri fu il cominciamento de' conti Guidi, il quale il primo ebbe nome Guido, che 'l fece conte Palatino, e diedegli il contado di Modigliana in Romagna; e poi i suoi discendenti furono quasi signori di tutta Romagna, infino che furono cacciati di Ravenna, e tutti morti dal popolo di Ravenna per loro oltraggi, salvo uno picciolo fanciullo ch'ebbe nome Guido, sopranomato Sangue, per gli suoi che furono tutti in sangue morti; il quale poi per lo 'mperadore Otto quarto fu fatto signore in Casentino, e questi fu quegli che tolse per moglie in Firenze la contessa Gualdrada, figliuola che fu del buono messere Bellincione Berti de' Ravignani onorevole cittadino di Firenze. Ancora troviamo che 'l detto Otto primo soggiornava in Firenze quando andava e tornava a Roma, e mise amore e piacquegli la città, e perch'era stata sempre figliuola della città di Roma e fedele allo 'mperio, sì·lla favorò e brivileggiò, e dielle infino in sei miglia di contado. E quando tornò in Alamagna, de' suoi baroni vi rimasero e furono cittadini; e intra gli altri fu quegli ch'ebbe nome Uberto, onde si dice che nacque la casa e progenia degli Uberti, e per suo nome così fu nomata; e un altro barone ch'ebbe nome Lamberto, che si dice che discesono i Lamberti: questo però non affermiamo; e più altri di sua gente de' migliori baroni, e di quegli d'Otto secondo, rimasono in Toscana in signoria, onde poi sono stratti molti lignaggi in Firenze di gentili uomini, e molte terre d'Italia. Questo Otto primo brivileggiò i Lucchesi che potessero battere moneta d'oro e d'ariento, e però la loro moneta è improntata del suo nome. Dapoi che morì Otto primo fu fatto imperadore Otto secondo suo figliuolo,
Ecco quindi gli Uberti fiorentini essere originati da un Uberto barone di Ottone I e parimenti ecco Lamberto originare i Lamberti
I recenti studi di Enrico Faini e di Maria Pia Contessa ci informano invece gli Uberti aver origine cittadina
Anche a Pisa non vollero esser da meno
Ecco l'uso di una quasi speculare versione da parte dei cronisti di Pisa , con i medesimi scopi
riportata a verita' coi documenti dal prof Mauro Ronzani
Ovviamente Ottone e i baroni anche qui non c'entrano niente
......... In alcuni dei testi cronistici a base comune compilati a Pisa verso la metà del secolo XIV, ma giunti a noi in unione con le più tarde, varie narrazioni che vi furono posposte, il passaggio dalla storia antica e leggendaria a quella ‘medioevale' - quando cioè «si tralatò l'imperio agli Alamanni da Francieschi» - è segnato dal ricordo d'un soggiorno pisano di Ottone I di Sassonia. Un avvenimento davvero degno di nota, sia perché piacque all' «inperatore tedescho (...) lo stare in Pisa», sia, soprattutto, perché qui «rimaseno dei suoi sette baroni», colmati di privilegi e «molti doni»; e da costoro sarebbero poi discesi quelli che i nostri testi già definivano antonomasticamente «i sette chasati», semenzaio di tutte le schiatte più illustri della Pisa comunale: «ciò è di Chasamatti e gli Orlandi et que' di Librafacta et Ghaetani, et Duodi hora Griffi, et Bischonti (...) et Verchionesi» (1).
Taciuta dalla cronaca contenuta nel manoscritto lucchese 54, stesa verso il 1338, la notizia dell'origine dei sette casati dovette comunque essere inserita di lì a pochi anni, per mano dell'anonimo che continuò il racconto fino al 1348, e curò altresì un primo compendio di quel testo (o meglio centone di testi),.....................................
Ed anche a Bologna per dare un antenato illustre ai Lambertini si ferma un conte ottoniano ..........Secondo Pompeo Scipione Dolfi (Cronologia delle famiglie nobili di Bologna), la famiglia Lambertini ebbe origine nell'anno 976 da Lamberto figlio del conte Mondo di Sassonia, che per Filelfo venne con l'imperatore Ottone I in Italia, e si stabilì a Bologna, UN ESEMPIO ECLATANTE da wikipedia I MASSIMO romani Le origini della famiglia restano oscure e leggendarie. Una tradizione mitica fa risalire l'origine della famiglia Massimo alla Gens Fabia dell'antica Roma la quale con Quinto Fabio Rulliano avrebbe aggiunto nel IV secolo a.C. per senatoconsulto della repubblica romana il cognomen «Maximi». La leggenda sarebbe stata diffusa da Onofrio Panvinio (1529-1568) nel suo "De gente Maxima" del 1556 (Cod. Vat. 6168 pag. 166) pubblicato da Angelo Mai nel 1843 nel tomo IX dello "Spicilegium romanum"[4]. Secondo il Panvinio a questa famiglia sarebbero appartenuti due papi santi, Anastasio I e Pasquale I. La leggenda ebbe una certa fortuna per cui la famiglia Massimo è considerata da alcuni, fra cui Vittorio Spreti, la più antica d'Europa[5][6]. A Napoleone Bonaparte che chiedeva notizie sulla veridicità di tale discendenza, Francesco Camillo VII Massimo, plenipotenziario del papa Pio VI, rispondeva: «Je ne saurais en effet le prouver, c'est un bruit qui ne court que depuis douze cents ans dans notre famille»[4] (in realtà non potrei provarlo, è una diceria che si racconta nella nostra famiglia solo da una dozzina di secoli). Il desiderio di possedere ascendenze mitiche era abbastanza comune nelle casate dato che costituivano un'ulteriore prova della loro nobiltà: nella maggior parte dei casi le ricerche araldiche venivano affidate a noti eruditi il cui fine era di compiacere l'aristocratico committente. Nota Bene : il tuttologo Vittorio Spreti fa da cassa di risonanza ad una impossibile ed indimostrabile leggenda Piu' prosaicamente possiamo attestare la famiglia al 1347 DC ......................................... Tuttavia il primo a essersi fregiato del nome di famiglia «de Maximis», come segno di appartenenza all'aristocrazia romana, sembra sia stato Massimo di Lello di Cecco, titolare di un banco di pegni nella prima metà del XV secolo, definito nei documenti dell'epoca «Maximus Lelli Cecchi»; suo padre Lello (morto nel 1420) gestiva una spezieria nel rione Sant'Eustachio e fu Conservatore di Roma nel 1418, mentre il nonno Cecco di Lello de Maximo, che sottoscrisse nel 1347 gli statuti dell'arte della lana, fu probabilmente il principale artefice della fortuna economica della famiglia. by wikipedia La verita' e' che oggi in occidente non si puo' risalire oltre lo VIII secolo ( e questo solo per particolari e rare famiglie regnanti ) Per altre famiglie e' raro arrivare genealogicamente allo XI -XII secolo Per quasi tutte le famiglie in Italia la successione genealogica scende ai tempi posteriori al Concilio di Trento quando venne resa obbligatoria la tenuta dei libri dei battezzati Le nostre societa' sono basate pricipalmente sull'ipocrisia La filosofia ha imbastardito il nostro modo di pensare con tre o quattro concetti venefici Dio La giustizia La verita' ........................... la divisione sociali in ceti non ha molto buonsenso la vita ci dice che esistono solo due tipi di uomini : quello che ha sufficienti risorse per riuscire a soddisfarre i propri bisogni primari e quelli che non hanno queste risorse
I bisogni primari cambiano di tempo in tempo. Oggi una connessione internet fa parte dei bisogni primari , la tutela della sicurezza e della salute , una giornata di lavoro limitata alle otto ore , la scuola dell'obbligo ed i libri per studiare , il cibo e l'alloggio Gli uomini sono tutti uguali. Non lo sono nelle capacita' che sempre troverai l'uomoo piu' intelligente o l'uomo piu' forte o l'uomo piu' veloce o l'uomo piu' cinico o l'uomo piu' abile ma sono uguali per le loro debolezze , per i medesimi bisogni, per la medesima fame, sofferenza fisica e morale, malattia, morte, per le medesime paure . per i medesimi desideri Dagli anni 50 del ventesimo secolo viviamo in un mondo in continua trasformazione A volte cambiamento per puro gusto di cambiare e non miglioramento Trasformazione fortemente marcata dalla tecnologia che ci mette in mano strumenti spesso ingovernabili da un cervello ancora piccolo Nella storia di noi "scimmioni nudi" questo era gia' successo o forse era gia' cominciato prima nel secolo XV Ad esso si era opposto nei paesi mediterranei il connubio fatale tra Chiesa cattolica e Spagna Il titolo nobiliare in Italia ebbe un senso storico solo nei tempi medioevali o di poco successivi quando aveva una sua ben specifica funzione basato su un rapporto vassallatico e conteneva un valore guerriero A quei tempi aveva un significato di controllo militare e fiscale sul territorio che implicava un sentimento di fedelta al capo , di forza ,di onore e di coraggio in senso guerriero valori discutibili ma comunque valori alla base aveva sempre il rapporto di popolo vincitore e di popolo vinto . Il disprezzo iniziale del vincitore verso il vinto La proto-nobilta feudale aveva il disprezzo che ha il guerriero verso l'imbelle o il pacifico
Credeva che la pricipale qualita' dell'uomo fosse il valore guerriero
E questo concetto e' riaffermato anche da Federico II
Non credo sia possibile affermare che quella proto-nobilta' era completamente cristiana solo perche' osservava certi formalismi cristiani mentre e' piu' facile definirla barbaro-cristiana
Venuta meno l'importanza dell'Impero Romano Germanico e creatisi gli stati nazionali la nobilta' perse la funzione di amministratori del territorio Per la nobilta' dei secoli xvii e seguenti
Una falsa consapevolezza di superiorita' si fa piu' profonda
il disprezzo verso il villano si fa strutturale e ramificato , La nobilta' diventa qualcosa quasi di genetico : la nobilta' e' una sorta di razza all'interno della compagine sociale predestinata da un dio a governare la societa' cosi come e' il Re ad avere un diritto divino
Ancor peggio ! mi pare
Cosi viene instillato nel popolo profondamente che e' quello che vuole Dio , che tramare contro il re o l'ordine sociale e' come andare contro Dio
la concessione del titolo nobiliare divenne invece un prezioso strumento di consolidamento del potere il re ( nobile feudale tra i nobili feudali ) ha il problema di far accettare la sua supremazia a quelli che a pieno titolo si considerano suoi pari L'invenzione di far discendere il potere regio direttamente dalla volonta di Dio , puntellata dalla Chiesa che cosi si puntellava , giustificava che un Re potesse nobilitare un suo simile L'invenzione della "Corte" fu il passo successivo per il consolidamento regio Ingabbiare i possibili ribelli in una gabbia dorata in cui si ci teneva prigionieri da soli Prigionieri di uno schema mentale Lentamente in questa gabbia dorata aspirarono ad entrare i fermenti che agitavano la societa' piegandosi a chi apriva e chiudeva gli sportelli Un ottimo libro che investiga anche il fenomeno nobiliare moderno e lo inquadra nell'assolutismo dei regimi dei secoli XVI XVII XVIII e' : "Alle origini dell'eta' moderna" di Ernst Hinrichs un tempo professore all'universita' Oldenburg dice: .............Per quanto riguarda il sistema di corte e la tecnica di governo in Spagna l'assolutismo era stato realizzato cento anni prima che in Francia Quando Filippo II ( 1556 - 1598 ) si stabili a Madrid nel cuore della Castiglia ,ponendo fine agli spostamenti tradizionali del re attraverso le regioni del regno , compi un passo che sarebbe stato ricalcato da ogni futuro monarca assoluto e che percio' si puo' considerare costitutivo di questa prassi di dominio Il suo sistema di corte era un elaborazione autonoma del cerimoniale borgognone di Carlo V e fu subito accettato dalla nobilta' castigliana Conferendo cariche ufficiali di corte , lego' la nobilta' alla corte e la compenso' delle posizioni perdute, mentre negli uffici chiave poneva giuristi e teologi di estrazione borghese che ( nel mondo castigliano del XVI secolo , il mondo dei Grandi di Spagna e degli hidalgos ) impersonavano il dinamismo politico e sociale ................................... Un periodo buio : La proclamazione della disuguaglianza per nascita considerazionigenealogiche ESCLUSIONE DEI NON NOBILI DALLE CARICHE PUBBLICHE : LA NECESSITA' DI ESSERE NOBILI ESAGERAZIONI E MENZOGNE ----COSTRUZIONE DI UNA REALTA' SOSTITUTIVA Con parole opportune il prof Roberto Bizzocchi : A proposito di cognomi nobiliari : e' un tema che abbiamo gia' affrontato per il medioevo ; ma l'eta' moderna ci riserva alcuni sviluppi interessanti da analizzare .Durante questa eta' giunsero infatti al loro apice la cultura dell'aristocrazia del sangue, l'esaltazione dell'antichita' e lustro delle famiglie , la politica delle serrate oligarchiche , cioe' l'esclusione dei non nobili dalle cariche pubbliche . Tutto cio' ebbe conseguenze anche sul piano onomastico, perche' portare un cognome o un altro poteva discriminare in modo decisivo. Accadde cosi' che chi aveva ambizioni e mezzi ma soffriva sotto il peso di un cognome indicativo di un passato modesto cercasse di cambiarlo , chi ne vantava uno di buon prestigio brigasse per farlo risultare ancora piu' interessante e chi godeva per puro caso di una fortunata omonimia imbrogliasse le carte per rivendicare dei rapporti di parentela nobilitanti La mania genealogica e' cominciata molto prima del cinquecento ed e' sopravvissuta anche alla Rivoluzione francese, ma durante i tre secoli dell'eta' moderna --soprattutto durante i primi due , quando non doveva ancora fare i conti con la ragione illuministica -- ha vissuto il suo periodo d'oro In apertura di questo libro abbiamo visto la famiglia Oldradi proiettare nel 1587 il proprio cognome di ottocento anni all'indietro per mostrarsi in relazione con Carlo Magno , e appena qui sopra ci siamo imbattuti in un messer Simone da Canossa che ha solleticato lavanita' di Michelangelo La letteratura e la documentazione storica del Cinquecento e del Seicento contengono un gran numero di manipolazioni , pasticci e e veri e propri falsi dettati dalla pretesa di nobilitazione e interessanti qui per le loro implicazioni coi cognomi.................. COL XVI SECOLO INIZIA IN TUTTA EUROPA L'ETA' DELLE MONARCHIE UNA NAZIONE NON E' PROPRIETA' DI UN POPOLO MA DIVENTA PROPRIETA' DI UNA FAMIGLIA SI EREDITANO GLI STATI COME COSE PRIVATE PER NOI OGGI E' IMPOSSIBILE CONCEPIRLO MA ALLORA E FINO ALL'OTTOCENTO SARA' COSA NORMALE UN LUNGHISSIMO SONNO L'ARISTOCRAZIA DIVIENE NOBILTA' DI CORTE LA STORIA DI FAMIGLIA DIVENTA FIERA DELLE VANITA' E INIZIA UN EPOCA DI COSTRUZIONE DI FAVOLE GENEALOGICHE SI HA UNA FORTE MISTIFICAZIONE DELLE VICENDE FAMILIARI NELLE FAMIGLIE ARISTOCRATICHE I GRANDI FALSI DEI SECOLI XVI XVII XVIII XIX TALVOLTA QUESTI FALSI FAMILIARI GIUNGONO A FALSIFICARE LA MACROSTORIA LOCALE Il vanto di una famiglia dovrebbe essere quello di aver fatto qualcosa nell'interesse della propria patria Un titolo di demerito dovrebbe esser quello di aver sfruttato gli altri per mantenere la propria opulenza I baroni meridionali che hanno alle spalle i patimenti di tanta povera gente che si e' spaccata la schiena per permettere loro una vita di agi non mi sono simpatici Parteggio per quel cafone ignorante stracciato e senza cultura e con la pancia sempre vuota che permetteva al gentiluomo di essere colto educato e con la pancia sempre piena Quando si dice di un nobile che viveva dei frutti della terra si dimentica cosa vi era dietro questo dar frutti della terra Gia ai primi dell'ottocento Ugo Foscolo ( 1778-1827 ) memore dei valori repubblicani diceva : Io stimo i patrizi , e disprezzo i nobili. Ed e’ per me vero patrizio d’una citta’ chi ha terre da far fruttare , sepolcri domestici da venerare , e Lari da difendere , ed antenati da imitare , i quali per lungo ordine di anni abbiano o arricchita la loro Patria coll’industria o celebrata con le virtu’; e con l’ingegno o protetta col sangue . Ma i titoli , i feudi, e gli stemmi che ogni principe puo’ dare e puo’ torre , e che ogni soldato straniero , o mercatante fortunato , o letterato cortigiano puo’ assumere nei paesi conquistati o usurpati , e che puo’ tramandare ai suoi nipoti , sono ai miei sguardi ricami sopra sucida tela. LA FASCINAZIONE DELLA NOBILTA' Molti si avvicinano alla genealogia con idee sbagliate Molti , sempre meno ma sempre troppi , si avvicinano alla ricerca storico.genealogica sperando di scoprire qualche antenato col titolo nobiliare e considerano insoddisfacente e senza stimoli una ricerca che non dia questi risultati Vi e' una scarsa conoscenza della storia che invece dovrebbe essere la conoscenza base per chi vuole indagare sulla propria famiglia I veri secoli bui non sono quelli medioevali come molti ritengono ma sono invece i secoli XVI XVII E XVIII quando anche in Italia si afferma quella innaturale alleanza tra Monarchia e Chiesa cioe' tra Trono e Religione in cui si afferma come ceto dominante una nobilta' esangue e pallida E in questi secoli che viene veicolato e si afferma per molto tempo il concetto di famiglia nobile contrapposto a quello di famiglia plebea. E questo concetto ha talmente tanta forza da condizionare la societa' con idee che si sono affacciate all'oggi UN SANGUE DIVERSO , UN DESTINO DIVERSO NATI PER COMANDARE E NATI PER OBBEDIRE MITO E MITI DELLA NOBILTA' La nobilta' italiana ha normalmente piedi di argilla ed e' normalmente recente cioe' non poggia le sue radici prima del xvi secolo e non ha alcuna virtu' guerriera di cui far mostra ma e' frutto del denaro insaccato Non ha radici medioevali che parlano almeno di guerriciole e di valore ma e' frutto del favore e del capriccio di un signore fattosi da solo nel xv-xvi secolo e il motivo piu' nobile che sta alla base del titolo e' generalmente la fortuna imprenditoriale ( storicamente ben piu' degna di ricordo che il titolo nobiliare che ne e' conseguenza ) La logica del mondo longobardo o del mondo Carolingio e di un mondo feudale poco si discosta da quelle dei secoli secoli XVI , XVII , XVIII, XIX in cui in effetti si assiste alla rinascita di una specie di mondo feudale forse addirittura piu' ingiusto La nostra esperienza comunale ( Comuni di popolo ) verra' travolta dalla formazione degli stati nazionali in buona parte d'Europa e da Signorie piccole e grandi in Italia L'esperienza della nascita e dello sviluppo dei "Comuni italiani" nel nord dell'Italia e' un momento di modernita' straordinaria in un panorama scialbo di idee Vi e' ancora oggi scarsa consapevolezza della grandezza dell'esperienza comunale italiana ( Comuni di popolo ) La Chiesa cattolica perde la sua universalita' ( che in realta' non aveva mai avuto essendo da sempre separata dalla Chiesa d'oriente ) La separazione delle Chiese dei paesi protestanti della Chiesa d'Inghilterra ed in parte dalla Chiesa francese frantuma potere ed entrate economiche Il rischio dell'allargamento del dissenso ( Repubblica di Venezia ) spinge verso l'adozione di una mentalita' di assedio Quella che si presenta dopo il Concilio di Trento e' : UNA CHIESA SENZA ALCUN VALORE CRISTIANO UNA CHIESA BASATA SULLA SUPERSTIZIONE DELLA POVERA GENTE UNA CHIESA BASATA SULLA IGNORANZA DELL'ANALFABETISMO UNA CHIESA DI POTERE APPOGGIATA ED APPOGGIO AL SOVRANO UNA CHIESA NON PIU' UNIVERSALE MA NAZIONALE UNA CHIESA STRUMENTO DI POTERE E DI IMMOBILISMO UNA CHIESA CHE INSEGNA LA RASSEGNAZIONE ALLA POVERA GENTE E LA TIENE CALMA Alete Dal Canto, nato a Roma il 17 aprile 1883 in Via della Frezza n. 387, da Amodio ed Eva Della Marta.
Fu tra i primissimi soci della Lazio. Socio podista. Si classifica 3° nella gara di marcia del 17 dicembre 1900. E' presente alla gita a piedi di 12 km organizzata dalla sezione podistica il 16 maggio 1901 in cui fu scattata la prima foto conosciuta della S.P. Lazio. A fine maggio dello stesso anno giunse 3° ad una marcia di 50 km svoltasi ai Castelli romani in cui fu preceduto solo da Luigi Bigiarelli e Romano Zangrilli. Nel 1905 era detentore del record italiano di marcia sull'ora con km 11,133. Oltre che sportivo, Dal Canto fu un fecondo scrittore. Libero pensatore, ateo, anticlericale, antimilitarista, probabilmente massone, esoterico, pubblicò numerosi libri tra i quali "Aonio Paleario - Un martire del libero pensiero", "Pietro Carnesecchi", "Chiesa e brigantaggio", "Le imposture del prete", "La Messa svelata ovvero la Commedia Clerico - Acrobatico -Tragico - Antropofago - Teofago - Pagana", "Il culto e le sacre reliquie della Vergine Maria" ecc. Durante la 1^ Guerra Mondiale fu ferito gravemente. Nel 1925 fu nominato Cavaliere. Morì a Roma il 14 ottobre 1968, riposa nel cimitero del Verano. XVI secolo che e' il secolo in cui comincia una controriforma cattolica e quindi da il via ad una religione cupa e sospettosa tutto fuorche' pietosa, appoggiata al potere civile per tenersi in piedi e soffocare le idee di libero pensiero da Wikipedia : Nel XVII secolo, l'assolutismo monarchico si affermò in Francia e in altri Paesi dell'Europa continentale, come la Prussia e la Russia degli zar. Nell'Europa dell'inizio dell'età moderna era la forma di governo più diffusa, nella sua incarnazione di Stato dei ceti dove il potere del principe era affiancato da una corte, ufficiali, parlamenti, Diete, nei quali erano presenti le classi privilegiate, come il clero e la nobiltà, ma spesso il potere di questi apparati si riduceva ad essere puramente consultivo. Non avevano seria influenza nelle decisioni, solamente cercavano di difendere i propri privilegi. Tradizionalmente l'origine del concetto di sovrano assoluto si individua negli scritti di Jean Bodin. Egli sosteneva l'unità, indivisibilità e perpetuità della sovranità. Hobbes, nella sua filosofia della legge naturale, riteneva che i governanti assoluti emergessero in accordo con gli istinti fondamentali degli uomini, in particolare la loro paura della morte e il loro bisogno di potere. Nella sua visione, non poteva esserci ordine sociale senza la cessione del potere a un singolo individuo che lo avrebbe usato per limitare le tendenze violente e anti-sociali del popolo. Hobbes insisteva anche sull'irreversibilità del potere assoluto comunque acquisito, per vie pacifiche o violente, legali o illegali. Nel mondo occidentale il concetto venne ad essere associato con la fede cattolica e le altre confessioni cristiane, nel periodo della riforma protestante. La nozione di "diritto divino dei re" sicuramente esisteva già precedentemente al periodo medioevale. Comunque, fu nel XVI secolo che venne usata intensamente come principale meccanismo politico per incrementare il potere dei re all'interno delle monarchie centralizzate, relativamente ai nobili e ai sudditi. La sua formulazione più esauriente venne data dal vescovo francese Jacques-Bénigne Bossuet e dal sovrano protestante inglese Giacomo I, ma la dottrina dei monarcomachi deve molto agli antichi scritti di Agostino d'Ippona e Paolo di Tarso. Nella Lettera ai Romani, capitolo 13, San Paolo scrisse che i regnanti in terra, anche nel caso in cui non fossero cristiani, erano nominati da Dio alle loro posizioni di potere, allo scopo di punire i malvagi. Alcuni studiosi biblici ritengono che San Paolo stesse scrivendo, in parte, per rassicurare le autorità romane che governavano il suo mondo, che il movimento cristiano non era politicamente sovversivo. Le difficoltà poste per i successivi cristiani furono dovute al fatto che il Nuovo Testamento non contiene piani espliciti per il governo di società principalmente cristiane. Esso assume che i cristiani sarebbero sempre stati una minoranza in un mondo pagano, e i suoi consigli politici erano limitati a suggerire di obbedire alla legge e stare alla larga dai governi pagani. Sant'Agostino modificò l'accento nel suo De Civitate Dei, per gli scopi del da poco convertito Impero Romano, che si trovava in serie difficoltà politiche e militari. Mentre la "Città degli Uomini" e la "Città di Dio" potevano servire a scopi differenti, entrambe erano state istituite da Dio e servivano alla sua volontà ultima. Anche se la "Città dell'Uomo", il mondo del potere secolare, poteva sembrare empio e governato da peccatori, nonostante ciò, era stato posto sulla Terra per proteggere la "Città di Dio". Quindi i monarchi erano stati posti sul loro trono per gli scopi di Dio, e mettere in discussione la loro autorità equivaleva a mettere in discussione quella di Dio. Durante l'inizio del regno di Luigi XIV, Bossuet portò questo argomento alle sue conclusioni estreme. Rivedendo i precedenti dell'Antico Testamento riguardo alla scelta dei re, Bossuet concluse che i re erano consacrati come rappresentanti di Dio sulla Terra. Ognuno di essi aveva ricevuto il suo trono da Dio stesso, e ribellarsi contro la loro autorità era come ribellarsi a Dio. Nessun parlamento, nobile, tanto meno il popolo, aveva il diritto di partecipare a questa autorità data da Dio, poiché era stata conferita dalla provvidenza divina attraverso il diritto di primogenitura. In effetti Bossuet scrisse non per giustificare l'autorità di una monarchia già autocratica, ma per proteggerla da ulteriori incidenti e tumulti che avevano scosso il trono francese, come la serie di "fronde" nelle quali i nobili francesi avevano combattuto insignificanti guerre civili contro l'autorità di Luigi XIII e contro lo stesso Luigi XIV. Gli insegnamenti di Bossuet in definitiva si rivelarono essere la causa di molti tumulti e spargimenti di sangue in Francia. La nozione di diritto divino venne infine spazzata via dalla rivoluzione francese e il vero atto simbolico fu la morte sulla ghigliottina della regina Maria Antonietta, moglie di Luigi XVI, il 16 ottobre 1793, che da accesa sostenitrice di questo principio e implacabile avversaria della causa rivoluzionaria era stata un simbolo del dispotismo e ostinata roccaforte dell'ancien Régime fino alla fine. Per coloro che credevano che il monarca assoluto fosse stato scelto da Dio, la ribellione contro il monarca era equivalente alla ribellione nei confronti di Dio. Quindi, il governo era considerato assoluto, in quanto non poteva essere sfidato. da Wikipedia I secoli precedenti usciti dall'alto medioevo avevano visto l'affermazione del "mercante"l'uomo che costruiva il proprio destino , abbelliva la propria citta' di opere d'arte, la difendeva con la propria spada , partecipava infine con la propria esperienza alla vita politica e alla conduzione dello Stato A nessuno era precluso a priori di migliorere le proprie condizioni sociali ed economiche ( con tutti i distinguo ) Un esperienza sociale troppo innovativa che veniva soffocata perche' pericolosa per Chiesa e Re Soffocato l'Umanesimo tutto prese un aspetto diverso Questa cappa di oscurantismo ebbe influenza su qualunque idea e su qualunque aspetto sociale Nei secoli XVI , XVII , XVIII,ed in parte XIX ) si accetta il concetto di una differenza sociale tra gli uomini benedetta e voluta da Dio stesso Si insegna al povero la rassegnazione al volere di Dio quello che era un cittadino diventa un uomo impotente e si abitua alla vilta' Uno degli elementi fondanti l'importanza di un casato e' l'antichita' dello stipite e l'importanza degli stipiti dell'albero genealogico Questi elementi paiono legittimare le aspirazioni delle nuove generazioni ad avere un ruolo di responsabilita' alla guida della comunita' trasposto dal sito http://www.giustiniani.info/genealogica.html Ricostruire, tassello per tassello, il grande mosaico genealogico di una famiglia, è come fare un affascinante viaggio. Svolgere una ricerca genealogica non vuol dire andare alla ricerca di ascendenti illustri, ma ricostruire le origini del proprio ceppo familiare risalendo all'indietro nelle generazioni e nei secoli a seconda delle fonti disponibili. La ricerca genealogica è una forma di memoria collettiva espressa nell’idioma della parentela. Passando i vari modi di rappresentazione genealogica in ambito ligure citiamo innanzi tutti i “repertori” delle famiglie, particolarmente diffusi nel XVIII secolo in area ligure.
L’interesse per le ricostruzioni famigliari comincia nella seconda metà del cinquecento, quando vengono commissionate ad eruditi specialisti ricerche volte a dimostrare l’antichità, la più remota possibile di nobili casati. Nell’elevato valore simbolico e nei benefici materiali legati all’attestazione di nobiltà si può riconoscere il movente di una crescente domanda di panegirici e scritti celebrativi, in cui si riconosce l’ascendenza dei committenti fino ad uno stipite leggendario, spesso ambientato nella Roma imperiale, in Babilonia o in Troia. Il genealogista individua il mitico fondatore del casato, sovente l’eponimo, e lo collega al committente in linea agnatica, meglio se primogeniturale. Cultura quindi cortigiana e mercenaria, genealogia come celebrazione ed elaborazione di un mito delle origini famigliari, praticata con improbabile rigore e, talvolta, con manifesta disinvoltura, esempi che comunque si ripetono anche ai giorni nostri. La fiorente committenza nella ricerca di legittimazione del proprio prestigio proveniente sia da nobili che da i così detti “neo” ricchi, viene efficacemente tratteggiata da Girolamo Tiraboschi nel 1789 nella sua opera: “Riflessioni sugli scrittori genealogici”: “Un uomo, cui la fortuna dal basso stato, che aveva nascendo, ha sollevato a sublime grado di ricchezze e di onori, desidera prima, poi sogna, e finalmente si persuade, che i suoi maggiori non siano stati si vili, come il volgo s’immagina, e che la sorte abbia bensì per qualche tempo potuto oscurarne, ma non estinguerne lo splendore. Un erudito famelico conosce il lor desiderio, e la loro ambizione; s’insinua destramente nella lor grazia; si mostra profondamente istruito nell’antichissima nobiltà delle loro famiglie, e offre lor la sua opera ad illustrarla scrivendo. Si accetta cortesemente l’offerta; e l’erudito è ben persuaso, che la sua ricompensa sarà in proporzione de’secoli”.
Nonostante che a Genova, forse per il fatto di essere una Repubblica e non una monarchia, fossero poco diffuse che altrove, tuttavia non mancano esempi interessanti di ricostruzioni fantastiche delle origini famigliari che tentano di riportare le genealogie delle famiglie in vista dai re Visigoti e dalle monarchie di Aragona, Asturie, Castiglia e Navarra. Già nel 1775, un certo Battista Coccorno segnalava il dilagare di tal costume della nobiltà genovese ricordando come “in questa metropoli molti pretendono di discendere da Conti della Marca di Germania, da duchi di Cleves, da Conti di Barbona e per insino dagli imperatori Ottoni, come li Lomellini, li Spinoli, li Doria et altri, venuti tutti sono questi dalle Ville di Polcevera, chi da quelle della Lombarda, chi da Boscaglie e Montagne della Riviera e chi da Paesi di Padri ignoti”.
Più ampia e costante a Genova, specie tra il XVI ed il XVIII secolo la produzione delle raccolte di “tavole genealogiche”, anche se il loro scopo non è quello della celebrazione del casato nelle sue origini e nelle sue fortune, ma nella scomposizione capillare dei suoi rami, in funzione dell’accertamento dei diritti successori relativi alla riscossione degli interessi periodicamente maturati sui “titoli” del debito pubblico: sono le così dette “colonne” di San Giorgio, una delle fonti di investimento delle famiglie Genovesi, anche dei Giustiniani, accese e spesso vincolate a legati, vitalizi e fedecommessi come ad esempio come quello del Principe di Bassano di Vincenzo Giustiniani. Quindi più che l’istituzione e la legittimazione dello status vi si riconoscono lo strumento funzionale all’attuazione di strategie patrimoniali. A differenza dei panegirici sopra citati, non sono legati ad una moda letteraria, ma si aggiornano e si riscrivono sino alla fine del settecento, estendendosi progressivamente dalle sole famiglie ascritte al “Liber Nobilitatis” a tutte quelle coinvolte negli investimenti sulle colonne del banco, siano esse nobili o meno.
Un terzo genere di ricerche in questo campo oltre i panegirici e le raccolte di tavole, soprattutto prodotte tra gli inizi del XVII e i primi decenni del XIX sono le “collezioni di schede organizzate secondo un modulo costante” , che si presentano come un distinto e ragionato repertorio o dizionario nel quale vengono raccolte le informazioni ricavate sui singoli membri di ciascuna famiglia. Accanto al nome della famiglia, sono trascritte alcune brevi osservazioni sulle origini e l’arma araldica: se questa è ignota lo scudo è lasciato in bianco. Seguono le note, disposte in ordine cronologico, precedute dalla data a cui risale la notizia e talvolta concluse con la citazione della fonte, dalla quale sono state tratte. L’ordine delle famiglie è differente nei diversi repertori, come criterio di selezione che ne informa sulla struttura. Nei manoscritti risalente agli inizi del XVII secoli e prodotti a Genova, troviamo inserite le sole famiglie cittadine ascritte alla nobiltà. Altre invece inseriscono chiunque abbia soggiornato seppur per breve tempo nella Repubblica Genovese, altri, forse per meglio ossequiare le committenze o i probabili acquirenti, evitano di includere gli individui che, avendo compiuto atti criminali o esercitano mestieri umili, screditano il casato.
I repertori delle schede di famiglia sono a struttura aperta, essendo progressivo, è suscettibile di modifiche, aggiunte o integrazioni o correzioni, aggiornabili con nuove informazioni sulle famiglie e ulteriori annotazioni sui loro componenti. Non sono quindi infrequenti aggiunti trascritte, anche molti anni dopo la stesura, dallo stesso autore, dal committente o dai successivi possessori. Si può riconoscere in queste opere una sorta di “libro di famiglia”. Gli schedari quindi diventano opera collettiva, in cui ciascuno di essi diventa sostanzialmente una copia aggiornata ed integrata del precedente. Alle note trascritte nel primo seicento ricavate pressocchè esclusivamente dagli elenchi delle magistrature cittadine, si aggiunge in seguito lo spoglio dei fondi notarili, le citazioni tratte dagli annalisti e dagli storici della Repubblica, le iscrizioni e le lapidi sepolcrali, i cartolari del Banco di San Giorgio, e naturalmente, le informazioni tratte dai repertoristi precedenti. Il differenziato uso delle fonti utilizzate nell’arco di due secoli per le note repertoriali illustra l’evoluzione del significato funzionale del repertorio tra la fine del XVI secolo e XVIII: probabilmente nato in relazione alla questione dell’ascrizione alla nobiltà e alla conseguente necessità di “provare l’antica abitazione della Stirpe nello Stato” , il repertorio viene in seguito prodotto e consultato per ciò che attiene alle riscossioni di rendite e ai benefici successoriali. Con la riforma delle “Leggi del Casale” del 1576, viene stabilita l’abrogazione del sistema basato sugli alberghi e la riassunzione del cognome abbandonato nel 1528. Le ascrizioni al “Liber nobilitatis” sono limitati a dieci (sette per la città e tre per le riviere), vengono inoltre fissati i principi d’inserimento: antica ascendenza nella storia della Repubblica, nascita legittima, buona reputazione e onestà di costumi, il vivere del proprio e non aver esercitato da almeno tre anni nessuna arte meccanica. Nei processi d’iscrizione istruiti a seguito delle richieste di iscrizione, fra la documentazione prodotta dai candidati accanto alle domande di rito, alle fedi di nascita e di matrimonio dei genitori e alle prove testimoniali, di solito non si trovano gli alberi genealogici: non sono semplicemente richiesti, non escludendo che essi possano essere prodotti per dimostrare l’eccellenza delle origini ed in particolare il ruolo degli antenati nelle cariche pubbliche.
Il repertorio delle famiglie, e talvolta anche la raccolta di tavole genealogiche, è di solito proceduto da un piccolo riassunto (il “ristretto” ) di storia genovese e da una premessa di carattere metodologico di solito a partire dalla fondazione della città in epoca preromana alla riforma degli alberghi Doriana nel 1528 e delle Leggi del Casale del 1576. Ciò è funzionale ad accreditare il ruolo preminente delle parentele nelle storia genovese. Le vicende della Repubblica sono esposte ponendo in evidenza in ruolo delle famiglie a quello degli individui e delle Istituzioni. Nel riassunto viene ambiguamente tratteggiato anche il significato di nobiltà che nella Repubblica di Genova aveva un significato più di compartecipazione alla cosa pubblica piuttosto che un significato squisitamente signorile e di censo come in quella vassalla delle monarchie e principati. A Genova la nobiltà fondata sul sangue non ha nessun fondamento storico del resto lo stesso storico Oberto Foglietta nel XVI secolo afferma che “non v’ha famiglia i cui principj per qualche tempo non siano stati umili, e forse abietti, mà molto più a Genova, ove il sterile territorio hà obbligato i cittadini all’industria” . La condivisione del cognome non implica la discendenza e comunque ad un titolo non corrisponde di per sé alcun merito. Ancora lo storico Stefano Agostino Della Cella afferma “Ognun sa molto bene che ne tempi moderni, anzi ai giorni nostri, si sono ascritti al Libro d’Oro non poche famiglie, che di quelle antichissime non ostante portino la stessa denominazione, anzi lo stesso stemma, con tutto ciò non hanno nulla a che fare con quelle, avendo nel corso delli anni, per diversi accidenti, acquistato o carpito il nome delle antichissime”. Un cognome eminente è del resto una risorsa, la sua aggiunta al proprio, per alleanza o per affiliazione o per clientela, aveva rappresentato tra il XIV e il XVI secolo una pratica consueta che poteva portare, nel tempo alla sostituzione del secondo con il primo come di fatto era stato imposto nel 1528 con le aggregazione delle famiglie nobili in alberghi. Sul finire dello stesso secolo si riporta in una cronaca che “vi sono infiniti Spinoli che zappano in quelle montagne, né li fa nobili il domandarsi Spinoli, ma l’esser scritto nel libro della nobiltà” , ribadendo quanto fosse dubbio il concetto di una nobiltà di sangue preteso dai “vecchi” nobili, ancor più se argomentato sulla pura condivisione del cognome. Gli storici Dalla Cella e Garibaldi considerano nobile chi si è distinto per il “valore militare” , l’attaccamento alla patria e il “giusto ardente zelo della libertà” , più di chi abbia acquisito un titolo senza dare prova di possedere tali valori; come si può affermare delle famiglie che vengono “in altre regioni servilmente innalzate a fumosi titoli”. E’ infatti “di gran lunga più nobile… la difesa e l’amore della libertà propria”, piuttosto che la forsennata vendita del proprio sangue ad un vile interesse, o la malnata ubbidienza alla ingiusta e talor tirannica ambizione di un regnante” (Stefano Agostino Della Cella: “Famiglie di Genova”, ms in 3 tomi 1782-1784).
Viene così riaffermata l’idea di una nobiltà di ascendenza comunale non feudale, come più volte ribadita nella storia genovese. Concetto anche ripreso da altri storici più avanti, come il notaio chiavarese Angelo Della Cella, che giudica “chimerico questo vocabolo di nobiltà solo riferibile per lo più ai ricchi… né so figurarmi per nobile se non colui che difese e governò con disinteresse e plauso la propria Patria”.
La storia della ricerca genealogica si muove quindi sul principio dell’autorappresentazione di un individuo, di una parentela o di una società basata sulle parentele; ma anche legittimazione di status o di diritti successori, esteso a tutti i livelli della stratificazione sociale, che affiora nella documentazione giuridica civile e penale, nelle testimonianze legate ai processi matrimoniali per le cause di consanguineità, nelle pacificazioni imposte sulle faide interparentali soprattutto per le cause sui gravami sulle terre comuni, i giuspatronati, le dispense, i lasciti e sui patrimoni soggetti all’istituto del fedecommesso. Soprattutto in questo ultimo caso il sistema delle sostituzioni implica la previsione di una gerarchia fra le linee, ed è probabilmente questa una delle ragioni che spiega come soprattutto nel seicento si moltiplichino negli archivi di famiglia le ricognizioni genealogiche e i rifacimenti degli alberi.
Nelle introduzione dei repertori tardo settecenteschi, traspare inoltre il desiderio degli autori di essere considerati a pieno titolo tra gli storici genovesi, essendo l’interesse per le famiglie un modo tutt’altro che indiretto di occuparsi di storia patria. I lunghi elenchi di scrittori genovesi posti al termine dei repertori non sono soltanto le liste delle fonti alle quali gli autori hanno attinto notizie, di molti di essi gli autori ne conoscono l’esistenza ma non l’opera se non attraverso la citazione dei repertoristi e degli storici precedenti. Tali elenchi appaiono così come una scheda extrafamigliare quasi una genealogia, in fondo alla quale l’autore del repertorio aspira a essere inserito ed immortalato.
Parte di questo capitolo è stato tratto dal lavoro di Massimo Angelini: “La cultura genealogica in area ligure nel XVIII secolo – introduzione ai repertori della famiglie” , pubblicata negli “Atti della Società ligure di Storia Patria”, n.s. XXXV (1995), I, pp. 189-212
cultura_genealogica La cultura genealogica in area ligure nel XVIII secolo Sempre dello stesso autore segnalo altri articoli presenti nel suo sito: Pubblicazione di Massimo Angelini :
cultura_genealogica Le scritture domestiche in area ligure cultura_genealogicaL’invenzione epigrafica delle origini famigliari trasposto dal sito http://www.giustiniani.info/genealogica.html STORIA DI FAMIGLIA E GENEALOGIA COME APPANNAGGIO DELLE FAMIGLIE NOBILI Nel seicento , settecento nell' ottocento , durante il regno d'Italia ( durato appena 80 anni ) la storia di famiglia e la conseguente storia genealogica divennero un tutt'uno con la storia nobiliare le famiglie titolate si appropriarono della cultura genealogica Era trascurabile e trascurata una storia familiare non arricchita da titoli nobiliari l'odore di stalla cancellava una vita il seicento , il settecento . l'ottocento hanno visto imporre lo straordinario concetto di "sangue blu" e questa pura e semplice ridicolagine frutto d'incoltura condiziono' ieri e condiziona oggi la vanita', e questo a molti basta Il mestiere delle armi oppure la toga o la sottana del prete contrapposte alle disprezzate "arti vili e meccaniche "
Cosi s'impose che il contadino e l'artigiano avessero una storia inutile e non degna di essere tramandata La ricostruzione della storia familiare divenne cosa preclusa ai poveri nell'idea di cosa di interesse risibile Una pesante falsificazione sociale Un imposizione di una cultura di periodo inculcata con tale forza da resistere ancor oggi La Verità scopre la Menzogna di Vincenzo Mannozzi
Un tempo si diceva : bugiardo come un genealogista Il genealogista era qualcuno che alterava le origini e le vicende familiari con l'intento di renderle antiche e di dar loro "nobilta"
per far questo costruiva falsi documenti , alterava o distruggeva documenti , collocava individui in luoghi dove non erano mai stati, gli dava padri e madri che non avevano avuto
POCO MALE SE
Poco male se di fatto alterando i modi dell'ascesa sociale non si alterasse il quadro storico . Mistificando , poi beatificando talvolta i modi sbagliati di questa ascesa : l'assassinio, il furto, l'usura, la borsa nera, l'accaparramento, l'adulterazione, la truffa, il tradimemento, il compromesso, lo sfruttamento, il sopruso, la prostituzione , la menzogna , e atti disonorevoli vari ......................( si dice che il denaro non ha odore ) Giustificando , dipingendo colori tenui anziche' colori foschi........
UNA MICROSTORIA FALSA CHE IMPEDISCE ALLA COLLETTIVITA' DI COSTRUIRE IL FUTURO NON CONOSCENDO IL PASSATO
PEGGIO INSEGNANDOLO E TENTANDO DI FARLO CREDERE DIVERSO La vita umana e' in genere fatta di corruzione nascosta ( piccola o grande corruzione ) Tutti esaltiamo la virtu' e sembriamo detestare il vizio In realta' compensiamo lautamente chi alimenta i nostri vizi e molto spesso ignoriamo chi fa appello alla nostra virtu' la vita umana e' fatta di sporte che vanno e vengono
e' fatta anche di compromessi , di furti, di sopraffazioni, di ingiustizie, di abusi sessuali , di prostituzione , di menzogne , di desideri inconfessabili
ognuno fa finta di credere alla rispettabilita' e alle menzogne dell'altro, atte a dipingere il diavolo con tratti piu' dolci del reale
Il risultato e' questo nostro mondo raccontato in maniera distorta in cui l'ingiustizia la fa da padrona
PIANO PIANO ALMENO PER LE MENZOGNE FAMILIARI PERO' LE COSE VANNO A POSTO CON LA RICERCA UNIVERSITARIA LA VERITA' DOCUMENTALE
Pur timidamente l'approccio alla storia di famiglia e' cominciato a cambiare ; La ricerca storica ( quella che studia la macrostoria ) ha iniziato a studiare i ceti dirigenti ed il loro ruolo, la struttura della societa' . Lo studio prosopografico ha aperto la strada allo studio delle storie familiari . E' iniziato cosi spesso un lavoro demolitorio di bugie consolidate ( interessantissimi in ambito fiorentino gli studi economici del dr Sergio Tognetti che esaminano il successo e il declino dell'avventura commerciale di alcune famiglie e che lo pongono in relazione con l'aspetto pubblico ) gli studi della dottoressa Claudia Tripodi e della dottoressa Isabel Chabot lo studio del dr Giovanni Ciapelli Una famiglia e le sue ricordanze : I Castellani di Firenze nel tre-quattrocento edito da Leo S. Olschki editore Si sta insomma cominciando a riscrivere la storia di una Nazione, nel modo in cui va scritta , cioe' attraverso la storia delle sue famiglie La grande storia e' piu' facile da capire attraverso le vicissitudini delle famiglie che la costruiscono o la subiscono In definitiva la grande storia e' fatta di piccole cose talvolta figlie assurdamente solo del malumore ingiustificato di un potente I meccanismi sono sempre i medesimi e gli attori spesso colpevoli di enormi rovine sono semplici uomini ambiziosi o inconsapevolmente trascinati dagli intrecci della sorte A costruirla sono in pochi e spesso non completamente consapevoli di tutte le conseguenze A subirla sono in molti e le loro vicende ci parlano delle conseguenze che spesso sfuggono indagando solo sulla macrostoria Al posto del concetto di famiglia "famiglia nobile" ( che per tanto tempo ha relegato in un'immobilismo fantastico la storia familiare ) si sta facendo strada il concetto di "famiglia storica" Si guarda alla storia dell'imprenditoria come tassello essenziale della costruzione della grande storia Si rimuove la cultura che costringeva a guardare alla storia di famiglia solo dalla finestra della storia nobiliare Si comprende come altre fossero le storie che andavano visitate Si fa strada il concetto che l' apporto alla macrostoria di una "famiglia nobile" possa essere risibile e quello di una"famiglia non nobile" notevole L'importanza del titolo nobiliare viene oggi totalmente ridimensionata La nobilitazione viene vista come un semplice episodio nella storia di secoli di una famiglia e come episodio che interessa alcuni rami e non interessa altri Se ne scavano le motivazioni liberando il titolo nobiliare dalle esaltazioni fantastiche del passato ; guardandolo in una visione critica e non esegetica , Viene cioe' messo in luce il reale contributo alla macrostoria dato dalle famiglie E' vicino l'interesse alla ricostruzione della storia delle famiglie che hanno subito la storia ed hanno reagito per sopravvivere creando i fermenti per i moti convettivi che hanno portato l'emersione di facce continuamente nuove nell'economia della Nazione E' da aspettarsi che le vicende ed il contesto storico di una povera famiglia emigrante possano aver talvolta piu' valore nella ricostruzione di una corretta immagine del passato delle vicende di una famiglia titolata in un certo senso quiete , statiche e banali Fare quindi ricerca , come accadeva ( ed accade ancora ) spesso solo per cercare antenati titolati ( nobili ) di una famiglia avra' sempre meno importanza Come detto l' ottenimento di un titolo nobiliare e' solo un episodio nella lunga storia di una famiglia ( a volte episodio da valutare perche' a volte un titolo nobiliare e' originato da motivi molto mediocri quando non ignobili ) storia lunga secoli e che talvolta presenta episodi che maggiormente la segnano e ne cambiano il destino La sola ricerca genealogica privilegiante gli antenati nobili e' quindi gia' oggi un modo molto maldestro di ricostruire una storia di famiglia e ancor piu' lo sara' in futuro Scrivete la storia della vostra famiglia o del vostro cognome ; servira' prima o poi alla Macrostoria La storia di famiglia appartiene a tutti e ricostruire la storia di una famiglia contadina o operaia e delle sue sofferenze e' spesso un modo di capire meglio i tempi Un ceto dirigente dovrebbe avere come dice il nome principalmente dei doveri diceva Sant'Agostino Comandare e' una responsabilita' che comporta l'aspirazione all'interesse comune .....Nella casa del giusto ,anche coloro che esercitano un comando non fanno altro che prestare un servizio a coloro cui sembrano comandare ; essi di fatto non comandano per cupidigia di dominio , ma per dovere di fare del bene agli uomini , non per orgoglio di primeggiare , ma per onore di provvedere....... i secoli videro l'Italia colassare sotto la guida di un ceto dirigente che badava solo al mantenimento dei privilegi e proteggeva l'immobilismo Una miriade di piccoli titolati che imperversarono su un Italia prostrata intenti solo a succhiare un osso senza carne Il manzoniano fantastico Don Rodrigo ne e' il simbolo Sinceramente ed ottusamente convinto della propria superiorita' su una plebe nata senza diritti Quindi occhio di cosa vi volete vantare , potreste trovarvi a vantare di persone che hanno travasato il vuoto nel vuoto , probabilmente non per colpa loro ma per colpo di una cultura vecchia e stantia che permeava l'aria che respiravano e che tappava gli occhi e intorcigliava le lingue e che comunque non hanno fatto nulla per modificare perche' in definitiva faceva loro comodo Ho letto che vi e' qualcuno che proclama ancora che la STORIA ha un debito verso la nobilta' E' vero ha un debito di sofferenza . Un debito che ancora chiede giustizia La mancanza di documenti autentici o comunque attendibili crea una frattura genealogica col mondo romano Il periodo longobardo e' sicuramente caratterizzato dalla carenza di documentazione e da individuazioni problematicissime con patronimici scarni, spesso limitati al solo nome e alla funzione anche le prime crociate sono piu' legate piuì a favole posteriori piu' che che a fatti veri e coevi L'uso del cognome moderno inizia nel periodo a cavallo degli anni 1150 e sostituisce con enorme lentezza l'uso del patronimico Registrazione dei battesimi cominciano a comparire solo a cavallo del 1400 e si generalizzeranno intorno al 1614 in forme cognominali I documenti cominciano a ricomparire con una certa abbondabza verso il XII secolo e sono perlopiu' documenti di donazioni alla Chiesa ( quindi riguardanti solo un certo settore sociale ) ...................... METODI DI FALSIFICAZIONE
Tutto cio provoca rischi enormi di omonimia , ( in modo particolare l'uso dei patronimici e' una enorme fonte di errori ) E questo fu ed e' sfruttato da falsari piu' o meno abili Ma i falsari non si limitarono a sfruttare le omonimie , ma fabbricarono documenti falsi e distrussero quanti piu' documenti autentici che ebbero tra le mani al fine di proteggere le loro menzogne DEBOLEZZE DELLA NOBILTA' E CREAZIONE DI MITI PER RAFFORZARE L'IMMAGINE IL RANGO , IL DECORO , LO STILE DI VITA ADEGUATO AL RANGO
ANTICHITA' DEL RANGO
AGGANCIO A PERSONAGGIO NOBILE ED ANTICO OMONIMO MA DEL TUTTO ESTRANEO Chi aveva soldi si affidava ad un genealogista compiacente , che mescolava bene le carte e costruiva alberi genealogici falsi ma di gran lustro Molto spesso se non sempre in barba alla storia Oggi che conosciamo meglio la storia molti falsi diventano immediatamente evidenti E in futuro sara' ancora piu' semplice riconoscere il falso Insomma non c'e' futuro per le balle FAVOLE GENEALOGICHE A CUI FINALMENTE SI E' SMESSO DI CREDERE Ancora oggi vi sono alcuni che chiamano queste mistificazioni CULTO DEL LIGNAGGIO O IL DARE LUSTRO ALLA STORIA FAMILIARE e di questo si deve ridere perche' si tratta di vere truffe con cui si e' tentato di modificare la realta' storica E' il bambino colto a rubare la marmellata che balbetta una scusa Queste grossolane menzogne evidenziano la debolezza di un periodo storico che aveva bisogno di adornarsi di falsita' per aver valore Prof Alfeo Giacomelli A Bologna la tendenza alla "sostituzione" di famiglie antiche con altre recenti, in origine caratterizzate da altri cognomi, era così diffusa che in parte venne accettata ed avallata dalle stesse famiglie antiche, mentre in altri casi fu lo stesso potere politico aristocratico a favorirla. Del resto le grandi famiglie patrizie erano le prime a fare, da molto tempo, impressionanti falsi genealogici nei quali esse stesse non credevano: a Bologna, ad esempio, i Grassi rivendicavano la continuità coi Grassi "Clarissimi" già illustri e caratterizzati da vescovi nel XII sec.; alterarono probabilmente ancora le loro più specifiche genealogie per nascondere la discendenza illegittima da cardinali e cortigiane e, a loro volta, finirono per riconoscere l’improbabile derivazione di famiglie fiamminghe o dei Grassi del palazzo veneziano, nobilitati da recenti e popolane origini chioggiotte. Prof Alfeo Giacomelli Oggi stiamo imparando a guardare ( lentamente e faticosamente ) con senso critico e con sana diffidenza alle notizie che non hanno supporto documentario Cosi : titoli , contee o marchesati che hanno come pezze giustificative documenti falsi inventati ad hoc, ( diplomi imperiali , omonimie,.....) falsi diplomi di titoli nobiliari mai posseduti comprovati ingenuamente o bonariamente dalle consulte araldiche del Regno d'Italia falsi legami genealogici e parentele inesistenti, Lo sfruttamento di omonimie per colmare gli anelli mancanti sull'albero genealogico Le "opere prave"dei genealogisti per accontentare il committente che pagava piu' volentieri per un risultato gratificante ( con creazione di documenti falsi e peggio distruzione di documenti veri che potevano smentire ) ci paiono finalmente falsificazioni a cui non poter prestare fede Stiamo insomma imparando a smantellare le tante bugie del passato SOLO CIARPAME PASSATISTA IN MOLTI CASI MA IN TALUNI CASI GRAVI FALSIFICAZIONI DELLA STORIA 
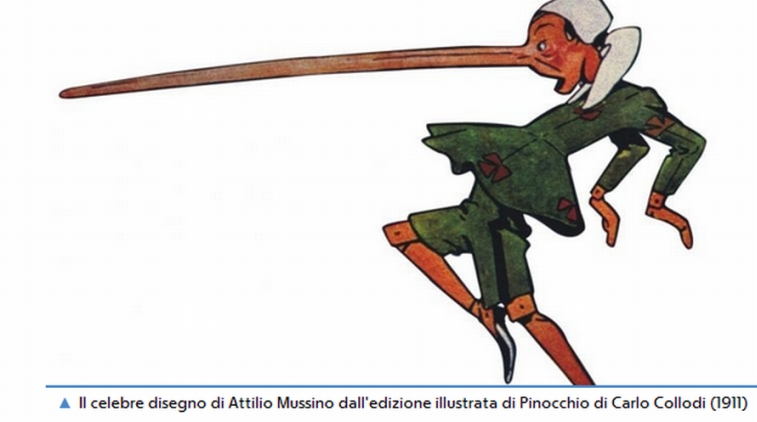
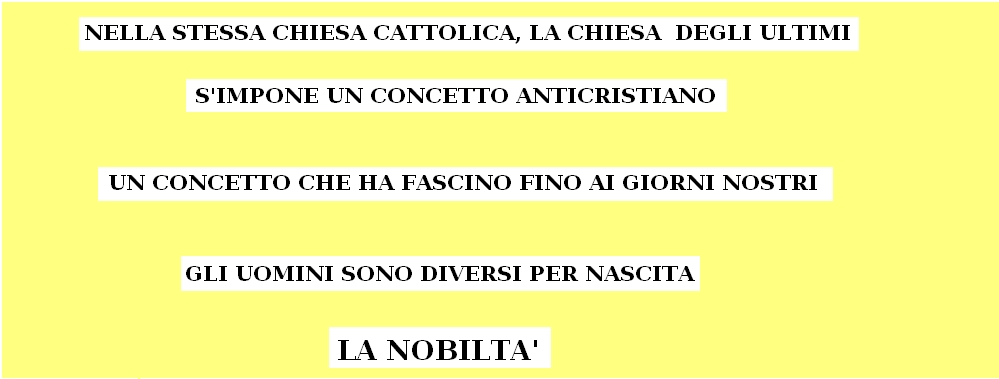
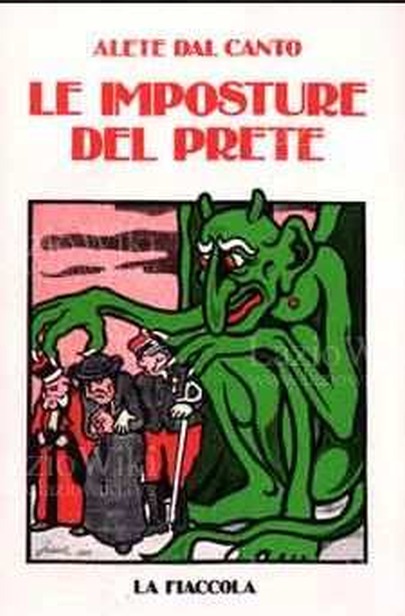

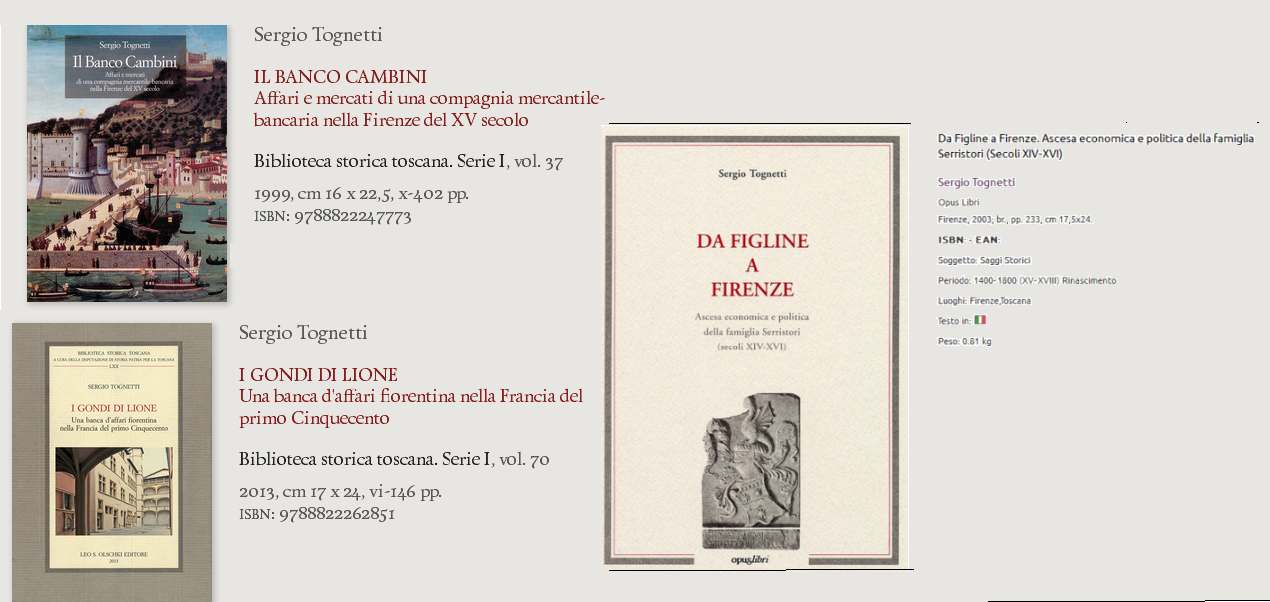
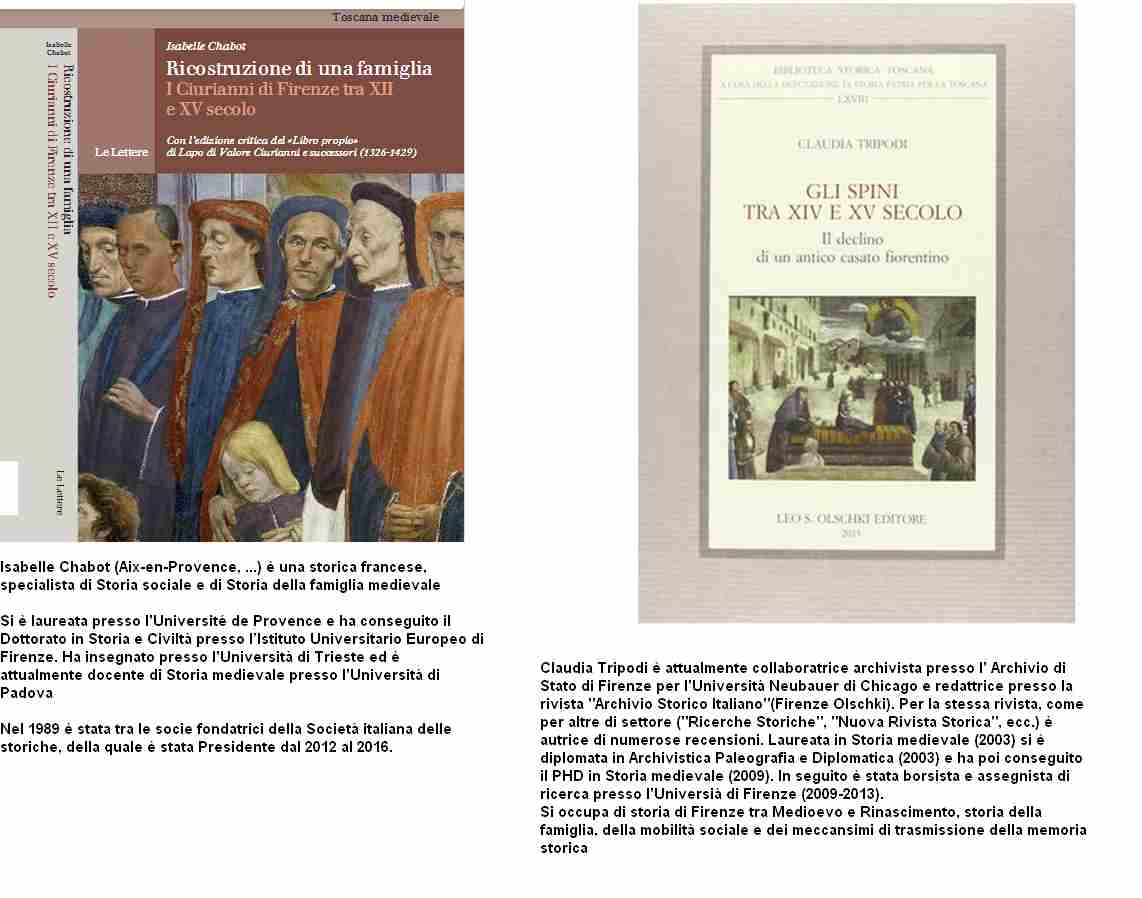
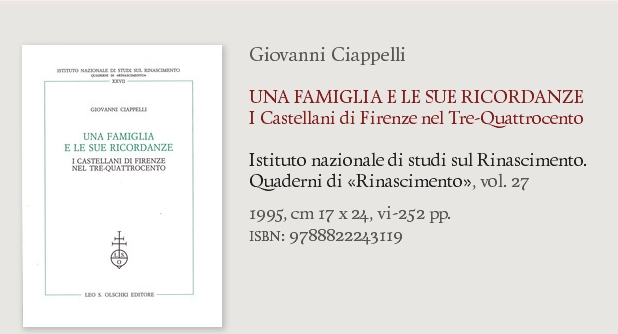
Questa e' la ragione di tante invenzioni
Occhio quindi a non bersi come verita' le tante favole che ancora qualcuno tenta di far circolare sulla propria famiglia
Era quasi un obbligo della famiglia nobile o arricchita inventare leggende sull'origine familiare supplendo spesso alla detta fragilita' delle origini
Quando la genealogia non era una scienza e procedeva senza regole, era di una semplicita' disarmante falsare i legami genealogici e la storia familiare
In buonafede ed in malafede
Vi furono genealogisti seri , condizionati dal modo di studio dei loro tempi , e che quindi non poterono evitare di cadere in errori anche grossolani mancando dei mezzi di cui oggi disponiamo e mancando di una metodologia scientifica
Vi furono quindi alcuni genealogisti in buonafede ( traditi da omonimie e dalla cattiva interpretazione dei documenti )
Moltissimi genealogisti in malafede ben consapevoli dell'utilizzo di omonimie e di documenti falsi
Vi furono poi autentici falsari che inserirono in documenti antichi nomi che non figuravano , che crearono diplomi reali o imperiali mai emessi , che crearono parentele basate solo su indimostrate omonimie , che infine distrussero i documenti che potevano rivelare i loro inganni
La commissione dell'albero genealogico e delle notizie sulla famiglia presupponevano un esito che compiacesse all'ordinante e moltissimi si adeguarono per denaro
Alla fine divenne una moda inventare favole : antenati bizantini , antenati crociati , antenati normanni , cavalieri di Carlo Magno, guerrieri del Barbarossa. o addirittura mitici giganti
Ciascuna famiglia aveva la sua favola basata su tradizione orale e non documentata
La presenza nell'ottocento sul campo di genealogisti tuttologi ( E PRIVI DI METODO SCIENTIFICO ) come il Crollalanza o lo Spreti o il Passerini (anche il Passerini ) o il Litta .............ha fatto da cassa di risonanza a vecchi studi genealogici ( PRIVI DI METODO SCIENTIFICO ) ed ha dato veridicita' coll'autorita' del loro nome a studi e a leggende che oggi non hanno piu' alcun valore
....Ripetete una bugia cento , mille , un milione di volte e diventera' una verita'
Le menzogne sono dure a morire
Conseguenza di cio' e' che ancor oggi si legge nelle storie familiari di incredibili favole genealogiche basate su eredita' verbali avvallate solo dall'autorita'(ad esempio ) del Crollalanza , che se nell'ottocento venivano accettate come vere in una reciproca accondiscendenza , oggi meriterebbero una denuncia d'ufficio per abuso della credulita' popolare
Leggo oggi nel 2020 un libro del 2010 recensito cosi :
...............Le parole con cui l'erudito del XVI secolo Antonio Augustino, nel suo Liber de familiis Romanorum, ricorda l'antica famiglia degli Aelii, o Ailii, o Alli, costituiscono una delle più antiche testimonianze sulle origini di uno dei pochi casati che possano vantare radici nella storia della Roma repubblicana.........................
Che qualcuno nel 2010 possa lasciar credere al lettore che esistano documenti di qualsiasi tipo che possano riallacciare la genealogia di una qualsiasi famiglia all'impero romano o peggio alla repubblica romana e' agghiacciante ed antistorico
Peggio ancora che si spinga il lettore a pensare che gli scritti di un qualsiasi erudito del passato possano esser portati come prova ( nessuno storico si sognerebbe oggi di far affermazioni senza documentarle con materiale coevo )
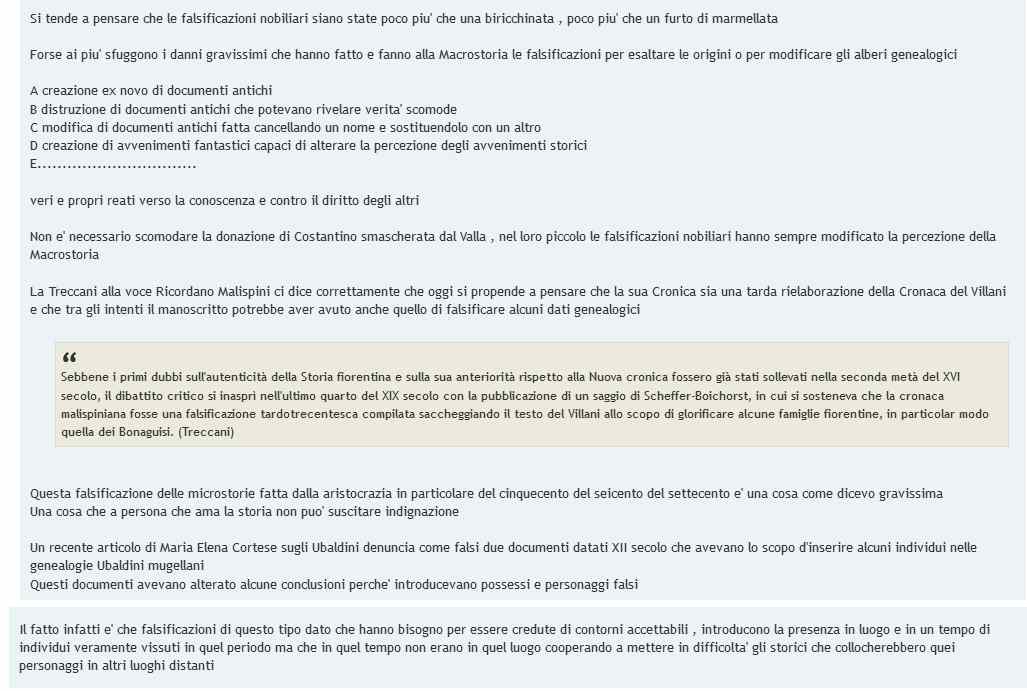
Il grande errore imputabile ai Crollalanza , agli Spreti , ai Mango di Casalgerardo , ecc , sono appunto di aver fatto da cassa di risonanza a favole ed invenzioni genealogiche giunte cosi ai giorni nostri, dando a vedere di avvalorarle solo nel riportarle , mentre avrebbero dovuto formulare dubbi e critiche
Difficilmente opere come quelle degli autori citati saranno possibili in futuro
L'Italia ha avuto la grande eta' comunale ( dei Comuni di popolo ) che e' stato un fatto di un innovazione sconvolgente in un Europa oscurata da un feudalesimo perdurante ma che ha fatto si che esista un Italia dalle cento patrie e nessuna uguale all'altra
Per questo motivo io ritengo impossibile essere un tuttologo
per questo ritengo inconcepibili e da prendersi con le molle il Crollalanza o lo Spreti ed anche il Litta , perche' in genealogia ritengo si possa coltivare solo un orticello non molto grande
Entrati nell'eta dei patronimici quando in un luogo non esistono ancora i cognomi si possono continuare a ricavare le genealogie e trovare le origini di una famiglia
Entrati nei patronimici perso il filo rosso del cognome ( che comunque in molti casi gia' si prestavava all'errore di omonimia ) il problema dell'omonimia si presenta moltiplicato di molto
E qui occorre un estrema conoscenza dei documenti ed una memoria dei nomi (avere un database ) ampissimo ecco perche' l'orto non puo' essere grande
Occorre ricordare migliaia di documenti
Quindi si puo' arrivare intorno all'anno 1000 e rarissimamente sfondarlo con notevoli rischi di un omonimia nascosta che richiede conoscenza della geografia antica delle vicende storiche e sociali insomma dell'ambiente
Questo spiega perche' l'orto genealogico di cui ci si occupa deve essere di piccole dimensioni
Nel passato i Crollalanza , gli Spreti , i Mango , i Litta , anche i Passerini per prima cosa non avevano a disposizione gli strumenti di cui oggi disponiamo , i metodi di studio non avevano la rigorosita' richiesta oggi , inoltre erano costretti a fidarsi di collaboratori che alla lunga si sono dimostrati a volte affidabili ed altre volte (il piu' delle volte : specie nelle origini delle famiglie ) completamente inaffidabili
PASSERINI : Autore di una grave e falsa convinzione
Omaggio ( un pasticciaccio ) non richiesto a Napoleone Bonaparte da parte di uno dei piu' quotati genealogisti dell'epoca
«Ma la confusione più grande l'ha provocata lo studio del fiorentino Passerini, che nel 1856 fece risalire l'albero genealogico dell'allora regnante Napoleone III direttamente ai Cadolingi. La sua argomentazione, allora molto apprezzata, si basava su un documento (conservato nell'Archivio di Stato di Firenze), del 15 maggio 1235, redatto a Fucecchio, secondo il quale un certo Jamfaldus di Firenze avrebbe fatto, per sé e per la sua famiglia, una donazione all'ospedale di Rosaia. Come figlio di Jamfaldus viene nominato un "Willielmo qui nuncupatur Bonaparte", e come fondatore dell'ospedale il gran conte Ugo, un antenato (abavus) di Jamfaldo.
Basandosi su questo documento il Passerini stabilì un legame tra la casa Bonaparte e i C. e pensò di poter risolvere anche gli altri problemi genealogici.
Il Passerini, dirigeva la Biblioteca Magliabechiana di Firenze ed aveva una lunga esperienza di studio su manoscritti, eppure non si accorse o non volle accorgersi che il documento del 1235 era una grossolana falsificazione moderna
Forse, egli contro ogni evidenza, volle attenersi ad esso per rendere omaggio con la sua opera all'imperatore francese.
In ogni caso la sua costruzione genealogica non regge ad un esame critico
Come dice il detto popolare : le bugie hanno le gambe corte
Alcune invenzioni significativedelle famiglie nobili per arricchire la propria storia familiare
Troiani ,Romani e Bizantini , Crociati , Longobardi , Goti , Franchi ,Normanni , diplomi imperiali , omonimie , usurpazione di stemmi ..........................
Oggi prova di somma ignoranza storica e scarsa preveggenza degli sviluppi della ricerca ma nello stesso tempo intralcio alla verita'
Saggio del dr Francois Menant
Alterazione della storia di Bergamo la famiglia Bonghi
Saggio del dr Massimo Angelini
Alterazione della storia familiare in Liguria Alcuni falsi familiari in Liguria
Saggio del dr Massimo Angelini
Alterazione della storia familiare un falso su una famiglia Garibaldi
Da una discussione di Monaldo Leopardi padre di Giacomo
Alterazione della storia familiare Recanati
Un saggio della dottoressa Roberta Mucciarelli : (edito in “Bullettino Senese di Storia Patria”, CIV, 1997, pp. 357-376)
Alterazione della storia familiare La costruzione del mito attraverso le carte della Consorteria Piccolomini
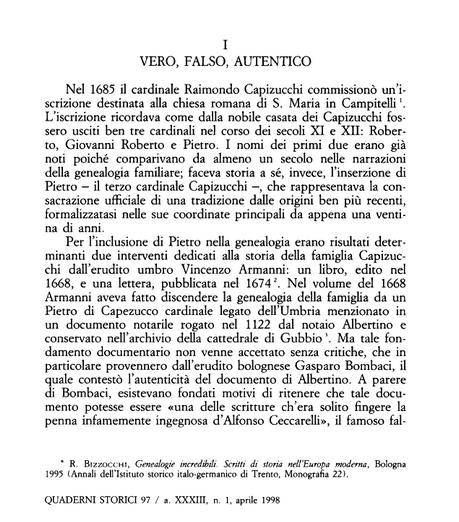
Dall'errore "cassa da risonanza" non vanno esenti ancor oggi la Treccani e Wikipedia , che in alcuni casi continuano a riportare leggende familiari prive di qualunque documentazione e credibilita'
I GRANDI FALSARI DEL PASSATO
e' interessante ricordare la vita e le opere di Carlo Galluzzi ( 1616 - 1672 ) e di suo figlio Giacomo ( 1651-1685 ) che spiegano come fosse organizzata la falsificazione e come comportasse la distruzione di documenti veri vedi Treccani TRECCANI CARLO GALLUZZI
FORSE IL PIU' GRANDE DI TUTTI
Alfonso Ceccarelli o Ciccarelli (Bevagna, 21 febbraio 1532 – Roma, 9 luglio 1583) è stato un falsario, storico, scrittore e genealogista italiano.
Provvide egli stesso, utilizzando molteplici pseudonimi (Fanusio Campano, Giovanni Selino, Jacopo Corello, Gabino Leto ecc.), a confezionare testi ”antichi” ricchi di fantastiche ricostruzioni storiche, intramezzate con alcune notizie vere ed altre false, quantunque a volte verosimili, tanto da riuscire spesso difficile distinguere le une dalle altre.
Con il suo nome, firmò numerosi testi di storia e di genealogia, quasi tutti rimasti manoscritti, basandoli prevalentemente sulle fonti da lui precostituite.
Trasse così in inganno numerosi storici, scrittori, genealogisti (ad esempio: Eugenio Camurrini, Giovanni de’ Crescenzi, Innocenzo Cybo Ghisi, Ferdinando Marra, Paolo Moriggia, Francesco Sansovino, Lodovico Vedriani, ecc.) i quali, con un approccio quantomeno accondiscendente, diedero credito a quanto da lui asserito. Fra i contemporanei, pochi furono coloro che sollevarono dubbi o perplessità; tra questi Alberico Cybo e Scipione Ammirato. Una disamina più attenta e critica delle affermazioni pseudo-storiche disseminate dal Ceccarelli fu elaborata a decorrere dal XVII secolo: da Leone Allacci, il primo che denunciò l'inconsistenza delle fonti e delle notizie da lui riportate, a Girolamo Tiraboschi, che gli riservò la maggior parte delle sue Riflessioni sugli scrittori genealogici, sino a studi più recenti. Ciò nonostante numerosi testi genealogici, agiografici o di storia locale continuano ad essere redatti facendo ricorso alla fantasiosa bibliografia ceccarelliana.
L'avidità di ulteriori e maggiori guadagni - nonostante la notorietà e ricchezza acquisite (nel 1580 fu pure nominato conte palatino dal pretendente al trono del Montenegro in esilio, Nicola Crnojevic) ed i pressanti inviti rivoltigli dal padre di lasciare Roma e ritornare in famiglia - lo spinsero a passare dalle mere contraffazioni storico-genealogiche, più o meno innocue, alle falsificazioni, anche su commessa, di testamenti, fidecommessi, passaggi di proprietà.
Vere e proprie truffe che, alfine, lo videro imputato innanzi il tribunale della Camera pontificia. Tra le accuse vi fu anche quella di aver prodotto un falso diploma con il quale l'imperatore Teodosio I (IV sec.) confermava la supposta donazione di Costantino (Constitutum Constantini), a lungo considerata la fonte istitutiva del potere temporale della Chiesa cattolica.
Incarcerato, ammise gli addebiti giustificando il suo comportamento in un memoriale che presentò in sua difesa. Al termine del processo, con sentenza del 1º giugno 1583 emessa da monsignor Girolamo Mattei, regnante Papa Gregorio XIII, il Ceccarelli fu condannato a morte e giustiziato
Eugenio Gamurrini deve collocarsi a mezza strada egli si limitava scientemente a inventare origini remotissime alle famiglie che lo ingaggiavano per una storia genealogica inventando di aver visto documenti a riprova
Cosi pure Aurelio Grifoni
E si bisticciavano pure tra loro accusandosi vicendevolmente:
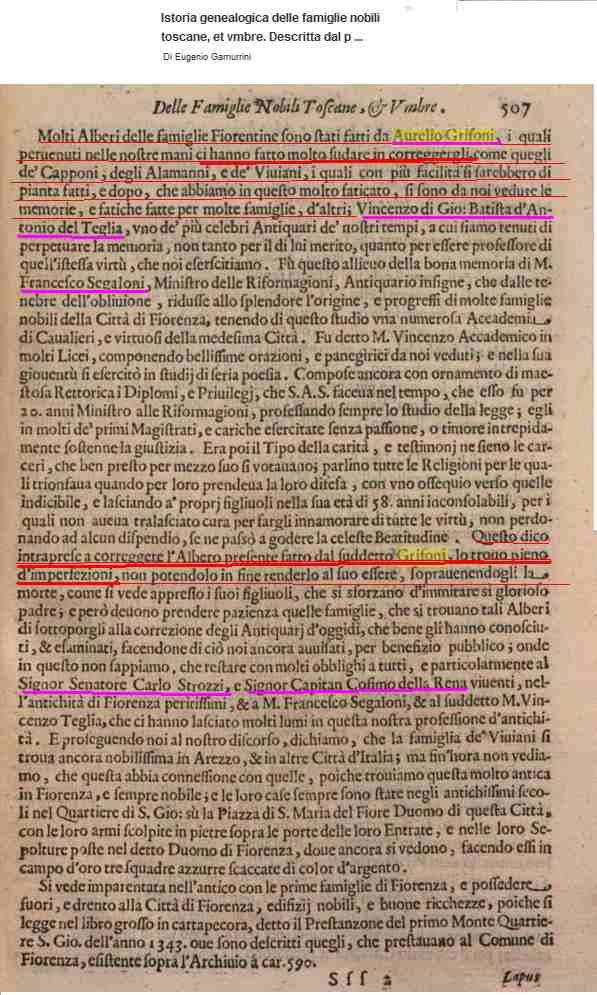
In ambito fiorentino e' annosa come ricordato la questione su Ricordano Malispini e della glorificazione dei Buonaguisi e di alcune altre famiglie a cui viene data antichita'
La storia del Malispini contiene tutta una serie di elementi fantastici come la creazione di cavalieri aurati da parte di Carlo Magno
Antonio Maresti per Ferrara inventa stemmi e antichita' , per alcune famiglie cerca radici nell'antica Roma
FERRARA Teatro genealogico ed istorico vol 1 FERRARA Teatro genealogico ed istorico vol 2
In ambito diplomatistico si distingue il falso storico (documento formalmente genuino, che contiene dati inesatti o inventati) dal falso diplomatico (atto fabbricato per attestare atti giuridici o avvenimenti la cui documentazione originale è perduta). Si trovano molti esempi di entrambi i tipi di falso nel Medioevo: la critica moderna ha, per esempio, svelato i falsi privilegi fabbricati a loro favore dai monaci di Montecassino per retrodatare o ampliare i possessi della loro abbazia. Si ebbe una grande produzione di documenti falsi anche tra la seconda metà del 16° sec. e la prima metà del 18°, soprattutto per ragioni genealogiche, in Francia e in Italia. Attualmente i mezzi in possesso della critica diplomatica hanno di molto diminuito la fortuna dei falsi documentari, che costituiscono comunque un’interessante testimonianza storicoculturale.
( TRECCANI )
La falsificazione sulla storia familiare ha imperato in mille forme e per molti secoli
Talvolta ha coinvolto personaggi insospettabili
Nel bel saggio di Luca Trapani sugli Usimbardi di Colle
da sottili alterazioni a grossolane alterazioni
alterazione storia familiare Albero ouero Genealogia de' signori Lazaradelle
LA LEZIONE DELLA MACROSTORIA
SE IL CAMMINO UMANO E' IN DIVENIRE E IL POTER VOLGERSI AL PASSATO COMPRENDENDOLO E' QUELLO CHE SI CHIAMA ESPERIENZA
OCCORRE MEDITARE PROFONDAMENTE SU QUESTI SECOLI NEO-FEUDALI
COMPRENDERE I MOTIVI INTELLETTUALI , ETICI ,E RELIGIOSI CHE LI HANNO RESI POSSIBILI
SI SANCI L'INEGUAGLIANZA COME REGOLA DI VITA
PER LUNGHI SECOLI LA NOSTRA NAZIONE SI ADDORMENTO' , SI AVVILI ,
Se dici cacciavite sai a cosa serve
se dici medico sai a che cosa serve
se dici nobile ....................A cosa serve ?
E' questo il punto di partenza che spiega tutto
E' stupefacente come dopo 6000 anni di storia noi stiamo ancora a fare le medesime cose
Razze , disuguaglianza , confini , patria , proprieta' , eredita' ,potere , denaro, guerra , furto , dio religione superstizione preti
neve fritta ma anche veleno
Tutto questo perche' siamo una specie animale che fa anno dopo anno le medesime cose che ha fatto dalla scoperta del fuoco e dove prevale il bisogno del capo branco
Non ci sarebbe niente di male ma il fatto e' che nel frattempo una gran quantita di persone costruisce la piramide e precipita ,o va a combattere e muore , patisce la fame , si ammala , si prostituisce
E' evidente che c'e' qualcosa che va profondamente cambiato
Io credo che l'uomo possa IMMAGINARE la giustizia , o la verita' . o la giustizia sociale MA NON SIA IN GRADO DI REALIZZARLE
Consapevole di cio' non dovrebbe smettere di sperimentare modelli sociali per la ricerca della felicita'
Consapevole comunque che nessuna delle sue leggi potra' essere giusta o adeguata
La nobilta' e' una incrostazione dello sviluppo sociale che ha portato gli uomini da poche migliaia a otto miliardi , con tutti i problemi conseguenti
Ritorniamo alla domanda
se dici nobile ....................A cosa serve un nobile?
La nobilta e' un concetto moralmente deleterio Ha un valore storico. Ma anche la guerra ha un valore storico
Incredibilmente va a braccetto con la religione quando dovrebbero essere agli antipodi essendo l'una un concetto che proclama le persone diverse per nascita e l'altra che ne dichiara l'uguaglianza ( anche se non chiaramente )
Una delle tante contraddizioni
potere sui corpi potere sulle anime
ora un concetto italiano di nobilta' non e' in realta' mai esistito per lungo tempo : quindi e' un concetto relativamente moderno ( tanto che le dispute sulla nobilta cominceranno nel XIV secolo )
Prima qualche tentativo di deificazione dell'Imperatore con la grande civilta' romana , e notabilita' col patriziato poi coi Longobardi poi Italo /longobardi /goti si aveva il concetto di uomo libero e servo ma non il concetto di nobile
Si mettevano in risalto le virtu guerriere e Re e Duca erano cariche gerarchiche ed amministrative ( niente eredita' )
La nobilta' e' un concetto che viene introdotto in Italia dai Franchi con la cultura feudale
Nonostante cio' i marchesi ed i conti inizialmente non rappresentano quel concetto di nobilta' ma sono semplicemente cariche pubbliche e burocratiche come i nostri prefetti La nobilta' la vedi solo nei conti palatini le persone vicine alla corte imperiale
E' con gli Ottoni e con il Barbarossa e Federico II che le cose cambiano
Con loro un concetto EREDITARIO di nobilta' inizia a formarsi
Un concetto perche' in questo periodo IX ----XIII secolo luogo da luogo , tempo da tempo vi sono sensibilissime differenze
Bada bene l' organizzazione e' feudale e vassallatica e influenzata dal fortissimo spopolamento , dalla incapacita' del potere centrale di controllo del territorio quindi dal crollo del potere centrale e della nascita di poteri locali di tipo mafioso
Nelle citta' in Italia nascono i comuni sotto il vescovo
Nelle campagne e nel resto d'Europa i poteri signorili
Uscendo dalla storia ed entrando in discorsi filosofici
E qui nasce il concetto NASCOSTO ma caratterizzante
Se guardi le antiche carte trovi la figura del FEDELE e il concetto di FIDELITAS
Cioe' vi e' l'accettazione di un potere , e il giuramento di difenderlo , in cambio della concessione di privilegi tangibili
QUESTA E' L'ESSENZA della nobilta' : la FIDELITAS
Crolla l'impero e nei vuoti di potere si comincia ad affermare il monarca e la signoria ed il concetto di stato ereditario
Non si perde il concetto essenziale
Il fedele accetta un potentato , vi e' protezione reciproca . ed in cambio la parte fedele riceve un riconoscimento pubblico di privilegio
Sembra banale ma le conseguenze dal punto di vista logico sono dirompenti
La nobilta' e' legata al patto di fidelitas e quindi esiste solo in relazione a quel rapporto
Cessa quando la fons honorum e' debellata
Meglio cessa quando la fons honorum in qualunque modo perde il controllo del territorio dato al fedele
Esempio :La nobilta' toscana o duo siciliana decade totalmente quando il controllo del territori passa ad un signore diverso
E come potrebbe essere altrimenti . Alla base deve esserci la fiducia ed un nuovo patto di fidelitas
Ciascuno si circonda di persone di cui si fida
ti rendi conto che stiamo parlando di cose anacronistiche e le nostre parole suonano surreali ( meno male e' roba che interessa poche migliaia di persone ) ma seguitando a parlarne
Dire che la nobilta' non si estingue o che la nobilta' e' congelata o che la nobilta' e' un eredita' immateriale e' un emerita cazzata
Non fosse che e' neve fritta in una Repubblica dopo la rivoluzione francese la nobilta' e' legata alla fons honorum ed al controllo del territorio da parte di questa
Questa e' filosofia
poi volendo parlare di cosa sia stata realmente la nobilta' , storicamente puoi solo parlare di ceti dirigenti , della disuguaglianza , delle leggi che sancivano privilegi ed abusi , della religione come classe e cane da guardia morale , del disprezzo verso il lavoro manuale , dell'ignoranza culturale , ed allora giustifichi qualunque eccesso di vendetta popolare
Peggio sarebbe parlare del fascino che esercita ancora la nobilta'
Che e' legato al modo fantasioso con cui viene ancora raccontata la storia
E per il fatto che l'usurpazione di ricchezza e' stata tale che molti nobili mantengono ancora una forza patrimoniale notevole
|
considerazionigenealogiche
l'ineguaglianza entra negli alberi genealogici : Una delle opere prave dei genealogisti e' l' epurazione dei parenti poveri dagli alberi delle famiglie nobili ( di quei parenti che puzzando di stalla mettevano tanto a disagio ) .Relegando di fatto i poveri a non avere storia
E' un concetto giunto fino ai nostri giorni un contadino non poteva essere parente di un aristocratico
Interessante e controcorrente e' questo estratto da un
intervento del prof Alfeo Giacomelli - Università di Bologna ,
Estratto un po’ lungo ma molto arricchente per chi ama la geneologia
Non buttate il Crollalanza..... Storia degli Sturani di Ancona Un falso stemma Uberti / ufficiale
importanti questi studi Guido da Canossa ---Treccani---Gherardo Ortalli Bonifacio da Canossa---Treccani--Gherardo Ortalli Il cavallo di Gabrotto di Canossa Storia dei Canossa di Verone e di Mantova
|
CONTRADDIZIONI
Il concetto di Fidelitas
Sappiamo che il nostro concetto di nobilta' prende l'avvio con Carlo Magno che questo concetto nasce e si evolve in modo ben diverso da come e' nato ma che alla base presuppone un vecchio saldo concetto guerriero : il concetto di FIDELITAS verso il capo
In regime feudale, e' il dovere che gli inferiori nella piramide avevano verso il loro signore di assisterlo con aiuti materiali e con forze militari, ogni volta che ne avesse bisogno.contraccambiato con il diritto ad una serie di privilegi nella catena di comando
Un giuramento di fedeltà, dal latino fidelitas (la fedeltà o "sentimento di lealtà verso..."), è un pegno di lealtà di una persona verso un'altra. In genere il giuramento viene fatto su di un oggetto religioso come una Bibbia o su una Santa reliquia, spesso contenute all'interno di un altare, vincolando il giuramento come fatto davanti a Dio. Fedeltà e omaggio sono un elemento chiave del feudalesimo.
................................
Nell'Europa medievale, un giuramento di fedeltà è stato un elemento fondamentale del sistema feudale nel Sacro Romano Impero. Esso è stato giurato tra due persone, la persona obbligata (vassallo) ed una persona di rango (signore feudale). Il giuramento di fedeltà/lealtà era solitamente effettuato nell'ambito di una cerimonia tradizionale, in cui il sottoposto fedele o il vassallo dava al suo Signore un pegno di fedeltà e di accettazione delle conseguenze di un tradimento della fiducia. In cambio il Signore ha promesso di proteggere e rimanere leale al suo vassallo. I diritti conferiti al vassallo erano così simili al possesso effettivo che è stato descritto come usufrutto (dominium utile), mentre i diritti del Signore erano di proprietà diretta (dominium directum).
Nel tardo Medioevo, l'investitura e il giuramento di fedeltà sono state sempre registrate in un atto; in tempi moderni questo ha sostituito la cerimonia tradizionale.
Dove la distanza geografica tra le due parti è stata significativa, il Signore poteva nominare un rappresentante davanti al quale il giuramento veniva prestato.
L'intero contratto tra cui il giuramento di fedeltà era parte di una formale cerimonia di encomio che ha creato il rapporto feudale.
by Wikipedia
Ho altrove posto il problema che con la nascita della borghesia il grande presupposto per la nobilta' e' la ricchezza . Poi vedremo negli albi d'oro nel passato venire escluso chiunque non avesse un reddito sufficiente:
Tanto i Patrizi quanto i Nobili, PENA LA PERDITA del loro status, dovevano mantenere col dovuto decoro la nobilta' trasmessa loro dagli antenati
Ho altrove posto il problema dell'incompatibilita' del concetto cristiano degli uomini come fratelli in Cristo col concetto della nobilta' che li vede diversi : nobili ed ignobili
Ora vi pongo un altro problema NESSUNO PUO' SERVIRE DUE PADRONI, perché o odierà l'uno e amerà l'altro, oppure si affezionerà all'uno e disprezzerà l'altro.
Domando :
Come poteva un nobile che aveva giurato fedelta' al Re delle due Sicilie rimanere nobile del Regno d'Italia se non spergiurando una FIDELITAS da lui giurata o giurata dai suoi antenati ?
Jean-Pierre Labatut ha definito la nobiltà quale «una qualità eminente che solo alcuni uomini possiedono»:11 anche i teorici italiani, portoghesi e francesi del Cinquecento avevano espresso lo stesso principio.
Il nobile –prosegue Labatut– è colui che si è sciolto dai bisogni elementari del vivere e da tali bisogni va esente grazie al lavoro manuale compiuto da altri. Parimenti egli resta esente dalle servitù ordinarie della condizione umana e così dà un senso alla società di cui si colloca al vertice.
Altre sono le doti che lo caratterizzano, e cioè la generosità, la liberalità e la libertà. Ma se la nobiltà è una élite sociale, essa è anche una élite militare, e resta assodato che la sua vera natura può essere compresa solo nel quadro degli ordini in cui la società è articolata. 12
Poco dopo il Mille, Adalberone di Laon aveva distinto la società della sua epoca in tre ordini: l’ordine costituito dagli uomini di preghiera, cioè i religiosi; l’ordine formato da coloro che portavano le armi, cioè i nobili; e, infine, l’ordine costituito da coloro che lavoravano: quest’ultimo comprendeva tutti coloro che non appartenevano ai due ordini precedenti.
Da questo semplice schema, nel corso dei secoli XII e XIII si cominciano a precisare le caratteristiche dell’ordine nobiliare: si collegano strettamente tra loro le due nozioni di nobiltà e cavalleria; alla funzione militare si uniscono, per i nobili, quella politica, quella economica e il compito di preservazione delle terre e dei feudi; il ceto sociale formato dai nobili tende sempre maggiormente a costituirsi in categoria ereditaria.
È a questo punto, come afferma ancora Labatut, che diviene
[…] legittimo definire la nobiltà come il gruppo sociale che possiede uno statuto giuridico particolare, che si perpetua per via biologica, e rinnova i suoi ranghi (con l’immissione di nuovi nobili) in base a regole quanto mai rigorose.13
Nel Rinascimento, infatti, l’idea di nobiltà si diversifica rispetto a quella che si aveva in epoca medievale, perché viene a cadere il concetto di uguaglianza degli uomini di fronte a Dio.
Dal canto loro gli umanisti […] riscoprono la filosofia degli antichi, e quindi insistono nell’illustrare il fondamento giusto e legittimo della disuguaglianza.14
Gli uomini –essi spiegano– nascono naturalmente dissimili e la società deve rispecchiare questa disuguaglianza. Per natura, i nobili ricevono in eredità il coraggio e, in virtù di questo, è loro consentito di esercitare il potere sugli altri. La società è divisa in ordini e la nobiltà si preoccupa di salire sul gradino più alto di questa gerarchia.
La nobiltà –però– è sotto il controllo dell’autorità politica che può esigere l’esibizione di prove da coloro che pretendono di avere diritto ad essere inclusi tra i nobili. Tuttavia l’autorità politica non era sempre quella di uno Stato monarchico relativamente centralizzato, come, ad esempio, era lo Stato francese.
Anzi, di tali funzioni di controllo poterono a volte incaricarsi assemblee della nobiltà oppure degli organi municipali.15
by LA LEGGE DEL 1750 SULLA REGOLAMENTAZIONE DELLA NOBILTÀ E CITTADINANZA NEL GRANDUCATO DI TOSCANA: UN CASO ARETINO (ITALIA
NOBILTA.......................nobilta europea e toscana (( Anna Borgia )
|
RESIDUI DI MITOLOGIA L'UOMO E' DA SEMPRE UN ANIMALE RELIGIOSO : PAURA SUPERSTIZIOSA , SPERANZA , BISOGNO DI GIUSTIZIA
Cesare Saccaggi (Tortona, 7 febbraio 1868 – Tortona, 3 gennaio 1934)
La Bibbia che di libro sacro ha solo il nome essendo una raccolta contraddittoria di documenti profani , racconta il pensiero degli antichi che allora opinavano naturalmente su un origine da un seme che identificavano in Adamo ed Eva , inconsapevoli del metodo darwiniano e dei problemi evoluzionistici
Non credo in un Adamo ed in una Eva primordiali, ritengo vi siano molti stipiti primordiali e le vicende degli incroci del nostro DNA molto complicate
GENESI
Capitolo 1
1 In principio Dio creò il cielo e la terra. 2 Ora la terra era informe e deserta e le tenebre ricoprivano l'abisso e lo spirito di Dio aleggiava sulle acque. 3 Dio disse: «Sia la luce!». E la luce fu. 4 Dio vide che la luce era cosa buona e separò la luce dalle tenebre 5 e chiamò la luce giorno e le tenebre notte. E fu sera e fu mattina: primo giorno. 6 Dio disse: «Sia il firmamento in mezzo alle acque per separare le acque dalle acque». 7 Dio fece il firmamento e separò le acque, che sono sotto il firmamento, dalle acque, che son sopra il firmamento. E così avvenne. 8 Dio chiamò il firmamento cielo. E fu sera e fu mattina: secondo giorno. 9 Dio disse: «Le acque che sono sotto il cielo, si raccolgano in un solo luogo e appaia l'asciutto». E così avvenne. 10 Dio chiamò l'asciutto terra e la massa delle acque mare. E Dio vide che era cosa buona. 11 E Dio disse: «La terra produca germogli, erbe che producono seme e alberi da frutto, che facciano sulla terra frutto con il seme, ciascuno secondo la sua specie». E così avvenne: 12 la terra produsse germogli, erbe che producono seme, ciascuna secondo la propria specie e alberi che fanno ciascuno frutto con il seme, secondo la propria specie. Dio vide che era cosa buona. 13 E fu sera e fu mattina: terzo giorno. 14 Dio disse: «Ci siano luci nel firmamento del cielo, per distinguere il giorno dalla notte; servano da segni per le stagioni, per i giorni e per gli anni 15 e servano da luci nel firmamento del cielo per illuminare la terra». E così avvenne: 16 Dio fece le due luci grandi, la luce maggiore per regolare il giorno e la luce minore per regolare la notte, e le stelle. 17 Dio le pose nel firmamento del cielo per illuminare la terra 18 e per regolare giorno e notte e per separare la luce dalle tenebre. E Dio vide che era cosa buona. 19 E fu sera e fu mattina: quarto giorno. 20 Dio disse: «Le acque brulichino di esseri viventi e uccelli volino sopra la terra, davanti al firmamento del cielo». 21 Dio creò i grandi mostri marini e tutti gli esseri viventi che guizzano e brulicano nelle acque, secondo la loro specie, e tutti gli uccelli alati secondo la loro specie. E Dio vide che era cosa buona. 22 Dio li benedisse: «Siate fecondi e moltiplicatevi e riempite le acque dei mari; gli uccelli si moltiplichino sulla terra». 23 E fu sera e fu mattina: quinto giorno. 24 Dio disse: «La terra produca esseri viventi secondo la loro specie: bestiame, rettili e bestie selvatiche secondo la loro specie». E così avvenne: 25 Dio fece le bestie selvatiche secondo la loro specie e il bestiame secondo la propria specie e tutti i rettili del suolo secondo la loro specie. E Dio vide che era cosa buona. 26 E Dio disse: «Facciamo l'uomo a nostra immagine, a nostra somiglianza, e domini sui pesci del mare e sugli uccelli del cielo, sul bestiame, su tutte le bestie selvatiche e su tutti i rettili che strisciano sulla terra». 27 Dio creò l'uomo a sua immagine; a immagine di Dio lo creò; maschio e femmina li creò. 28 Dio li benedisse e disse loro: «Siate fecondi e moltiplicatevi, riempite la terra; soggiogatela e dominate sui pesci del mare e sugli uccelli del cielo e su ogni essere vivente, che striscia sulla terra». 29 Poi Dio disse: «Ecco, io vi do ogni erba che produce seme e che è su tutta la terra e ogni albero in cui è il frutto, che produce seme: saranno il vostro cibo. 30 A tutte le bestie selvatiche, a tutti gli uccelli del cielo e a tutti gli esseri che strisciano sulla terra e nei quali è alito di vita, io do in cibo ogni erba verde». E così avvenne. 31 Dio vide quanto aveva fatto, ed ecco, era cosa molto buona. E fu sera e fu mattina: sesto giorno. Capitolo 2 1 Così furono portati a compimento il cielo e la terra e tutte le loro schiere. 2 Allora Dio, nel settimo giorno portò a termine il lavoro che aveva fatto e cessò nel settimo giorno da ogni suo lavoro. 3 Dio benedisse il settimo giorno e lo consacrò, perché in esso aveva cessato da ogni lavoro che egli creando aveva fatto. 4aQueste le origini del cielo e della terra, quando vennero creati. 4bQuando il Signore Dio fece la terra e il cielo, 5 nessun cespuglio campestre era sulla terra, nessuna erba campestre era spuntata - perché il Signore Dio non aveva fatto piovere sulla terra e nessuno lavorava il suolo 6 e faceva salire dalla terra l'acqua dei canali per irrigare tutto il suolo -; 7 allora il Signore Dio plasmò l'uomo con polvere del suolo e soffiò nelle sue narici un alito di vita e l'uomo divenne un essere vivente. 8 Poi il Signore Dio piantò un giardino in Eden, a oriente, e vi collocò l'uomo che aveva plasmato. 9 Il Signore Dio fece germogliare dal suolo ogni sorta di alberi graditi alla vista e buoni da mangiare, tra cui l'albero della vita in mezzo al giardino e l'albero della conoscenza del bene e del male. 10 Un fiume usciva da Eden per irrigare il giardino, poi di lì si divideva e formava quattro corsi. 11 Il primo fiume si chiama Pison: esso scorre intorno a tutto il paese di Avìla, dove c'è l'oro 12 e l'oro di quella terra è fine; qui c'è anche la resina odorosa e la pietra d'ònice. 13 Il secondo fiume si chiama Ghicon: esso scorre intorno a tutto il paese d'Etiopia. 14 Il terzo fiume si chiama Tigri: esso scorre ad oriente di Assur. Il quarto fiume è l'Eufrate. 15 Il Signore Dio prese l'uomo e lo pose nel giardino di Eden, perché lo coltivasse e lo custodisse. 16 Il Signore Dio diede questo comando all'uomo: «Tu potrai mangiare di tutti gli alberi del giardino, 17 ma dell'albero della conoscenza del bene e del male non devi mangiare, perché, quando tu ne mangiassi, certamente moriresti». 18 Poi il Signore Dio disse: «Non è bene che l'uomo sia solo: gli voglio fare un aiuto che gli sia simile». 19 Allora il Signore Dio plasmò dal suolo ogni sorta di bestie selvatiche e tutti gli uccelli del cielo e li condusse all'uomo, per vedere come li avrebbe chiamati: in qualunque modo l'uomo avesse chiamato ognuno degli esseri viventi, quello doveva essere il suo nome. 20 Così l'uomo impose nomi a tutto il bestiame, a tutti gli uccelli del cielo e a tutte le bestie selvatiche, ma l'uomo non trovò un aiuto che gli fosse simile. 21 Allora il Signore Dio fece scendere un torpore sull'uomo, che si addormentò; gli tolse una delle costole e rinchiuse la carne al suo posto. 22 Il Signore Dio plasmò con la costola, che aveva tolta all'uomo, una donna e la condusse all'uomo. 23 Allora l'uomo disse: è carne dalla mia carne e osso dalle mie ossa. La si chiamerà donna perché dall'uomo è stata tolta». 24 Per questo l'uomo abbandonerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie e i due saranno una sola carne. 25 Ora tutti e due erano nudi, l'uomo e sua moglie, ma non ne provavano vergogna.
Capitolo 3 1 Il serpente era la più astuta di tutte le bestie selvatiche fatte dal Signore Dio. Egli disse alla donna: «E' vero che Dio ha detto: Non dovete mangiare di nessun albero del giardino?». 2 Rispose la donna al serpente: «Dei frutti degli alberi del giardino noi possiamo mangiare, 3 ma del frutto dell'albero che sta in mezzo al giardino Dio ha detto: Non ne dovete mangiare e non lo dovete toccare, altrimenti morirete». 4 Ma il serpente disse alla donna: «Non morirete affatto! 5 Anzi, Dio sa che quando voi ne mangiaste, si aprirebbero i vostri occhi e diventereste come Dio, conoscendo il bene e il male». 6 Allora la donna vide che l'albero era buono da mangiare, gradito agli occhi e desiderabile per acquistare saggezza; prese del suo frutto e ne mangiò, poi ne diede anche al marito, che era con lei, e anch'egli ne mangiò. 7 Allora si aprirono gli occhi di tutti e due e si accorsero di essere nudi; intrecciarono foglie di fico e se ne fecero cinture. 8 Poi udirono il Signore Dio che passeggiava nel giardino alla brezza del giorno e l'uomo con sua moglie si nascosero dal Signore Dio, in mezzo agli alberi del giardino. 9 Ma il Signore Dio chiamò l'uomo e gli disse: «Dove sei?». 10 Rispose: «Ho udito il tuo passo nel giardino: ho avuto paura, perché sono nudo, e mi sono nascosto». 11 Riprese: «Chi ti ha fatto sapere che eri nudo? Hai forse mangiato dell'albero di cui ti avevo comandato di non mangiare?». 12 Rispose l'uomo: «La donna che tu mi hai posta accanto mi ha dato dell'albero e io ne ho mangiato». 13 Il Signore Dio disse alla donna: «Che hai fatto?». Rispose la donna: «Il serpente mi ha ingannata e io ho mangiato». 14 Allora il Signore Dio disse al serpente: sii tu maledetto più di tutto il bestiame e più di tutte le bestie selvatiche; sul tuo ventre camminerai e polvere mangerai per tutti i giorni della tua vita. 15 Io porrò inimicizia tra te e la donna, tra la tua stirpe e la sua stirpe: questa ti schiaccerà la testa e tu le insidierai il calcagno». 16 Alla donna disse: i tuoi dolori e le tue gravidanze, con dolore partorirai figli. Verso tuo marito sarà il tuo istinto, ma egli ti dominerà». 17 All'uomo disse: «Poiché hai ascoltato la voce di tua moglie e hai mangiato dell'albero, di cui ti avevo comandato: Non ne devi mangiare, maledetto sia il suolo per causa tua! Con dolore ne trarrai il cibo per tutti i giorni della tua vita. 18 Spine e cardi produrrà per te e mangerai l'erba campestre. 19 Con il sudore del tuo volto mangerai il pane; finché tornerai alla terra, perché da essa sei stato tratto: polvere tu sei e in polvere tornerai!». 20 L'uomo chiamò la moglie Eva, perché essa fu la madre di tutti i viventi. 21 Il Signore Dio fece all'uomo e alla donna tuniche di pelli e le vestì. 22 Il Signore Dio disse allora: «Ecco l'uomo è diventato come uno di noi, per la conoscenza del bene e del male. Ora, egli non stenda più la mano e non prenda anche dell'albero della vita, ne mangi e viva sempre!». 23 Il Signore Dio lo scacciò dal giardino di Eden, perché lavorasse il suolo da dove era stato tratto. 24 Scacciò l'uomo e pose ad oriente del giardino di Eden i cherubini e la fiamma della spada folgorante, per custodire la via all'albero della vita. Capitolo 4 1 Adamo si unì a Eva sua moglie, la quale concepì e partorì Caino e disse: «Ho acquistato un uomo dal Signore». 2 Poi partorì ancora suo fratello Abele. Ora Abele era pastore di greggi e Caino lavoratore del suolo. 3 Dopo un certo tempo, Caino offrì frutti del suolo in sacrificio al Signore; 4 anche Abele offrì primogeniti del suo gregge e il loro grasso. Il Signore gradì Abele e la sua offerta, 5 ma non gradì Caino e la sua offerta. Caino ne fu molto irritato e il suo volto era abbattuto. 6 Il Signore disse allora a Caino: «Perché sei irritato e perché è abbattuto il tuo volto? 7 Se agisci bene, non dovrai forse tenerlo alto? Ma se non agisci bene, il peccato è accovacciato alla tua porta; verso di te è il suo istinto, ma tu dòminalo». 8 Caino disse al fratello Abele: «Andiamo in campagna!». Mentre erano in campagna, Caino alzò la mano contro il fratello Abele e lo uccise. 9 Allora il Signore disse a Caino: «Dov'è Abele, tuo fratello?». Egli rispose: «Non lo so. Sono forse il guardiano di mio fratello?». 10 Riprese: «Che hai fatto? La voce del sangue di tuo fratello grida a me dal suolo! 11 Ora sii maledetto lungi da quel suolo che per opera della tua mano ha bevuto il sangue di tuo fratello. 12 Quando lavorerai il suolo, esso non ti darà più i suoi prodotti: ramingo e fuggiasco sarai sulla terra». 13 Disse Caino al Signore: «Troppo grande è la mia colpa per ottenere perdono? 14 Ecco, tu mi scacci oggi da questo suolo e io mi dovrò nascondere lontano da te; io sarò ramingo e fuggiasco sulla terra e chiunque mi incontrerà mi potrà uccidere». 15 Ma il Signore gli disse: «Però chiunque ucciderà Caino subirà la vendetta sette volte!». Il Signore impose a Caino un segno, perché non lo colpisse chiunque l'avesse incontrato. 16 Caino si allontanò dal Signore e abitò nel paese di Nod, ad oriente di Eden. 17 Ora Caino si unì alla moglie che concepì e partorì Enoch; poi divenne costruttore di una città, che chiamò Enoch, dal nome del figlio. 18 A Enoch nacque Irad; Irad generò Mecuiaèl e Mecuiaèl generò Metusaèl e Metusaèl generò Lamech. 19 Lamech si prese due mogli: una chiamata Ada e l'altra chiamata Zilla. 20 Ada partorì Iabal: egli fu il padre di quanti abitano sotto le tende presso il bestiame. 21 Il fratello di questi si chiamava Iubal: egli fu il padre di tutti i suonatori di cetra e di flauto. 22 Zilla a sua volta partorì Tubalkàin, il fabbro, padre di quanti lavorano il rame e il ferro. La sorella di Tubalkàin fu Naama. 23 Lamech disse alle mogli: mogli di Lamech, porgete l'orecchio al mio dire: Ho ucciso un uomo per una mia scalfittura e un ragazzo per un mio livido. 24 Sette volte sarà vendicato Caino ma Lamech settantasette». 25 Adamo si unì di nuovo alla moglie, che partorì un figlio e lo chiamò Set. «Perché - disse - Dio mi ha concesso un'altra discendenza al posto di Abele, poiché Caino l'ha ucciso». 26 Anche a Set nacque un figlio, che egli chiamò Enos. Allora si cominciò ad invocare il nome del Signore. Capitolo 5 1 Questo è il libro della genealogia di Adamo. Quando Dio creò l'uomo, lo fece a somiglianza di Dio; 2 maschio e femmina li creò, li benedisse e li chiamò uomini quando furono creati. 3 Adamo aveva centotrenta anni quando generò a sua immagine, a sua somiglianza, un figlio e lo chiamò Set. 4 Dopo aver generato Set, Adamo visse ancora ottocento anni e generò figli e figlie. 5 L'intera vita di Adamo fu di novecentotrenta anni; poi morì. 6 Set aveva centocinque anni quando generò Enos; 7 dopo aver generato Enos, Set visse ancora ottocentosette anni e generò figli e figlie. 8 L'intera vita di Set fu di novecentododici anni; poi morì. 9 Enos aveva novanta anni quando generò Kenan; 10 Enos, dopo aver generato Kenan, visse ancora ottocentoquindici anni e generò figli e figlie. 11 L'intera vita di Enos fu di novecentocinque anni; poi morì. 12 Kenan aveva settanta anni quando generò Maalaleèl; 13 Kenan dopo aver generato Maalaleèl visse ancora ottocentoquaranta anni e generò figli e figlie. 14 L'intera vita di Kenan fu di novecentodieci anni; poi morì. 15 Maalaleèl aveva sessantacinque anni quando generò Iared; 16 Maalaleèl dopo aver generato Iared, visse ancora ottocentotrenta anni e generò figli e figlie. 17 L'intera vita di Maalaleèl fu di ottocentonovantacinque anni; poi morì. 18 Iared aveva centosessantadue anni quando generò Enoch; 19 Iared, dopo aver generato Enoch, visse ancora ottocento anni e generò figli e figlie. 20 L'intera vita di Iared fu di novecentosessantadue anni; poi morì. 21 Enoch aveva sessantacinque anni quando generò Matusalemme. 22 Enoch camminò con Dio; dopo aver generato Matusalemme, visse ancora per trecento anni e generò figli e figlie. 23 L'intera vita di Enoch fu di trecentosessantacique anni. 24 Poi Enoch cammino con Dio e non fu più perché Dio l'aveva preso. 25 Matusalemme aveva centottantasette anni quando generò Lamech; 26 Matusalemme, dopo aver generato Lamech, visse ancora settecentottantadue anni e generò figli e figlie. 27 L'intera vita di Matusalemme fu di novecentosessantanove anni; poi morì. 28 Lamech aveva centottantadue anni quando generò un figlio 29 e lo chiamò Noè, dicendo: «Costui ci consolerà del nostro lavoro e della fatica delle nostre mani, a causa del suolo che il Signore ha maledetto». 30 Lamech, dopo aver generato Noè, visse ancora cinquecentonovantacinque anni e generò figli e figlie. 31 L'intera vita di Lamech fu di settecentosettantasette anni; poi morì. 32 Noè aveva cinquecento anni quando generò Sem, Cam e Iafet. Capitolo 6 1 Quando gli uomini cominciarono a moltiplicarsi sulla terra e nacquero loro figlie, 2 i figli di Dio videro che le figlie degli uomini erano belle e ne presero per mogli quante ne vollero. 3 Allora il Signore disse: «Il mio spirito non resterà sempre nell'uomo, perché egli è carne e la sua vita sarà di centoventi anni». 4 C'erano sulla terra i giganti a quei tempi - e anche dopo - quando i figli di Dio si univano alle figlie degli uomini e queste partorivano loro dei figli: sono questi gli eroi dell'antichità, uomini famosi. 5 Il Signore vide che la malvagità degli uomini era grande sulla terra e che ogni disegno concepito dal loro cuore non era altro che male. 6 E il Signore si pentì di aver fatto l'uomo sulla terra e se ne addolorò in cuor suo. 7 Il Signore disse: «Sterminerò dalla terra l'uomo che ho creato: con l'uomo anche il bestiame e i rettili e gli uccelli del cielo, perché sono pentito d'averli fatti». 8 Ma Noè trovò grazia agli occhi del Signore.
Una religione che guardava e guarda alla vita con sospetto e quasi mai con gioia Contraria ai piaceri della carne , al divertimento, predicante la macerazione e la penitenza , la sofferenza, la rassegnazione, il rimorso Era una religione dichiaratamente nemica delle elucubrazioni scientifiche sino dai tempi di San Paolo , e che tale si mantiene ai giorni nostri Che ha sempre rimandato la giustizia al regno dei cieli Molto meglio e naturale , la religione dei nostri padri pagani , molto piu' disincantati (e in tale a dire il vero ( eliminati i righi preteschi ) la stiamo ritrasformando : non rispettando i precetti , peccando e pentendoci, aprendo alle eccezioni e ai dubbi Con un ricco Pantheon di nuovi dei : la madonna , gli angeli , i santi ( ognuno ne ha due o tre a cui si affida ), migliaia di personaggi maggiori e minori che cercano di influire sul nostro destino tramite la recita di formule magiche dette preghiere
Secondo Lutero, il Purgatorio era un “terzo luogo” ignorato dalle Scritture. È solo alla fine del XII secolo che nasce la credenza in un luogo intermedio dell’aldilà: un evento che va oltre la storia della religione e della spiritualità, e che Le Goff collega alle nuove strutture sociali e politiche del feudalesimo e alle conquiste economiche, agricole e mercantili. Ed è cosí che le grandi sistemazioni culturali, filosofiche e anche teologiche che avevano governato il modo di pensare e di vivere dell’uomo medievale, vengono radicalmente messe in discussione. La nascita del Purgatorio, attraverso un attento studio della società medievale e della mentalità collettiva, dimostra infatti come l’affermarsi di una nuova visione del mondo abbia fatto sí che il peccato non decidesse tragicamente il destino dell’anima umana, ma che fosse possibile salvarsi in un “secondo regno, dove l’umano spirito si purga e di salire al cielo diventa degno”.
https://axismundi.blog/2021/02/02/cristiani-e-pagani-un-conflitto-inconciliabile/
Ma quale sarà il destino di quelli che in vita loro non hanno mai sentito parlare di Gesù? Dante colloca (perlomeno) nel Limbo i giusti che non conobbero Cristo, come Virgilio, la sua guida, ma altri li ritenevano dannati tout court. Il che, almeno per i Germani e i Norreni, creava un problema enorme: i loro antenati. Your predecessors, former princes of the Frisians, dying unbaptized, are undoubtedly damned, dice a re Rathbod il vescovo Wulfram [13]. E però re Rathbod, che aveva già i piedi in acqua replica al vescovo Wulfram che se il suo battesimo non salverà i suoi antenati preferisce stare con loro; e dunque rifiuta il battesimo: fonte regenerationis noluit mergi [14]. [13] «I tuoi antenati… morendo senza battesimo, sono certamente dannati» «Non volle essere immerso nel fonte battesimale». Ibidem. Robert Robinson, The history of the baptism, Applewood Books, 2009, p. 118. [14] «Non volle essere immerso nel fonte battesimale» Ibidem.
Con DARWIN e la FISICA QUANTISTICA il mondo ha cominciato a ricevere risposte meno favolistiche , che ci impongono comportamenti sociali nuovi o perlomeno riflessioni nuove sui nostri comportamenti sociali ed in particolare sui doveri sociali che ogni uomo ha verso l'altro uomo In avanti non ci sara' piu' l'attesa del premio o della punizione divina ma dovra' esserci necessariamente una giustizia umana funzionante nel controllo del comportamento sociale
L'orologiaio cieco (titolo originale The Blind Watchmaker: Why the Evidence of Evolution Reveals a Universe Without Design) è un libro di Richard Dawkins, L'orologiaio cieco è un libro originale, pieno di informazioni, paradossi, osservazioni inaspettate; un classico della divulgazione scientifica contemporanea che costituisce la più completa e chiara spiegazione, rivolta al grande pubblico, della teoria dell'evoluzione e della selezione naturale, oltre che una circostanziata difesa del darwinismo dai numerosi attacchi di cui ancora oggi è fatto segno dalla vecchia cultura dei terrapiattisti
L'orologiaio cieco (titolo originale The Blind Watchmaker: Why the Evidence of Evolution Reveals a Universe Without Design) è un libro di Richard Dawkins, Da Wikipedia, l'enciclopedia libera. In questo libro l'autore affronta il tema della complessità del mondo biologico dal punto di vista della moderna biologia evolutiva, spiegando come l'estrema improbabilità legata alle sofisticate configurazioni degli esseri viventi possa trovare una risposta soddisfacente nella corretta conoscenza del funzionamento dei sistemi selettivi secondo logiche darwiniane. Rifacendosi alla celebre analogia dell'orologiaio del filosofo e teologo William Paley, Dawkins la modifica in quella dell'orologiaio cieco, dove l'affascinante varietà e complessità degli organismi diventano una conseguenza inevitabile di processi di selezione naturale che rendono superflua la necessità dell'esistenza di un disegno intenzionale ad opera di un'entità sovrannaturale. Per spiegare il modo in cui si sono sviluppati organi estremamente sofisticati come l'occhio o l'ancor più singolare sistema di ecolocazione ultrasonica del pipistrello, non bastano però meccanismi legati a semplici variazioni casuali, che anche nel caso di tempi lunghissimi, come quelli della vita sulla terra, non risulterebbero minimamente sufficienti al raggiungimento di un tale grado di complessità. Ma un sistema di selezione cumulativa, in cui ad ogni passo i miglioramenti vengono messi alla prova, scartando le soluzioni meno efficienti, è la soluzione che avviene in natura per arrivare a creare ordine dal caos, ottenendo risultati strabilianti, in grado di sfidare le leggi di probabilità. Per simulare questi meccanismi e renderli più semplici da comprendere e visualizzare, l'autore ha quindi sviluppato un semplice programma per computer in grado di creare e modificare strutture bidimensionali ramificate secondo schemi che simulano i meccanismi biologici, compresa la derivazione genetica, in questo caso rappresentata attraverso parametri numerici operanti sulle forme stesse. Questi semplici "biomorfi", selezionati nella loro evoluzione secondo logiche arbitrarie operate dall'autore, sostituitosi in questo all'opera della selezione naturale, hanno mostrato una notevole capacità di ricreare forme di estrema complessità in un numero limitato di passaggi. L'autore prende spunto da questo esperimento per sostenere come l'opera di passaggi piccoli e graduali risulti l'unica via percorribile dal punto di vista evoluzionistico, poiché salti più significativi non potrebbero sfruttare il meccanismo di selezione cumulativa, affidando il successo della mutazione unicamente al caso, rendendo perciò altamente improbabile qualsiasi cambiamento efficiente. Per sostenere questa visione, e per sfatare una delle obiezioni più comuni al meccanismo evolutivo secondo logiche darwiniane, Dawkins mostra come si ritrovino nelle tracce fossili ed in natura innumerevoli esempi di come queste variazioni continue di efficienza si siano prodotte e sviluppate in organi ed esseri viventi. Fatto ulteriormente dimostrato dai numerosi casi di convergenza evolutiva, in cui problemi simili hanno portato specie diverse a sviluppare indipendentemente soluzioni sovrapponibili, come l'ecolocazione di pipistrelli e cetacei, o le molte strategie sociali comuni a formiche e termiti. Il tutto sotto il controllo di una molecola dotata della fondamentale capacità dell'autoreplicazione, il DNA, che tramite la ripetizione di semplici sequenze riesce ad immagazzinare una sbalorditiva quantità di informazioni, le quali a loro volta possono dare vita a strategie per la sopravvivenza di grande raffinatezza e complessità, tra cui gli organismi viventi. Questo grazie a meccanismi di interazione tra geni di tipo collaborativo che nel tempo hanno portato alla creazione di sistemi biologici sempre più complessi, ed alla parallela competizione tra gli organismi biologici stessi, impegnati in una rincorsa senza fine per la sopravvivenza. Nell'ultima parte l'autore si occupa delle teorie che si sono poste come alternative al darwinismo classico, come quella degli equilibri punteggiati, mostrando come in questo caso le supposte differenze siano il frutto di alcuni fraintendimenti e manipolazioni mediatiche, piuttosto che reali differenze nei meccanismi proposti. Riguardo a teorie decisamente in opposizione a quella proposta dal neodarwinismo, come quella di Lamarck, o quella mutazionista, l'autore ne illustra i punti deboli, e come il neo-darwinismo risulti molto più efficace nello spiegare le sorprendenti capacità di adattamento degli organismi all'ambiente.
|
Ci sono in Italia un 15% di agnostici , ed un 65% di cattolici , e la nostra cultura e' del tutto cattolica
Cosi viviamo in una societa' , in cui uomini che non si sposano ci spiegano come vivere , che crede alla piu' innaturale ed astrusa delle cose cioe' in un uomo partorito da una vergine ( sesso come innaturale ! ), alla resurrezione senza aver mai conosciuto nessun risorto, che ha un dio maschio ma ha creato un Olimpo composto di una dea-madre ( la Madonna) piu' venerata di dio e da migliaia di dei minori ( santi e martiri) , crede nei miracoli senza averne mai aver avuto le prove di uno solo , nelle stigmate di padre Pio scomparse alla sua morte, nella liquefazione del sangue di san Gennaro, nei commerci di Lourdes e di Medugorje, nei milioni di reliquie di ossi , di lenzuoli e croci , predica l'amore e pratica sistematicamente la violenza, odia gli ebrei per avergli ucciso dio , crede vagamente allo sterminio di undicimila vergini, alla casa volante di Loreto o di Monte San Savino, ci terrorizzerebbe con i tormenti del purgatorio e dell'inferno se nel frattempo gli uomini non se ne fossero dimenticati,
pueralita' indigeribili digerite solo per paure superstiziose ( non e' vero ma ci credo )
e nessuno piu' vede tutte le falsificazioni storiche che hanno segnato la storia dell'affermazione cattolica come religione di Stato e come raccoglitrice delle beneficenze
Tutte queste persone ( 65%) temono , tutte queste persone sperano
E la cultura tutta la nostra cultura e' stata invasa dalla menzogna piu' puerile
La ricerca della felicita' sancita dalla costituzione americana e' rimandata al regno dei cieli
La giustizia ha due facce quella terrena e quella divina , rimandando a dio la punizione del colpevole , rimandando a dio la giustizia sociale
la realta' e' sgradevole , e' che :
noi viviamo una volta sola , vorremmo rivivere ma non e' possibile
noi non vedremo piu' nostra madre e nostro padre , noi non vedremo piu' i nostri fratelli e le nostre sorelle
Qui in questo nostro mondo e' la nostra unica irripetibile occasione di amore e di felicita'. Non esiste domani
Una speranza falsa come la religione puo' spingerci a rimandare cio' che non e' rimandabile
e ritorniamo al punto da cui siamo partiti :
DUE MOTIVI DEL PERCHE' E' UTILE LA RICERCA GENEALOGICA E FAMILIARE
A : E' NOSTRO DOVERE RICORDARE E FAR RICORDARE I NOSTRI MORTI, ED E' PER LO STESSO PRINCIPIO NOSTRO DIRITTO CHIEDERE AI NOSTRI VIVI DI ESSERE RICORDATI A NOSTRA VOLTA , PER SFUGGIRE AL NULLA INCOMBENTE
B : IL RICORDO E' ESPERIENZA. L'ESPERIENZA DI MIGLIAIA E MIGLIAIA DI VICISSITUDINI UMANE E DOVREBBE POI SERVIRE AD EVITARE AGLI UOMINI DI RIPETERE ERRORI GIA' COMMESSI ED A RIPARTIRE PROPRIO DA QUEGLI ERRORI PER COSTRUIRE UNA VITA MIGLIORE PER TUTTI , EVITANDO I PRIVILEGI E LE RENDITE DI POSIZIONE. qUESTO S'INTENDE PER RICERCA DELLA FELICITA'
Nella Dichiarazione d'indipendenza degli Stati Uniti d'America (4 luglio 1776) leggiamo che «tutti gli uomini sono creati uguali; che essi sono dal Creatore dotati di certi inalienabili diritti, tra questi diritti vi sono la Vita, la Libertà e il perseguimento della Felicità».
Il perseguimento della felicità come diritto inviolabile, costituzionalmente garantito.
Significa che la felicità dei cittadini è qualcosa di cui i Governi devono farsi carico e qualora non siano in grado di garantirla, il popolo (We, the people leggiamo nel Preambolo della Costituzione americana) ha diritto di pretendere un nuovo Governo che organizzi i suoi poteri in una forma che sembri al popolo più adatta ad assicurarla.
Tutta la nostra vita , la vita di ogni animale , di ogni pianta , di ogni microbo infinitesimo ha in se' il germe di una nuova serie di vite
Una catena infinita : noi , quelli che sono venuti , quelli che verranno
la vita e' il trionfo della propagazione della specie
Poi arriva la morte ................
|
DEDICATO A TUTTI I CARNESECCHI
Forse la ricostruzione della storia dei Carnesecchi , a molti , potra' sembrare uno spreco di tempo con l'occuparsi di cose di poca o nessuna importanza e attualita', cose morte , cose passate .......... Ma il passato ,anche quello piu' profondo, anche quello che non abbamo conosciuto, ma di cui solo le nostre cellule conservano la memoria vive nel nostro presente
Vivi il presente , vivi la tua vita ………..acqua passata non macina piu’
Eppure nella vita arriva sempre un momento in cui si cominciano a capire i nostri genitori in cui si comincia a ricordare , a capire i ricordi e a capire che cio' che ci e' stato dato non ci era dovuto , a provare gratitudine verso gli autori dei nostri giorni Un momento in cui l’amore cieco si toglie la benda e diventa un amore riconoscente in cui ci assale la voglia di sapere di piu’ di quella moltitudine di persone che rappresentano il nostro passato e quel tempo in cui non esistevamo ma eravamo nel progetto della natura
Cosi questa ricerca non vuole essere niente di anacronistico , niente di infantile od inutile E’ un bisogno e' riscoprire l'odore della nostra tana , la tana dei nostri primi giorni Vuole essere un modo di ritrovare Nel nome di nostri comuni antenati antichi legami oggi dimenticati E nel medesimo tempo
Vuole essere un modo di conservare la memoria di questi uomini e donne di cui siamo carne e sangue
E col ricordo quasi tenerli in vita
ridare un senso alle loro vite : alle loro sofferenze , alle loro gioie , ai loro errori , ai loro successi, al loro coraggio , alle loro debolezze , ai loro sogni , alle loro paure , alle loro vicende umane
Un modo di combattere la caducita' della vita.
Forse un modo di dare loro il nostro amore postumo di figli e nipoti e pretendere dai nostri figli e nipoti lo stesso amore in nome della stessa ragione
UN UOMO VIVE FINO A QUANDO QUALCUNO NE CONSERVA IL RICORDO
|
Come compagni di un corto viaggio abbiamo dei doveri verso i nostri simili
E piu' ancora verso i nostri padri e madri e fratelli e sorelle
E' uno dei nostri doveri morali trasmettere la memoria
Esaltare il merito, denunciare le sofferenze e le ingiustizie eventualmente patite ,
Lo dobbiamo a tutta la catena di affetti di cui siamo il frutto e di cui aspiriamo ad essere parte in futuro
Provando a creare un mondo dove sia minimizzata la sofferenza
|
GRATITUDINE
|
un uomo puo' distinguersi per le sue azioni fuori dal comune
e puo' essere che le sue azioni diventino note ai piu' e vengano riconosciute , ammirate, invidiate, tramandate
E i suoi figli ?
A che giovano ai figli le azioni dei padri o delle madri ?
il male dell'ereditarieta'

Tempo presente e tempo passato sono entrambi presenti nel tempo futuro....e il tempo futuro è contenuto nel tempo passato" ............T.S. Eliot
Se vogliamo costruire il futuro dobbiamo conoscere esattamente come sono andate le cose nel passato
Solo chi conosce dove e' la buca non vi cade dentro
Come effettuare una ricerca genealogica……………………qualche consiglio esterno
La ricerca genealogica secondo il Portale antenati
La ricerca delle proprie origini e la ricostruzione della propria storia familiare mirano, in primo luogo, a rintracciare le affinità e relazioni parentali.
Ma la ricostruzione del filo genealogico, della tavola degli ascendenti per quarti e dell’albero genealogico di una famiglia non rappresentano che il primo passo per avanzare nella conoscenza dei propri antenati, che diventa più profonda e ravvicinata attraverso la ricerca di documenti che ne testimoniano i modi di vita, il grado di istruzione, i luoghi dove essi hanno abitato e hanno trascorso la loro esistenza, le professioni e i mestieri che hanno esercitato, etc.
Dalle loro storie particolari può scaturire un quadro complesso e articolato della società italiana attraverso le generazioni.
Dunque, da dove partire per rintracciare i propri antenati?
Le fonti indispensabili alla ricerca genealogica sono generalmente di due tipi: quelle private e quelle pubbliche. Tra le prime figurano i ricordi personali (le fonti dirette) e la tradizione orale della propria famiglia (le fonti indirette), ai cui si aggiungono gli archivi di famiglia e di persona; tra le fonti pubbliche, invece, è possibile menzionare lo Stato civile, l’anagrafe, la documentazione militare e gli atti parrocchiali; e, in secondo luogo, anche se meno ricchi di dati genealogici, gli atti notarili, i catasti, le matricole di ordini professionali.
Altre fonti pubbliche dove ricavare dati concernenti singole persone sono i fondi della Questura, Prefettura, Tribunali, degli enti pubblici assistenziali, orfanotrofi, ospedali etc.
In realtà, la ricerca genealogica, come ogni altra ricerca archivistica, ha bisogno di indizi e nessun documento, nemmeno un registro contabile, può dirsi insignificante allorquando possa fornire anche una sola informazione per integrare i nostri dati di partenza oppure una traccia che rinvii ad altri documenti utili per il prosieguo della ricerca.
Ma per cominciare è bene far ricorso innanzitutto alle fonti cosiddette “seriali”, ovvero alle registrazioni e ai documenti prodotti e conservati nel tempo principalmente da uffici pubblici o da strutture ecclesiastiche ed oggi accessibili presso gli Archivi di Stato o altri archivi storici. La ricerca deve prendere le mosse da riferimenti geografici, di tempo e di relazioni parentali (filiazione, fratellanza e matrimonio), per procedere, secondo una regola di carattere generale, necessariamente a ritroso nel tempo.
E quindi, per ricercare i dati anagrafici di un nostro antenato, partendo dalla data da noi conosciuta, generalmente ricavata da un documento o da una notizia in nostro possesso, è consigliabile procedere così:
a partire dalla data del 1° gennaio 1866 in avanti, è opportuno fare ricorso agli atti dello Stato civile o, in alternativa, ai registri parrocchiali, alle fonti militari o ai registri dell’anagrafe o altra documentazione comunale;
dalla data del 31 dicembre 1865 fino ai primi anni del ‘600 è consigliabile effettuare la ricerca sui registri parrocchiali (per alcune aree e in casi particolari le registrazioni parrocchiali sono più antiche e risalgono anche al XIV secolo);
per la documentazione antica, antecedente al XVI secolo, secolo è consigliabile effettuare la ricerca sugli atti notarili e su estimi e catasti; ancora più indietro nel tempo, in linea teorica, è possibile provare a individuare le tracce nei più remoti antenati nei fondi diplomatici degli archivi gentilizi, dei comuni, dei più antichi monasteri e chiese.
FONTI PRIMARIE DI QUALSIASI TIPO [Documenti coevi autentici, Stemmi , Lapidi, epigrafi, diari personali ecc] (controllare l'autenticità e l'attendibilita' )
http://www.iagiforum.info/viewtopic.php?t=2804
FONTI SECONDARIE DI QUALSIASI TIPO (Controllare prima ovviamente la credibilità dell'informatore e dell'informazione)
http://www.iagiforum.info/viewtopic.php?t=2804
La cosa migliore è cominciare a cercare il documento più vicino a noi cronologicamente. In questo caso, ipotizzando che già possiedo i documenti di cui ho scritto la data certa, il documento piu vicino da cercare sarà l'atto di matrimonio di Caio con Caia.
Nella ricerca delle fonti occorre seguire il filo genealogico
Spesso è fuorviante cercare documenti lontani nel tempo se non si possiedono quelli a noi vicini. ( forum IAGI)
recupero dati in casa :
Documenti di Famiglia
Fotografie familiari
Oggetti di famiglia
Ricordi delle persone della tua famiglia
Recupero materiale da parenti e archivi privati
Le fonti bibliografiche
I contatti con famiglie omonime
Archivi privati
Alcune genealogie preesistenti da controllare
ATTI DELLO STATO CIVILE (In Comune richiesta di documenti all’Ufficio Anagrafe. o a volte in copia presso gli Archivi di Stato):
consultazione dello Stato Civile
a) Atti di cittadinanza;
b) Atti di nascita ;
c) Atti di matrimonio;
d) Atti di morte;
e) Scheda anagrafica;
f) Foglio di famiglia;
3) ATTI PARROCCHIALI (In parrocchia o negli archivi diocesani):
a) Atti di battesimo;
b) Atti di matrimonio; e processetti matrimoniali
c) Atti di morte;
d) Atti dei cresimati;
e) Stati delle anime;
tracciare un'albero genealogico da implementare e controllare via via coi nuovi dati
cercare documenti con più informazioni
studio di altri documenti per procedere a ritroso nel tempo e colmare la mancanza di documenti anagrafici
I documenti sull’emigrazione
Le liste di leva i ruoli e i fogli matricolari
Prima guerra mondiale
Seconda Guerra mondiale
Guerre d'Africa
Guerre risorgimentali
Titoli di studio
processi civili e penali
dati su Gazzette Ufficiali
Documenti fiscali tasse di vario tipo a seconda del luogo e degli anni : catasti , dazzaioli. ..............
I protocolli notarili : atti notarili (Presso gli Archivi di Stato)
documenti catastali (Presso gli Archivi di Stato)
Accenni alla Guida generale degli archivi di Stato e ai siti genealogici consultabili online
Da IAGI forum
1) Un motore di ricerca :
es. https://www.google.it/
2) Un sito che dia notizie sulla concentrazione e la diffusione di un cognome in Italia ed all'estero :
es. http://worldnames.publicprofiler.org/
http://www.gens.info/italia/it/
http://www.cognomix.it/mappe-dei-cognomi-italiani/
3) Un sito che dia ampie notizie bibliografiche su una famiglia,un cognome o su un personaggio storico :
es. http://books.google.it/
http://www.treccani.it/enciclopedia/
http://openlibrary.org/
http://archive.org/
https://archive.org/search.php?query=crollalanza
4) Siti per la ricerca anagrafica on line .
http://www.antenati.san.beniculturali.it/
Alcuni consigli utili da Alessio Bruno Bedini forum IAGI
Come faccio ad avere notizie della mia famiglia? Le pergamene delle bancarelle o i fantagenealogisti sono inaffidabili. La cosa migliore e più sicura è iniziare autonomamente una ricerca genealogica. Sicuramente sarà molto lungo e faticoso ma alla fine della ricerca sarete senza dubbio soddisfatti dei vostri risultati e i vostri avi saranno orgogliosi di voi
Sono nobile? In genere chi è nobile lo sa dalla nascita per certo, quindi se la vostra nobiltà è affidata solo a leggende familiari, come "il titolo perso al gioco" o "il titolo venduto" et similia, in genere sono solo storielle simpatiche ma non veritiere. Certo, poi è anche possibile un caso di "nobiltà decaduta" fino a dimenticare le proprie origini ma in genere sono rarissimi. Ricordate, però, che la nobiltà è anzitutto quella interiore dunque non ha senso cercare ad ogni costo di ricongiungere la propria famiglia ad altre famiglie omonime ma che non siano la nostra. Diventereste in questo modo dei meri fantagenealogisti.
Cosa posso cercare per iniziare la mia ricerca genealogica? Comincia seguendo, possibilmente, i punti in questo ordine: Che metodologia seguo? e segnare i documenti da trovare. In questo modo:
Tizio
* 1860 ca.
= 1880 Tizia
+ 1915 ca.
Caio
* 1890 ca.
= 1920 Caia
+ Roma 20.2.1960
Sempronio
* Napoli 08.12.1925
= Roma 05.09.1965 Sempronia
Come reperisco gli atti del comune? Spesso basta una semplice lettera A/R in cui si cita il C.C. art. 450, il DPR 445/2000, il DPR 396/2000, la Legge 241/90, il "Il codice deontologico di buona condotta per i trattamenti di dati personali per scopi storici" del garante della Privacy.
Come reperisco gli atti della parrocchia? Qui le cose sono più complesse poichè non ci sono obblighi per le parrocchie. In genere i parroci non hanno tempo per svolgere per voi le ricerche e occorre quindi svolgerle autonomamente.
A volte capita che i parroci non abbiano tempo nemmeno per farle svolgere a voi o non vedano di buon occhio le ricerche genealogiche. In questi casi occorre agire con intelligenza e “diplomazia”. I consiglio è di:
1) Farsi presentare al parroco da una persona di sua fiducia;
2) Avere magari qualche conoscenza nella curia;
3) Farsi presentare come uno studioso serio e appassionato;
4) Essere generoso con il parroco e fare un offerta in denaro [magari faglielo sapere in anticipo tramite il tuo "contatto" in maniera discreta prima di conoscerlo]. Un modo simpatico di lasciare un buon ricordo al parroco potrebbe essere ad esempio anche quello di portare una bottiglia di vino ... di solito è ben accetta;
5) Essere sempre gentile ed educato;
Come reperisco gli atti dell'Archivio di Stato? Qui la cosa è ancora più complessa. Nei protocolli notarili, specie antichi, spesso occorre sfogliare i libri o i "bastardelli" pagina per pagina per trovare atti dei propri avi e documenti utili per la ricerca. Ovviamente serve molto tempo e molta pazienza.
Un buon manuale di genealogia on line formulato dal dr Claudio De Dominicis
L'opera e' datata 1990 e risente della situazione a quel tempo
ma contiene alcune perle concettuali e quindi va letta
Lineamenti di scienza genealogica manuale di genealogia del dr Claudio De Dominicis
la presentazione e' del prof Luigi Borgia , importante esperto di araldica
alcuni punti salienti :
la presentazione e' del prof Luigi Borgia , importante esperto di araldica
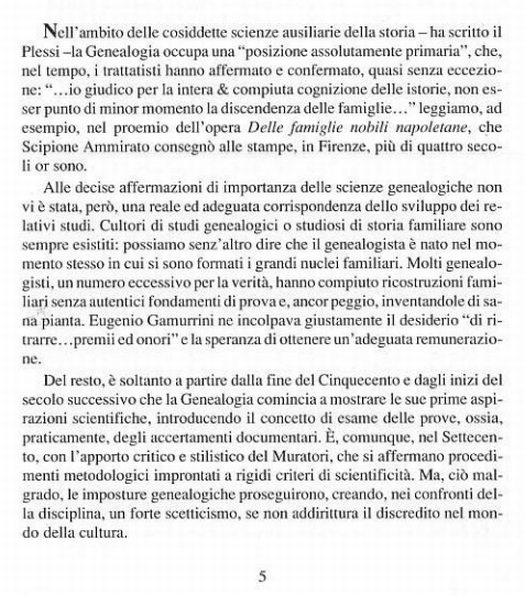
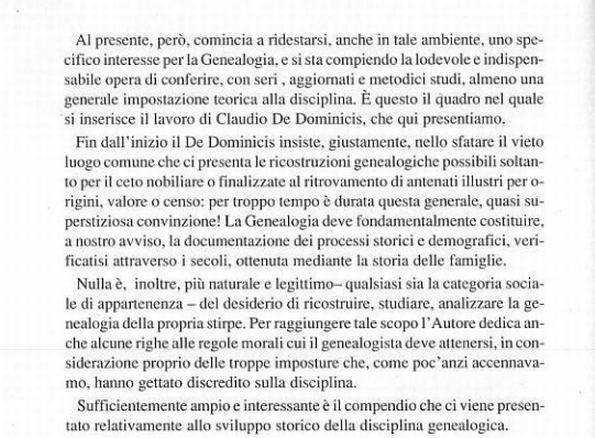
l'opera
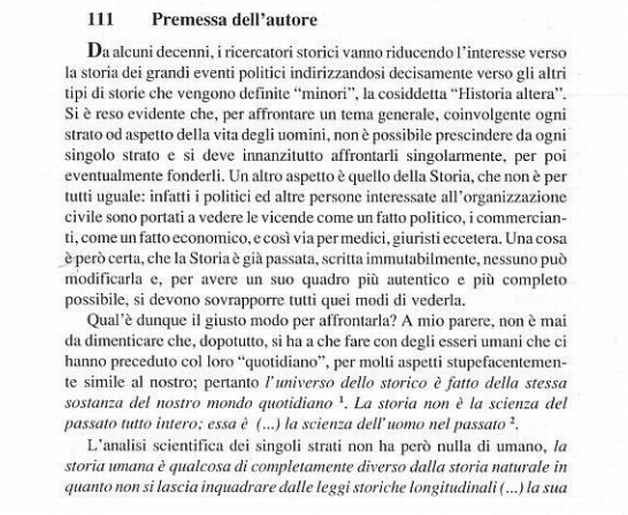
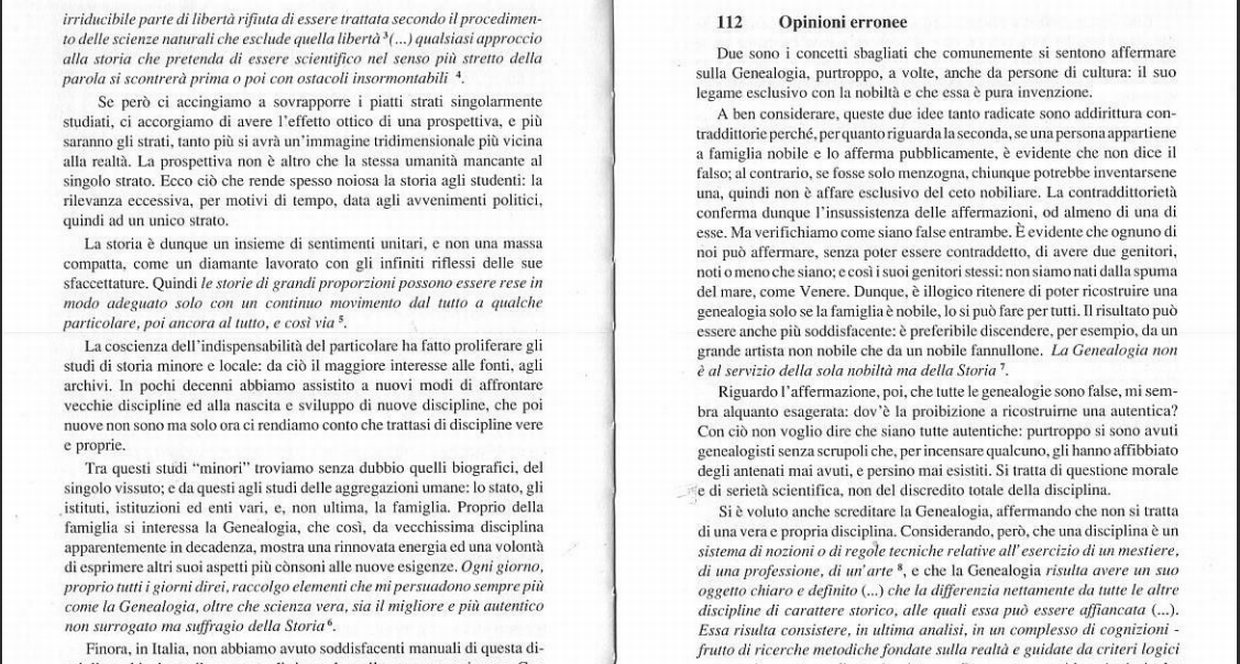

ALCUNE NOTE ULTERIORI
Atti di successione. Gli atti di successione sono atti giudiziari che mostrano come i beni (la proprietà) di una persona deceduta era divisa agli eredi. Spesso i testamenti elencano le donazioni di proprietà a coniugi, figli e altri parenti. I documenti amministrativi riportano il nome delle persone (spesso il coniuge vivente o il figlio maggiore) che devono eseguire il testamento. Spesso gli atti di successione non elencano tutti i figli, e quelli che sono già morti o hanno ricevuto la propria eredità non sono nominati. Inoltre, il coniuge vivente può non essere il genitore di alcuno dei figli nominati.
Atti catastali. Gli atti catastali, come i depositi e le ipoteche, possono essere usati per verificare i movimenti di una persona o di una famiglia. A volte gli atti catastali dichiarano i rapporti di parentela, come nel caso in cui marito e moglie sono entrambi i proprietari di un unico terreno o nel caso in cui una persona vende un terreno a un familiare. In altri casi tali rapporti di parentela non sono dichiarati, ma possono essere dedotti. Gli atti catastali possono altresì fornire indizi sulla situazione finanziaria, sul vicinato, sui soci in affari e sui nomi completi.
Documenti militari. I documenti militari di maggior valore per la ricerca della storia familiare sono le domande di pensione scritte dai soldati o dai rispettivi coniugi viventi. Le informazioni contenute nei documenti militari includono la data di nascita, quella di matrimonio, l’età al momento dell’arruolamento, il reggimento, la descrizione fisica (come il colore dei capelli, quello degli occhi, l’altezza e i segni particolari), le campagne militari e le battaglie, le disabilità provocate dal servizio militare, le testimonianze dei contemporanei, il luogo di residenza della persona e, a volte, il nome e la data di nascita degli eredi.
Documenti di censimento. Negli ultimi duecento anni o più, molti governi hanno compilato documenti di censimento. Spesso i primi censimenti riportano solo il capofamiglia e contengono il nome, il sesso, il luogo di nascita e l’età approssimativa dei componenti della famiglia. Quelli più recenti includono informazioni più complete.
Quando usi i documenti di censimento fai attenzione perché forniscono solo una vaga indicazione della famiglia. Di seguito trovi alcune avvertenze da tenere a mente quando consulti i documenti di censimento:
I componenti del nucleo familiare potrebbero non essere inclusi nel censimento se non erano in casa quando si è svolto.
I censimenti non includono i membri deceduti della famiglia.
La moglie elencata nel censimento potrebbe non essere la madre di eventuali figli.
A volte i parenti e gli ospiti sono elencati come figli.
Le informazioni possono essere state fornite dai vicini o approssimate da chi ha svolto il censimento.
I nomi potrebbero essere stati scritti in una miriade di modi diversi.
L’età è spesso arrotondata, e il luogo di nascita è spesso approssimato.
Registri di immigrazione. Le compagnie marittime hanno tenuto a lungo registri dei passeggeri che viaggiavano da un paese all’altro. Agli inizi del 1800 i paesi hanno cominciato a tenere elenchi degli arrivi (gli elenchi degli immigranti che sbarcavano sulle loro coste). Molti di questi documenti sono stati compilati in libri e in formato elettronico. I registri di immigrazione possono riportare il nome, l’età, la professione, il luogo di origine, il porto di imbarco (partenza) della persona e altre informazioni.
Documenti della naturalizzazione. I documenti della naturalizzazione includono le dichiarazioni d’intenti (in cui l’immigrante rinuncia alla fedeltà a un altro paese), le richieste di cittadinanza e le deposizioni (testimonianze rese nei tribunali, facevano parte della richiesta di cittadinanza). Le informazioni comprendono l’età del richiedente, i cambiamenti apportati al nome, il luogo di nascita, il porto di sbarco (arrivo), lo stato civile e l’indirizzo postale. In periodi diversi, la naturalizzazione può essere stata gestita a livello locale o nazionale. Per esempio, negli Stati Uniti, in origine i documenti di naturalizzazione erano elaborati da diversi tribunali federali, statali e di contea. Nel 1906 il Servizio di immigrazione e naturalizzazione degli Stati Uniti ha iniziato a mantenere un indice delle naturalizzazioni, allegando copie di documenti importanti per ogni caso.
Accanto a questa documentazione di tipo anagrafico, un’altra fonte importante conservata negli Archivi di Stato è la documentazione militare. Essa è costituita, in particolare, da tre tipologie:
Liste di Leva
Liste di estrazione
Ruoli Matricolari
Le Liste di leva erano compilate ogni anno su base anagrafica dai Comuni e contenevano l’elenco alfabetico di tutta la popolazione maschile residente che raggiungeva l’età della visita per la leva militare. I modelli ottocenteschi sono di grande formato e sono suddivisi in 21 colonne, nelle quali venivano riportati partendo dal margine sinistro il numero d’ordine dell’iscritto, il suo cognome e nome, il nome del padre e della madre, la data e il luogo di nascita e il luogo di residenza, la professione propria e del padre e varie altre indicazioni relative a questa prima compilazione della lista da parte dell’autorità comunale. Nelle colonne dell’altra facciata venivano indicati dal Commissario di Leva la verificazione definitiva della lista, il numero d’ordine al tempo della chiusura della lista, il numero di estrazione, la descrizione dell’aspetto fisico e le decisioni del primo esame e nelle ultime colonne i risultati riportati dal Consiglio di Leva ossia se abile, inabile, rinviato a successiva leva o renitente; l’arruolamento con data e iscrizione alla categoria ed infine la data di partenza ed il distretto militare, il corpo di assegnazione o riformato. Il modello di registro adottato nel 1911 introdusse informazioni relative al grado d’istruzione e quello prescritto nel 1940 assunse un formato più piccolo strutturato in una sola facciata di formato A4 circa dove i dati sono riportati su 4 colonne.
Le Liste di estrazione erano compilate per mandamento - non per comune - in quanto svolgevano effettivo servizio militare quanti, in base al numero estratto, rientravano nel contingente, cioè nella quantità di uomini richiesta al mandamento. La procedura di estrazione, utilizzato fino al 1911 (classe 1890), anno in cui le liste furono abolite, era giustificato dall'impossibilità da parte dello Stato di sostenere l'arruolamento di tutti i cittadini idonei.
I Ruoli matricolari sono registri suddivisi per classe, rilegati per ordine di matricola, tenuti e compilati dai Distretti militari in cui venivano registrati tutti i servizi resi allo Stato dal singolo militare durante la sua permanenza nei ruoli. I dati venivano riportati in una sola facciata. In alto veniva indicato il numero identificativo del militare, detto “matricola” e la classe di appartenenza. A sinistra venivano indicati i dati anagrafici, la descrizione dell’aspetto fisico, la professione, il grado d’istruzione e altre informazioni descrittive personali. Al centro i dati relativi all’arruolamento, servizi, promozioni ed altre variazioni matricolari con accanto la data corrispondente.
Inoltre, vi era una sezione dove venivano indicate le campagne ed azioni di guerra, le decorazioni, gli encomi, le ferite o le mutilazioni in guerra o in servizio. Oltre alla tenuta dei registri, i Distretti militari istruivano per ogni singolo soldato un fascicolo matricolare, nel quale veniva inserita la documentazione ufficiale inerente al servizio militare. I fascicoli matricolari offrono, quindi, informazioni più complete rispetto ai ruoli matricolari, che ne costituiscono la sintesi. Essi sono articolati in due sezioni: truppa e sottufficiali. Per poter avviare una ricerca nei fogli matricolari si deve partire dal cognome e nome della persona, individuati nelle rubriche alfabetiche divise per anno relativo all’anno di nascita. Qui si ricaverà il numero di matricola e con esso si potrà accedere alla relativa pagina del registro dei Ruoli matricolari o al fascicolo personale.
Altre fonti molto importanti conservate negli Archivi di Stato sono gli archivi notarili, che contengono anche molti documenti relativi all’ambito delle relazioni familiari. Ad esempio, emancipazione dei figli, patti matrimoniali, donazioni e testamenti; gli archivi relativi al catasto; gli archivi di provenienza privata acquisiti tramite acquisti o donazioni relativi ad archivi gentilizi o di famiglia e di persona; gli archivi di molte istituzioni pubbliche come per esempio le Prefetture, le Questure, dove si possono anche trovare documenti che riguardano l’emigrazione, i Tribunali o gli enti di assistenza e beneficenza, i cui archivi confluiscono negli Archivi di Stato competenti per territorio.

CONSIDERAZIONI DI ARALDICA
by don Antonio Pompili forum IAGI
Leggo in rete di persone - anche studi araldici e artisti (pittori) - che possono creare ex novo uno stemma personalizzato. Volevo sapere: si può fare? Far creare ex novo uno stemma sia con elmi e piume da borghese, pur non essendo appunto di nobile stirpe o comunque non facente parte di alcun ordine cavalleresco. Una volta fatto, mi è stato detto che è possibile fare un deposito araldico presso un notaio od avere una certificazione presso il Cronista d'Arme di Castilla y Leon.
Quanto poi al possesso di uno stemma, alla sua creazione e al suo uso, mi permetto di aggiungere una considerazione.
Premesso che, come già detto, chiunque - una persona, una famiglia o un più ampio gruppo collettivo - può dotarsi di uno stemma, nelle Associazioni che fanno capo a questo forum è chiaro un concetto: ciò che fa la differenza è l'uso di uno stemma, che cioè questo uso sia pubblico o piuttosto privato.
Chiunque può crearsi uno stemma e farne l'uso che vuole, e privatamente usarlo sulla carta da lettere, o su un servizio di piatti, o su mobile, ecc... ma perché uno stemma abbia valore pubblico è necessario che sia riconosciuto da un'autorità araldica pubblica (il che poi significa necessariamente autorità araldica di Stato). Certamente se qualcuno che non ne sia già dotato si crea uno stemma, non sarà tenuto a ottenerne una certificazione. Ma il suo stemma resterà privato e - per quanto magari sarà composto secondo le regole e le consuetudini del blasone e avrà dunque l'aspetto di uno stemma e di fatto lo sarà - non essendo stato riconosciuto da un'autorità competente nel suo contenuto araldico, non potrà avere lo stesso valore di un emblema di cui invece sia stato riconosciuto il contenuto araldico (e laddove esiste, il contenuto nobiliare).
Quanto ai due casi citati sopra, premesso che nella Repubblica Italiana può essere richiesta la concessione di stemmi solo da parte di enti (ad esempio città e comuni, banche, fondazioni, università...), per un cittadino italiano oggi non è (più) possibile il riconoscimento del proprio stemma mediante una certificazione d'arme spagnola (è stato possibile sino alla fine del 2005 attraverso l'ultimo Cronista de Armas del Regno di Spagna); mentre il ricorso al notaio può configurarsi soltanto come il deposito di una data, quella di inizio dell'uso fattivo del proprio stemma, ma non come riconoscimento ufficiale del contenuto araldico di questo.
.....................................
Infine vorrei dire che sono d'accordo sul fatto che chiunque potrebbe provare a realizzarsi il proprio stemma in autonomia, senza ricorrere a "esperti" di araldica e di disegno araldico. Ma vorrei dire che un bravo - a livello di tecnica e stile - disegnatore araldico non necessariamente è sempre un vero "araldista", il quale soltanto può avere la competenza per condurre alla realizzazione di uno stemma che corrisponda davvero al più autentico spirito araldico. Per questo, se già alcuni "studi araldici" e "artisti" rischiano di realizzare o portare alla realizzazione di stemmi scadenti, questo pericolo può essere ancora più forte per chi, magari mosso dalle migliori intenzioni e da buona volontà, non ha concezione neanche minima di cosa sia l'araldica e di come debba esser composto e rappresentato uno stemma
by don Antonio Pompili forum IAGI
Noi viviamo in un mondo d'immagini e di disegni
Un mondo che permette di vedere , di confrontare con un click
L'occhio legge
E' da rilevare come l'esecuzione di uno stemma sia sempre libera e dipenda dall'interpretazione dell'artista o artigiano per cui raramente poi l'occhio vede ( pur a fronte di una medesima blasonatura ) una stessa cosa

Ed anche altrove come spesso un bandato o un capo bandato diventi con facilita' nell'esecuzione un troncato
Cosa a cui i nostri antichi non davano importanza piu' del dovuto
L'alfabeto o arte del blasonare potrebbe parere non aver quindi piu' significato in questo nostro mondo contemporaneo dove e' cosi facile "vedere"
il blasonare conserva invece una una funzione importante proprio nel mondo dell'intelligenza artificiale
Permette di indicizzare facilitando la ricerca e l'abbinamento tra stemma e casata
|
IN GENERALE OCCORRE DUBITARE DEGLI STEMMARI QUANDO NON SONO DOCUMENTATI DA MANUFATTI COEVI NON TUTTI GLI STEMMI CONTENUTI IN UNO STEMMARIO E' DETTO CHE SIANO CORRETTAMENTE ATTRIBUITI AGLI ERUDITI CAPITAVA DI BARARE , DANDO AD INTENDERE DI CONOSCERE CIO' CHE IN REALTA' NON CONOSCEVANO, O TALVOLTA COMUNQUE DI SBAGLIARSI IN BUONA FEDE L'ABITUDINE A NON METTERE IN DISCUSSIONE QUANTO DETTO IN PASSATO HA TRASMESSO ALL'OGGI TUTTA UNA SERIE DI COSE FALSE ANCHE ARALDICHE
Tutti gli stemmari non documentati lasciano ovviamente dei dubbi In Toscana ne esistono molti di questi stemmari. Per l'uso dei Prioristi a famiglie Queste raccolte di stemmi talvolta troppo complete e talvolta assolutamente non documentate. Dal Monaldi in poi fanno pensare che alcuni stemmi possano esser parto della fantasia del realizzatore che intendeva trasmettere al lettore quel senso di completezza dell'opera di cui abbiamo parlato Pure il Benvenuti ed il Mariani ( antiquari ai loro tempi insigni ) cadono in errori sicuramente involontari ma in nome della loro autorita' questi errori continuano a circolare ai giorni nostri , in una sorta di catena di sant'Antonio
La comparazione degli stemmi Iacopi e Veneri mi ha spinto a pensare che in definitiva noi abbiamo ancora cose da chiarire sugli stemmi antichi , e che accettiamo molte cose per scontate E mi e’ venuto quel dubbio che alcuni ( pochi o molti ) stemmi contenuti in alcuni stemmari possano esser fasulli cioe’ inventati dall’autore IN MALAFEDE o erroneamente attribuiti in BUONAFEDE e tramandati di voce in voce sino ai giorni nostri senza manufatti in grado di validarli
Senza uno studio specifico suffragato da fonti primarie non si possono mai trarre conclusioni sui legami genealogici dovuti al possedere uno stesso cognome o apparentemente uno stesso stemma Utilizzare, io credo, l'araldica ha senso solo per stemmari che facciano riferimento a manufatti esistenti o fotografati ( vedi la metodologia del Ceramelli Papiani ) Gli stemmari che raccolgono una lunga serie di stemmi , senza citare come si e' pervenuti alla loro assegnazione , non danno aprioristicamente certezze di verita' Sono raccolte di figurine e basta Utili, perche' sono utili costituendo un punto di partenza ( la stessa cosa che si disse per i Crollalanza , i Litta , ecc ) ,ma che in molte affermazioni debbono esser sottoposti sempre a verifica Gli araldisti del passato non amavano il vuoto e cosi come inventavano uno stemma per re Artu' o per Carlo Magno spesso assegnavano a famiglie omonime di luoghi diversi uno stesso stemma Solo in presenza di manufatti araldici possiamo avere maggiori certezze Anche qui bisogna stare attenti alla vanita' umana che l'omonimia del cognome spinge ad inalberare talvolta uno stemma uguale a quello di una famiglia piu' famosa per fondare una parentela inesistente Detto questo pero' una famiglia mercantile nelle dinamiche medioevali e rinascimentali puo' aver benissimo messo radici in luoghi anche molto distanti dal Comune di origine , in Italia come in Europa I nostri antenati non avevano l'aereo ma si muovevano in maniera stupefacentemente rapida e percorrevano distanze enormi per lavoro La conclusione e' sempre la medesima : nella ricostruzione della storia familiare non vi e' nulla che possa essere escluso , ma tutto deve essere dimostrato a mezzo documentazione I vecchi studi sulle famiglie per la maggior parte ubbidiscono a schemi mentali superati, gli alberi genealogici debbono essere controllati Un lavoro difficile I cognomi italiani sono oltre 350.000 Quasi di nessuno nemmeno dei piu' famosi e' mai stato fatto uno studio esaustivo , che abbia esaminato tutti i rami omonimi o no , notabili o no , ricchi o poveri Io ho provato a iniziare un simile studio per il mio cognome paterno
|
|
ARALDICA ITALIANA
Credo che raccogliere fotografie di stemmi sia importante Probabilmente fra qualche anno qualcuno di questi stemmi non esistera’ piu’ e solo queste foto lo testimonieranno Queste pietre sono la documentazione piu' esposta alla distruzione Eccone un esempio :
Questa pagina web e' quindi anche un modo di conservarne il ricordo Un peccato mortale questa distruzione di parte della nostra storia : dovrebbero essere tracce irrinunciabili e talvolta sono documenti unici , utili a tante cose come vedremo nel caso dei Carnesecchi Purtroppo non vi e' molta sensibilita' sull'argomento e quello che peggio una sorta di rassegnazione a vederli scomparire senza far nulla per evitarlo
UN VIAGGIO DALL'INDIVIDUALE AL COLLETTIVO ALL'INDIVIDUALE E AL CAMBIO DI SIGNIFICATO
Come si passa dallo scudo individuale allo scudo familiare ? Come lo scudo familiare sia effettivamente uno strumento difensivo in battaglia o lo sia solo in torneo ? Cioe' come si riconoscevano in battaglia i cavalieri amici dai cavalieri nemici ?
Lo scudo e' un elemento difensivo da sempre forse dalla prima guerra tribale Il mondo romano L'esercito romano lo aveva fatto divenire parte dell'uniforme del soldato In questo far parte di un uniforme aveva perso quasi ogni propensione all'individualita'
disegno by Wikipedia
La rovina della civilta' romana sara' probabilmente occorsa in moltissimo tempo , un lento degrado, ma il risultato sociale e culturale e' catastrofico Si apre un'immensa voragine che inghiotte cultura , filosofia, societa' , diritto, gusto artistico, commercio , ricchezza, e riporta il mondo indietro di secoli
Col disfacimento del mondo romano mancano fonti sufficienti a seguire le sorti dello scudo mancando di sculture , mosaici , pitture , arazzi , manufatti ceramici, ............... Insieme al commercio e alla ricchezza vi e' un crollo della manifattura e forse delle specializzazioni dei popoli stanziali .....................................
Siamo di fronte ad un mondo diverso che vede la creazione abbastanza assurda del mondo feudale caratterizzata da una marcata mancanza di controllo del territorio da parte del potere centrale Potere centrale , che come un qualunque potere mafioso basato sulla violenza e sulla prepotenza, e' costretto ad affidare il controllo a signorotti locali che lo esercitano con la forza e con cui crea un complesso rapporto di fidelitas Questo potere centrale vive in simbiosi con la Chiesa cattolica ( che e' fondamentalmente la detentrice della cultura ) molto piu' di quanto appaia e nonostante i molti contrasti a volte anche violentissimi e apparentemente insanabili
( E sempre e' la Chiesa a portare avanti l'opera di conciliazione : consapevole che lo scontro porterebbe alla rovina di entrambi i contendenti , fino al punto da fare alla lunga dell'avversario il piu' forte: ed allora l'equilibrio sara' rotto definitivamente e la Chiesa scomparira' lentamente dalla storia). Ma questo e' un altro discorso
SCUDO DECORATO NON SCUDO ARALDICO
queste immagini ci portano intorno ai secoli XI e XII ai popoli del nord ed ad un loro scudo da guerra molto primitivo e rozzamente decorato a seconda di un gusto personale Gli avvenimenti intorno alla battaglia di Hastings raccontati con un tappetto intessuto lungo originariamente circa 80 metri ARMI...............................ARMI e Arazzo di Bayeux. ARMI...............................ARMI e Arazzo di Bayeux.
Da uno scudo da guerra decorato a seconda di un gusto personale si passa allo scudo araldico Dallo scudo araldico individuale ad uno scudo araldico di un gruppo e di un gruppo parentale
Il periodo che va dall' 800 al 1050 e' un periodo dove non esiste la storia familiare se non per quegli alti dignitari che si contendono il potere Il potere centrale non e' in grado d'imporre il rispetto della funzione pubblica e cosi assistiamo alla trasformazione del potere pubblico in potere personale e signorile Probabilmente quella sorta di ordine burocratico feudale diventa di fatto anarchia feudale che continua ad evidenziare una presunta piramide di comando basata solo su una sorta di fedelta' vasallatica ma che rivela un controllo del territorio completamente parcellizzato Un signore una terra piu' o meno vasta.......................... Un signore una sua insegna , un gruppetto di uomini cioe' una sorta di bravi , che tengono sottomesso al signore quella terra e che usano l'insegna del signore C'e' nell'ordine burocratico feudale una sorta di potere mafioso come evidenzia giustamente Barbero
Cessando le invasioni degli Ungari, dei normanni , dei Saraceni ( mezzo X secolo ) si apre un mondo che ritorna a una quasi normalita' Vi e' un mondo che e' cresciuto nelle citta' italiane e che timidamente continua a crescere Di fatto il periodo di Matilde (1046-1115) vede un cambiamento epocale Sotto la guida dei Vescovi si e' mantenuta e si prepara a riemergere una classe dirigente cittadina Il sorgere dei Comuni al centro-nord dell'Italia fa rinascere barlumi di quella civilta' romana cosi lontana nell'inbarbarimento generale dei costumi
LO SCUDO ARALDICO
NASCITA DELL'ARALDICA IN EUROPA
PASTOREAU ......................................un vecchio studio sulle origini dell'araldica
Forum IAGI..........................................Origini araldica
è forse con quest'immagine che iniziamo a parlare di araldica: É il celeberrimo cosiddetto smalto di Le Mans, oggi conservato al museo Tessé dell'omonima località francese, pregevole prodotto di arte orafa effigiante a colori Goffredo d'Angiò il Plantageneto, in vesti belliche e con scudo decorato. Anzi, con quello che è conosciuto come il primo stemma della storia. Goffredo morì nel 1151: questa stupenda placchetta venne realizzata in smalti di Limoges a cavallo di quell'anno. Sicuramente vi sono altri "ornamenti dello scudo" più antichi dello "Smalto di Le Mans". Ad esempio l'arazzo di Bayeux, ma gli scudi venivano già ornati dai greci, dai romani (forse meno), dalle popolazioni barbariche... già Omero ci parla dello scudo di Achille. Ma erano semplici ornamenti o identificavano il proprietario in senso araldico? Erano ornamenti diciamo così "codificati ed ereditari"? Erano assolutamente personali, o comunque non trasmessi ereditariamente né consuetudinariamente, o comunque non blasonabili.Differenze piccole, ma sostanziali rispetto agli stemmi come li intendiamo oggi.
Goffredo d'Angiò detto il Bello o Plantageneto, in francese Geoffroy V d'Anjou dit le Bel ou Plantagenêt (Angers, 24 agosto 1113 – Château-du-Loir, 7 settembre 1151) chi meglio di lui che era uso per distinguersi ornare l'elmo con rami fioriti di ginestra
Torno sul testo che citavo più sopra. "Le origini simboliche del blasone. L'ermetismo nell'arte araldica" di R. Vief, F. Cadet de Gassicourt, Du Roure de Paulin, ed. Arkeios. Lo "Smalto di Le Mans", lastra tombale di Goffredo Plantageneto, viene indicato come "inizio di elaborazione delle strutture araldiche". Perchè "inizio"? Perchè, citando dal testo, "... nessun dubbio che alle armi araldiche di Goffredo Plantageneto manchino ancora due tratti essenziali: la canonizzazione e l'ereditarietà.... lo "Smalto di Le Mans" va a prendere posto a fianco dei sigilli prearaldici, dei quali il più bell'esempio ci è dato dalla ceralacca di Guglielmo di Gloucester. Esso si pone ugualmente al fianco di certi capitelli romanici di tipo zoomorfo". Ma, prosegue, ancora il testo, né i sigilli né altri simili simboli ORNANO UNO SCUDO. La prima rappresentazione per così dire non casuale di "simboli su uno scudo" è lo "Smalto di Le Mans". Non si può ancora parlare di araldica nella sua pienezza, poiché "...non era stata ancora raggiunta quella canonizzazione e... le figure non erano ancora ereditarie.... nessuno dei figli di Goffredo riprenderà le insegne del padre: Enrico II porterà verosimilmente due leoni passanti e Guglielmo, figlio naturale di Goffredo, si armerà verso il 1156-1163 di un leone rampante..... Tuttavia, sulla tomba di un nipote di Goffredo (Guglielmo Lunga Spada, conte di Salisburgo, figlio bastardo di Enrico II), ritroveremo i sei leoncelli del nonno. E dopo di loro, tutti i membri di questa famiglia porteranno d'azzurro a sei leoncelli d'oro. Dunque, anche se lo "Smalto di Le Mans" non ha ancora di per sé il carattere di vera e propria arme araldica, è tuttavia al limite e sul punto di diventare molto rapidamente, negli anni a venire, canonizzato ed ereditario". .............................. cioè che è solo con lo "Smalto di Le Mans" che cominciamo a parlare ( cominciamo a parlare ) di araldica. Avanti a questo ci troviamo di fronte semplici ornamenti che non identificavano il proprietario in senso araldico. Erano ornamenti diciamo così "non codificati e non ereditari" Cioe' erano ornamenti assolutamente personali, o comunque non trasmessi ereditariamente né consuetudinariamente, o comunque non blasonabili. Differenze piccole, ma sostanziali rispetto agli stemmi come li intendiamo oggi. Uno scudo decorato non e' uno scudo araldico. altrimenti dovremmo parlare di araldica da sempre occorre ubbidisca ad una codificazione ( che giustifichi il mestiere dell'araldo) e diventi qualcosa di ereditario
Per mia visione della storia di famiglia come microstoria alla cui luce occorre verificare la macriostoria dei regni pero' lo stemma diventa importante quando diventa ereditario ed inizia a seguire e a segnare la storia familiare , cosicche' le sue vicende s'intrecciano con la storia familiare
L'araldica ha un importante valore storico: E' molto probabile che proprio la diffusione dell'araldica in Italia abbia favorito la formazione dei primi cognomi moderni tra le famiglie dei "milites" ( la cognomizzazione e' un fatto cittadino ) Lo stemma viene cosi a rappresentare il logo di un gruppo parentale. Che si raduna cosi sotto un comune simbolo e sotto una comune denominazione. Il simbolo grafico ha una forza particolare nella societa' analfabeta di mezzo secolo XII Cognome e stemma sono dirompenti politicamente all'interno delle citta' , contrastano il valore disgregante del sistema patronimico fino ad allora vigente, aiutano a creare la tradizione familiare
L'araldica ha un importante valore identificativo Al cognome Rossi ( per citare uno dei piu' comuni dei circa 350.000 cognomi italiani ), quanto al cognome xxxxx scarsamente diffuso io posso associare normalmente piu' alberi genealogici . Lo stemma aggiunge un ulteriore elemento al modo di identificare e distinguere
L'araldica ha un'importante valore documentario Talvolta lo stemma e' fonte primaria d'informazioni, permettendo di fare datazioni , trarre conclusioni sulle vicende familiari, talvolta di avere informazioni genealogiche, .
DATAZIONE DELLA NASCITA DELL'ARALDICA IN ITALIA : MOLTI STUDIOSI HANNO TUTTORA DI CIO' UNA CONVINZIONE SBAGLIATA
Rimasero ingannati nel 1300 Dante Alighieri , Giovanni Villani , Ricordano Malispini. ........... E molti appassionati ed anche studiosi oggi cadono nel medesimo errore
Hannelore Zug Tucci Istituzioni araldiche e paraldiche nella vita toscana del duecento ................ Le istituzioni araldiche traggono origine , come sappiamo
bene , nel mondo feudale. E poiche’ si disputa
se il loro centro d’irradiazione debba considerarsi l’Inghilterra degli
ultimi re normanni oppure la Francia degli stessi anni ( tra i numerosi contributi
che affrontano questi problemi , ci limitiamo a rinviare ai piu’ notevoli
apporti recenti : R. Viel , Les origines symboliques du blason , Parigi , 1972
; G.J. Brault , Early Blason Oxford 1972 ;H.
Pinoteau , Origine et diffusione de l’eraldique capetienne in corso di
stampa negli atti del Colloque de l’Accademie
internazionale d’heraldique 5-9
ottobre 1981 ; M.Pastoureau, Histoire des theories ayant tente’ d’espliquer
l’origine des armoiries (xii-xx siecle ) ibidem ) ,questo implica che la Toscana
, e l’Italia in genere , restino in posizione periferica e in ogni caso
passiva. Da cio’ deriva
che ogni attribuzione di armi a personaggi vissuti in epoche precedenti alla
prima meta’del xii secolo appartiene all’araldica fantastica , come e’ il caso notissimo della <<bell’insegna del gran barone
>>, l’arma << addogata bianca e rossa >> di Ugo il Grande di
Tuscia , dalla quale si fanno discendere le armi di alcune casate fiorentine.
Per quanto legittimata dall’autorita’
di Dante, essa deve ritenersi immaginaria. L’indiscussa preminenza anglo-normanna e francese che in
Toscana fa del sistema araldico un prodotto d’importazione , esclude dunque che
si possano collocare qui i problemi delle origini. Si tratta invece di
determinare perche’ le istituzioni feudali come le araldiche si siano
trapiantate in un contesto diverso e possano essere state recepite dalle
strutture comunali…….. Da Istituzioni araldiche e paraldiche nella vita toscana
del duecento Di Hannelore Zug Tucci Nobilta’ e ceti dirigenti in Toscana nei secoli xi-xiii : strutture e concetti -- Convegno Firenze 12 dicembre 1981
Si l'usage de l'héraldique est attesté pour la première fois à Rome par le portrait que commandèrent Scoto et Giovanni Paparone à Sainte-Marie-Majeure dans les dernières années du XII (fig. 13), c'est seulement vers les années 70-80 du siècle suivant que les tèmoignages de sont usage public se multiplient de manière systématique. A partir de cette époque, les barons et quelques familles prééminent de la cité se reconnaissent dans leur propre écu et l'utilisent systématiquement, le plaçant partout où cela est possible …
Fonte: Emiliano Bultrini, Ostentation et contrôle : l'héraldique à Rome entre monnayage et territoire (XIII-XIV siècles) in Héraldique et numismatique III. Moyen âge Temps moderns, sous la direction d'Yvan Loskoutoff, Mont-Saint-Aignan, Presses universitaires de Rouen et du Havre, 2015, p. 29
FISSATO QUESTO PALETTO DELL'ARALDICA COME PRODOTTO D'IMPORTAZIONE E D'IMITAZIONE DI CIO' CHE ACCADEVA OLTRE LE ALPI Possiamo dire che l'araldica nasce inizialmente come appannaggio dei "MILITES" cioe' di coloro che combattevano a cavallo . Cioe' quella forza allora determinante nel combattimento anche perche' allenata al maneggio delle armi Nasce in ambiente militare ed il segno distintivo ha come collocazione naturale lo scudo e quindi successivamente lo scudo sara' la base e l'elemento contenitivo del segno o stemma Nasce questo marchio per distinguere l'uomo che celato dentro l'armatura era altrimente indistinguibile ed ammirarne il valore e l'abilita' nel maneggio delle armi Molto probabilmente viene usato nei tornei e nell'allenamento alle armi Puo essere che venga usato dal milites anche nel combattimento reale ma e' meno probabile , in combattimento dovendo essere ben individuato dai balestrieri , dai pedites , dai milites amici senza correre il rischio di essere scambiato e ucciso per nemico nella foga del combattimento , e' molto probabile vi fosse una sorta di divisa comune
L'italia e' la Nazione che io chiamo delle "centro patrie" perche' diversa di luogo in luogo e di tempo in tempo per istituzioni ,leggi , abitudini , usi ,........................... Per cui e' difficile stabilire delle regole comuni Il Piemonte a contatto con la Francia L'area veneta a contatto con l'impero Romano d'oriente ----Bisanzio I Comuni del centro-nord in cui si sviluppa una civilta' del tutto particolare di Citta'-Stato ( civilta' comunale ) con caratteristiche particolarissime e che si diversificheranno col passare del tempo facendo della Toscana un mondo a parte Il patrimonio di San Pietro che inizialmente sviluppa una civilta' assai simile alla societa' comunale del centro-nord Il Regno Napoletano La Sicilia sottoposta ai Normanni e poi agli Svevi con una cultura propria fatta dall'integrazione di tante civilta' , e poi aragonese ed spagnola Corsica con una propria cultura Sardegna con una propria cultura Costa dalmata con una cultura veneta QUINDI A QUESTE DIFFERENZE TALVOLTA MOLTO PROFONDE OCCORRE PRESTARE SEMPRE ATTENZIONE PRELIMINARMENTE
La civilta' comunale del cento-nord italiano a cui la Toscana appartiene con una sua identita' peculiare, balza all'occhio di Ottone ( 1152-1190 ) e lo lascia perplesso e lo stupisce
.....considerazioni di Ottone vescovo di Frisinga e di Raevino (1115 ca.- 1158), zio di Federico I Barbarossa (1152-1190), sorpreso dalle forme di controllo che i comuni cittadini esercitavano sui …diocesanos…suos… compresi i grandi signori e feudatari, i domini loci I Latini… imitano ancor oggi la saggezza degli antichi Romani nella struttura delle città e nel governo dello Stato. Essi amano infatti la libertà tanto che, per sfuggire alla prepotenza dell’autorità si reggono con il governo di consoli anziché di signori. Essendovi tra essi tre ceti sociali, cioè quello dei grandi feudatari, dei valvassori e della plebe, per contenerne le ambizioni eleggono i predetti consoli non da uno solo di questi ordini, ma da tutti, e perché non si lascino prendere dalla libidine del potere, li cambiano quasi ogni anno. Ne viene che, essendo la terra suddivisa fra le città, ciascuna di esse costringe quanti abitano nella diocesi a stare dalla sua parte, ed a stento si può trovare in tutto il territorio qualche nobile o qualche personaggio importante che non obbedisca agli ordini delle città. Esse hanno preso anche l’abitudine di indicare questi territori come loro “comitati”, e per non mancare di mezzi con cui contenere i loro vicini, non disdegnano di elevare alla condizione di cavaliere e ai più alti uffici giovani di bassa condizione e addirittura artigiani praticanti spregevoli arti meccaniche che le altre genti tengono lontano come la peste dagli uffici più onorevoli e liberali. Ne viene che esse sono di gran lunga superiore a tutte le città del mondo per ricchezza e potenza. A tal fine si avvantaggiano non solo, come si è detto, per la saggezza delle loro istituzioni, ma anche per l’assenza dei sovrani, che abitualmente rimangono al di là delle Alpi
PAOLO GRILLO : Cavalieri, cittadini e comune consolare
Quando il Palais du Beaubourg di Renzo Piano fu costruito, per la sua dirompente carica innovativa venne immediatamente paragonato a un’astronave atterrata nel centro di Parigi. La stessa immagine credo si possa efficacemente utilizzare per illustrare l’effetto dell’apparizione del libro di Jean-Claude Maire Vigueur Cavalieri e cittadini, pubblicato nel 2003 in Francese e prontamente tradotto in Italiano nell’anno successivo,1 nel mondo della storiografia comunale italiana. Si tratta infatti di un’opera profondamente originale, un volume di quasi 550 pagine incentrato sul primo secolo e mezzo di vita comunale apparso in un momento in cui la quasi totalità delle ricerche si incentrava sui decenni a cavallo fra Due e Trecento. Soprattutto, Cavalieri e cittadini presentava una tesi interpretativa forte e innovativa,
Jean-Claude Maire Vigueur definisce la figura del MILITES nella civilta' comunale e lo descrive fuori degli schemi feudali , come un uomo sufficientemente ricco da potersi permettere di mantenere un cavallo da guerra e di comperare un armatura Con questa descrizione apparentemente banale apre ad un mondo fatto di mercanti , armatori , banchieri , artigiani che spiegano le parole di Vescovo Ottone
Maria Elena Cortese ha successivamente studiato il controllo del territorio da parte delle famiglie con modo di vita feudale ed ha documentato la loro presenza a Firenze fino alla morte di Matilde di Toscana ( 1115 ) e il loro successivo abbandono della citta' rinserrandosi nei loro possessi feudali desti nati a sgretolarsi sotto l'avanzata dell'esercito comunale
IN ITALIA COMUNQUE LO STEMMA E' QUASI SEMPRE UNO STEMMA FAMILIARE E QUASI MAI INDIVIDUALE ED E' QUASI INESISTENTE L'USO DELLE BRISURE E qui vengo corretto da Maurizio Carlo Alberto Gorra (Académie internationale d’héraldique) .............L'Italia storica, non soltanto medievale, ne fece uso frequente e in ogni stato che la componeva. Il problema è che si tratta di tematica poco studiata dai nostri araldisti, e spesso limitandosi alle brisure dei Savoia (tuttora in uso). Per dirti: solo i Sanseverino ebbero almeno una dozzina di brisure per le varianti di stemma da essi usati nei diversi feudi campani, lucani e calabresi, ulteriormente ampliati per il ramo insediatosi in Lombardia.
FONDAMENTALE : OGGI E' EVIDENTE UNA COSA CHE LA CULTURA NOBILIARE AVEVA COMPLETAMENTE OSCURATO : ...........Gli stemmi, al contrario di quanto solitamente si tende a credere, non sono appannaggio della nobiltà cavalleresca; dalla fine del XII secolo erano comunemente usati anche da artigiani, contadini, città ........................ Questo un esempio : http://www.iagiforum.info/viewtopic.php?f=1&t=23539&p=255101&hilit=stemmario#p255101
la grande importanza dello stemma nelle consuetudini della gente fiorentina del trecento e' messa in luce dalla novella 63 di FRANCO SACCHETTI nel suo TRECENTONOVELLE del 1399 dove si vede la considerazione verso lo stemma familiare ( forse ancor piu' del cognome ) all'interno della societa' fiorentina anche per gente che allora , allora , saliva la scala sociale
IN TOSCANA IL COGNOME ( O NOME FAMILIARE ) INIZIA AD AFFERMARSI INTORNO AL 1150 ( VEDI SU QUESTO SITO ) E RIGUARDERA' INIZIALMENTE POCHISSIME FAMIGLIE E TUTTE DEL CETO DIRIGENTE --MILITES ( LA SUA DIFFUSIONE NEGLI ALTRI STRATTI DELLA POPOLAZIONE SARA' POI UN PROCESSO MOLTO MOLTO LENTO E GRADUALE E SPESSO COLLEGATO AL FORMARSI DI UN NUOVO CETO DIRIGENTE ) . PER QUESTE POCHE FAMIGLIE DI MILITES IL SIMBOLO GRAFICO ( STEMMA ) STIMOLERA' L'AFFERMAZIONE DEL COGNOME E IL PARZIALE SUPERAMENTO DEL SISTEMA PATRONIMICO Teniamo in conto che: La societa' di fine secolo XII e' una societa' prevalentemente analfabeta in cui l'impatto dell'immagine e' molto forte Una famiglia nell'albero genealogico ha individui piu' conosciuti e altri meno conosciuti. Il segno grafico in comune li accorpa ed il numero nel secolo XII e XIII e' forza politica
ANCORA OGGI CONOSCIAMO IL PASSATO CON UNA PARTE DI VERITA' ED UNA PARTE DI MENZOGNA MOLTE DELLE NOSTRE CONOSCENZE ERRATE SONO DOVUTE ALLA MASSICCIA ALTERAZIONE DEL PASSATO DA PARTE DEL CETO NOBILIARE DEI SECOLI XVI_XVII_ED ANCORA XVIII ( MA IN MINOR MISURA )
Non si puo' prescindere da un inquadramento del periodo storico 1150 --1220
FIRENZE : IDEE PIU' CHIARE SU UN PERIODO STORICO POCO CONOSCIUTO CHE VEDE L'AFFERMAZIONE DELL'ARALDICA E DEL COGNOME rafforzando i legami familiari e aumentando cosi la forza delle famiglie dominanti
Per aver le idee piu' chiare su un periodo nebuloso come quello del XI e XII secolo fiorentino invito a leggere un libro che mi ha lasciato una vivissima impressione
Enrico Faini, Firenzenell’età romanica (1000-1211). L’espansione urbana, lo sviluppo istituzionale, il rapporto con il territorio ,Firenze, 2010.
Alle opere del Davidson , del Villari , del Santini , della De Rosa che hanno aperto la pista allo studio dei primordi fiorentini va io credo aggiunta l'opera di Enrico Faini
Infatti importantissimi direi irrinunciabili per un'amante della storia sono gli attuali studi del dottor Enrico Faini
Trovo insomma alta la capacita' del dr Faini di esaminare i manoscritti sotto molte angolature di utilizzarne e padroneggiarne le sfaccettature e di farne emergere molti dettagli nascosti di scrutarli , di compararli in modo da trarne conclusioni che vanno ben oltre il singolo documento ma aprono ad una visione d'insieme di aprire al lettore scenari che vanno oltre le tradizionali convinzioni
Sembra molto strano la visione che si aveva di un combattimento medioevale come una sorta di carnevalata in cui ciascuno si vestiva a modo suo Un avvenimento in cui si poteva morire e' una cosa seria Una battaglia medioevale con milites ( cavalieri ) , pedites , balestrieri , arcieri ..............la prima cosa che doveva proporre era il riconoscere e distinguere prontamente l'amico dal nemico Le immagini sottostanti sono un trionfo di colori e di araldica ma e' praticamente impossibile siano state vere
Bisognava che in combattimento un combattente se ucciso almeno venisse ucciso dai suoi una considerazione di buon senso , non poteva davvero pretendersi che un pedites conoscesse a menadito gli stemmi delle casate Non si poteva rischiare che un pedites ( o anche un milites, un arciere , un balestriere ..... ) uccidesse uno dei suoi semplicemente perche' nella foga del combattimento non ne riconoscesse le insegne .Quindi l'esercito doveva avere una sua insegna o delle sue insegne da tutti facilmente riconoscibili nella foga della battaglia Questo non toglie che il cavaliere potesse portare in battaglia uno scudo che lo distinguesse ma insieme a una sorta di uniforme Sicuramente gli scudi personali (inizialmente) o familiari venivano usati nei tornei e successivamente come una sorta di logo sociale individuale o familiare
Si tratta di una formella di un fregio più ampio, generalmente attribuito al XIII secolo, un tempo conservato sulla facciata di una casa in Via XX Settembre a Sansepolcro, l'antica Via Maestra, a fianco di una torre, oggi molto ridotta in altezza. Il fregio venne portato nella Pinacoteca Comunale (oggi Museo Civico) approssimativamente un'ottantina di anni fa, forse tra la fine degli anni '30 e i primi anni '40. by dr Andrea Czortek
In questa rappresentazione successiva ( e quindi di fantasia) della battaglia di Benevento vediamo gli eserciti presentare un uniforme ed uno scudo
FALSE INFORMAZIONI SUI COGNOMI FIORENTINI
False informazioni che ci vengono da quei cronisti che ci sembrano dover essere i piu' degni di fede
C'e' una contradizione tra i documenti che conserviamo e gli antichi cronisti fiorentini Villani , Malispini danno lunghe elencazioni di cognomi di famiglie di primo cerchio Nei documenti conservati quelli che possiamo considerare cognomi compaiono in realta' solo intorno alle prime decadi del duecento
Purtroppo anche alcuni storici "moderni" continuano a utilizzare i cognomi (in modo improprio ) per individui che ancora non avevano il cognome che avranno solo i loro discendenti E questo genera confusione Occorrerebbe far seguire "(attribuito)" al cognome ancora inesistente
come nascono e quando i primi cognomi Il cognome e lo stemma
da Nuova Cronica Giovanni Villani
Come Currado primo fu fatto imperadore. Dopo la morte d'Arrigo primo imperadore fu eletto e consegrato Currado primo per Benedetto papa ottavo negli anni di Cristo MXV. Questi fu di Soavia, e regnò nello 'mperio XX anni, e quando egli passò in Italia, non possendo avere la signoria di Melano, sì·ll'assediò infino ne' borghi; ma prendendo la corona del ferro di fuori di Melano in una chiesa, cantando la messa, sì venne uno grande tuono e saetta in quella chiesa, e alquanti ne morirono; e levato l'arcivescovo che cantava la messa dall'altare, disse a Currado imperadore che visibilemente vide santo Ambruogio che fortemente il minacciava se non si partisse dall'assedio di Melano; e egli per quella amonizione si levò da oste, e fece pace co' Melanesi. Questi fu giusto uomo, e fece molte leggi, e tenne lo 'mperio in pace lungo tempo. Bene andò in Calavra contro a' Saracini ch'erano venuti a guastare il paese, e co·lloro combattéo, e con grande spargimento di sangue de' Cristiani gli cacciò e conquise. Questo Currado si dilettò assai della stanza della città di Firenze quando era in Toscana, e molto l'avanzò, e più cittadini di Firenze si feciono cavalieri di sua mano e furono al suo servigio. E acciò che si sappia chi erano i nobili e possenti cittadini in quegli tempi nella città di Firenze, brievemente ne faremo menzione.X De' nobili ch'erano nella città di Firenze al tempo del detto imperadore Currado: prima di quegli d'intorno al Duomo Come adietro è fatta menzione, la prima reedificazione della picciola Firenze era divisa per quartieri, cioè per quattro porte; e acciò che noi possiamo meglio dichiarire i nobili legnaggi e case che a' detti tempi, disfatta Fiesole, erano in Firenze grandi di podere, sì gli conteremo per gli quartieri ove abitavano. E prima quegli della porta del Duomo, che fu il primo ovile e stazzo della rifatta Firenze, e dove tutti i nobili cittadini di Firenze la domenica facieno riparo e usanza di cittadinanza intorno al Duomo, e ivi si faceano tutti i matrimoni e paci, e ogni grandezza e solennità di Comune: e appresso porta San Piero, e poi porta San Brancazio, e porta Sante Marie. E porte del Duomo erano abitanti il legnaggio de' filii Giovanni, e quegli de' filii Guineldi, che furono i primi che reedificarono la città di Firenze, onde poi sono discesi molti lignaggi di nobili in Mugello e in Valdarno e in città assai, che oggi sono popolari e quasi venuti a fine: furono i Barucci che stavano da Santa Maria Maggiore, che oggi sono venuti meno; bene furono di loro legnaggio gli Scali e' Palermini. Erano ancora nel detto quartiere Arrigucci, e' Sizii, e' figliuoli della Tosa. Questi della Tosa furono uno legnaggio co' Bisdomini, e padroni e difenditori del vescovado; ma partissi uno di loro da' suoi di porta San Piero, e tolse per moglie una donna chiamata la Tosa, che n'ebbe lo retaggio, onde dirivò quello nome. Eravi quelli della Pressa che stavano tra' Chiavaiuoli, gentili uomini. XI Delle case de' nobili del quartiere di porta San Piero. Nel quartiere di porta San Piero erano i Bisdomini che, come di sopra è detto, e' sono padroni del vescovado, e gli Alberighi, che fu loro la chiesa di Santa Maria Alberighi da casa i Donati, e oggi non n'è nullo; i Ravignani furono molto grandi, e abitavano in sulla porta San Piero, che furono poi le case de' conti Guidi, e poi de' Cerchi, e di loro per donna nacquero tutti i conti Guidi, come adietro è fatta menzione, della figliuola del buono messere Bellincione Berti: a' nostri dì è venuto tutto meno quello legnaggio. I Galligari, e Chiarmontesi, e Ardinghi che abitano in Orto San Michele, erano molto antichi; e simile i Giuochi che oggi sono popolani, che abitavano da Santa Margherita; Elisei che simile sono oggi popolani, che stanno presso a Mercato Vecchio; e in quello luogo abitavano i Caponsacchi, che furono grandi Fiesolani; i Donati, overo Calfucci, che tutti furono uno legnaggio, ma i Calfucci vennoro meno; e quegli della Bella di San Martino anche divenuti popolani; e il legnaggio degli Adimari i quali furono stratti di casa i Cosi, che oggi abitano in Porta Rossa, e Santa Maria Nipotecosa feciono eglino; e bene che sieno oggi il maggiore legnaggio di quello sesto e di Firenze, non furono però in quelli tempi de' più antichi. XII Di quegli del quartiere di porta San Brancazio. Nel quartiere della porta di San Brancazio erano grandissimi e potenti la casa de' Lamberti, nati per loro antichi della Magna; gli Ughi furono antichissimi, i quali edificarono Santa Maria Ughi, e tutto il poggio di Montughi fu loro, e oggi sono spenti; i Catellini furono antichissimi, e oggi non n'è ricordo: dicesi che' figliuoli Tieri per bastardo nati fossono di loro lignaggio; i Pigli gentili uomini e grandi in quegli tempi, Soldanieri, e Vecchietti; molto antichi furono quegli dell'Arca, e oggi sono spenti; e' Migliorelli, che oggi sono niente; e' Trinciavelli da Mosciano furono assai antichi. XIII Di quegli del grande quartiere di porta Santa Maria e di San Piero Scheraggio. Nel quartiere della porta Sante Marie, ch'è oggi nel sesto di San Piero Scheraggio, e quello di Borgo, avea molto possenti e antichi legnaggi. I maggiori erano gli Uberti, nati e venuto il loro antico della Magna, che abitavano ov'è oggi la piazza de' priori e 'l palagio del popolo; i Fifanti, detti Bogolesi, abitavano in sul canto di porte Sante Marie, e' Galli, Cappiardi, Guidi, e Filippi che oggi sono niente allora erano grandi e possenti, abitavano in Mercato Nuovo; e simile i Greci, che fu loro tutto il borgo de' Greci, oggi sono finiti e spenti, salvo che n'ha in Bologna di loro legnaggio; Ormanni che abitavano ov'è oggi il detto palagio del popolo, e chiamansi oggi Foraboschi. E dietro a San Piero Scheraggio, ove sono oggi le case de' figliuoli Petri, furono quegli della Pera, overo Peruzza, e per loro nome la postierla che ivi era si chiamava porta Peruzza: alcuno dice che' Peruzzi che sono oggi furono stratti di quello legnaggio, ma non l'affermo. I Sacchetti che abitano nel Garbo furono molto antichi; intorno a Mercato Nuovo erano grandi i Bostichi, e quegli della Sannella, e Giandonati, e Infangati; in borgo Santo Appostolo erano grandi Gualterotti e Importuni, che oggi sono popolani; i Bondelmonti erano nobili e antichi cittadini in contado, e Montebuoni fu loro castello, e più altri in Valdigrieve; prima si puosono Oltrarno, e poi tornarono in Borgo. I Pulci, e' conti da Gangalandi, Ciuffagni, e Nerli d'Oltrarno furono ad un tempo grandi e possenti con Giandonati e con quegli della Bella insieme nomati di sopra; e dal marchese Ugo che fece la Badia di Firenze ebbono l'arme e la cavalleria, imperciò che intorno a·llui furono molto grandi. XIV Come in quegli tempi era poco abitato Oltrarno. Avemo nomati i nobili e possenti cittadini che a' tempi dello imperadore Currado primo erano di rinnomea e di stato in Firenze; altri più legnaggi v'avea di più piccolo affare che non se ne facea rinnomea, e oggi sono fatti grandi e possenti; e degli antichi nomati di sopra sono calati, e tali venuti meno, che a' nostri dì apena n'è ricorso se non per questa nostra cronica. Oltrarno nonn-avea in quegli tempi gente di lignaggio né di rinnomo, però che, come avemo detto addietro, e' nonn-era della città antica, ma borghi abitati di vili e minute genti. Lasceremo ora di raccontare de' fatti di Firenze infino che fia tempo e luogo, quando i Fiorentini cominciarono a mostrare loro potenzia, e diremo brievemente degl'imperadori che furono dopo Currado primo, e della contessa Mattelda, e di Ruberto Guiscardo che conquistò in quegli tempi Puglia e Cicilia, che di raccontare di tutti ci è di nicessità per le mutazioni che n'avennero in Italia e poi alla nostra città di Firenze.
Da Ricordano Malespini
Imprima la schiatta ,overo famiglia degli Uberti ne dissi adietro che sono nobili di progenia , e di nobilta' , e puosonsi fra santo Piero Scheraggio , e la chiesa di santo Romolo, e tra detti Uberti , e san Piero Scheraggio erono gli Ormanni detti Foraboschi , e tra il detto san Piero , e santa Cecilia si puosono i Malespini miei consorti , e allandare in verso santo Michele in orto alla mano mancha si puosono i Giugialferri, e i Tebalducci , tutte e tre queste ischiatte furono istratti d'uno lignaggio di ceppo : e allato a detti Tebalducci si puosono i Combiobbesi , poi seguitando alla detta mano ad andare in verso Calimara si puosono i Chiaramontesi , e guadagnuoli , e Malpilli , e i Romaldelli , tutti questi sopradetti di progenia maschulina istratti per anticho e al volgere su per la detta piaza , e la detta mano si puosono gli Abati antichi merchatanti , e Macci ancora antichi merchatanti, e a ritornare su per la detta piaza in verso il Garbo si puosono i Galigai in sulla detta piazza , e anchora nella via dietro al detto Garbo , che al partire della detta piazza va in verso santo Martino , ancora erono i detti Galigai , e per la detta via che viene d'orto san Michele , nel detto Garbo erano le case dei Buonaguisi dirimpetto a Compiobbesi, e Tebalducci alla detta mano mancha allo partire della detta piazaetto san Michele in Orto , e alla rivolta del detto Garbo alla detta mano allato a Buonaguisi erano gli Alepri , e quegli Dellapressa, andare in verso san Martino erono i Giugni : questi sopraminati quatro famiglie tutte furono istratti di progenia maschulina di Lisghai detti Ghaligai per anthico , ed etiandio quegli Dellapressa sopradetti nella detta via , e furono consorti dei detti Galigai . e furono d'uno lato i detti Buonaguisi , e quelli dellapressa , e si divisono da Galicai imprima assai che gli altri sopranominati , e poi all'andaresu per lo Garbo alla detta mano mancha erono i Sacchetti cioe' all'andare verso santo Appolinare , e poi all'andare in sue verso dove fa il Parlagio fu per la via detta oggi Anguillaia , si puosono gli Schelmi, e poi ditro alloro nella via del Borgo de Greci si puosono i detti Greci , i quali prima stavono in Terma ; e piu oltre per la via di san Pulinari ad andare in verso Arno si puosono i Magalotti , e al voggere in verso la mano diritra all'andare inverso santo Romolo ,o' nverso le case dei detti Uberti si puosono quegli che oggi si chiamava Del Belculaccio , e dirimpetto alloro si puosono que'dell'Asino che oggi sono ispenti al tempo di me Ricordano , e furono consorti di progenia maschulina con quegli Delbelculaccio : dietro a detti Ormanni si puosono i Manieri , e quelli Della Pera , e anche sono ispenti di miei di : poi vi vennono i figliuoli Petri , i quali furono richissimi merchatanti , poi all'andare inverso santo Romeo si puosono i Guidalotti del migliaccio : piu' oltre i Bagnesi , e que d'Aquona , che vennono di contado antichi gentili huomini , e di linea maschulina furono consorti con gli da Voghogniano , e di quegli che oggi si chiamono da Chastiglionchio , e dietro a santa Cicilia tral Merchato Nuoovo , e la detta Chiesa si puosono gl'Infangati , o vero Mangiatroi , e in Vachereccia si puosono i Baroncelli , e vennono da Baroncello , e poi all'andare inverso santa Maria si puosono i Fifanti detti Bogolesi , e in porta santa Maria erano i Galli che gia aveano un poggio allatoa santo Miniato a monte , che si chiamava il poggio dei Galli , e toglievanvi per antico passaggio allato a Galli erono Capiardi , e Filippi : erono nella via di Terma gli Scholari consorti abanticho di linea maschulina de Bundelmonti , e poi vivennono i Buondelmonti , i quali vennano di contado come adietro s'e' detto , e monte Buoni era loro , e toglievanvi passaggio abantico : nella detta via erono Tiniozzi , e piu altre , e Guidi , elle loro case teneano in fino in borgo santo Apostolo, e infino a santa Maria sopra porta , in borgo sopradetto erono i Gualterotti , e Importuni , e presso a santa Trinita erono gli Schali , e i Palermini , questi , e i Barucci da santa Maria maggiore e furono consorti di linea maschulina , presso a costoro si puosono i Conti di Gangalandi , e di loro abbiamo detto adietro: allato alloro i Ciuffagni e ancora presso a santa Trinita erano i Soldanieri , e i Petriboni , e i detti Petriboni vennono di contado dalle Petrobone , in Portarossa si puosono i Cosi consorti ab antico degli Adimari di linea maschulina , e feciono fare santa Maria Nipotecosa che ancora oggi ritiene il nome e al volgere i chiassi di Portarossa ad andare in verso santo Miniato tra le torri si puosono i Pigli, e gli Erri , i quali furono consorti di linea maschulina poi ad andare p la via di Merchato vecchio a s.Pancratio si puosono i Manfredi Vecchietti , e Migliorelli e gl' Ughi stavono dietro a costoro , dove oggi e' ancora santa Maria Ughi , e p loro fu chiamata cosi , po che la feciono fare abanticho . I Benvenuti furono allato a Vecchietti . I Tornaquinci stavono in capo della via giubasso .Dei Cipriani abbian detto . Poi ad andare da s.Piero Buonconsiglio verso santa Maria in Canpidoglio erono gl'Alfieri , gl Arrigucci che vennono da Fiesole difenditori del detto Vescovado di Fiesole , e Pegolotti. Furono antichi ancora i Canigiani , e pero innanzi vi vennono i Brunelleschi , e ancora i Corbizzi vennono da Fiesole , e da santa Maria maggiore erono que Del beccato . Toschi , e Galluzzi si puosono in Merchato vecchio.Palermini e Barucci dicemo adietro . Quegli della Bella si puosono in santo Martino , e al Fraschato , e vennono poi que della Tosa consorti di linea maschulina dei Bisdomini , i quali furono padroni , e difenditori del Vescovado di Fiorenza , e per la via che viene da san Tommaso al Vescovado si posono gl' Ubaldini che acquistarono per lo cardinale Attaviano tenute e chastella assai che le compero il detto Cardinale . Allato alloro erano Agolanti :apresso alloro i Toschi , inporta del duomo erono i Figiovanni : e loro , e Firidolfi , e Fighineldi , e Chattani da Barberino di Mugello , e Ferrantini furono consorti di progenia maschulina queste cinque sopradette famiglie , e poi come adietro dicemo divisi di nomi , e d'armi si come dissi adietro d'altre famiglie i Bisdomini si puosono presso a s. Liberata , e santo Benedetto presso a porta s Piero , e presso a loro i Tedaldini , Donati , Ravignani , e da santa Margherita , e ivi allato si puosono Buonizi , e a presso a santo Martino i Razzanti venuti da Fiesole , e presso alloro gli Alberighi anche parte arota de Corbizi si puose nel detto porta san Piero, poi a ritornare verso Merchato vecchio si puosono gli Adimari , piu oltre erono i Lisei , poi al volgere verso Chalimara i Caponsacchi antichi Fiesolani , e presso a santo Andrea i Catellini detti da Castiglione di figliuoli Tieri .Questi figliuoli Tieri discesono de Catellini d'uno bastardo. Poi verso santa Maria sopra porta , e presso a santo Andrea i Lamberti , e da casa loro si chiamava il Dado de Lamberti . E dove oggi si chiama Chiasso di ferro dietro a Lisei si puosono i Tebaldi detti quelli della Vitella , e que da Filicaia furono loro consorti di linea maschulina , in Merchato nuovo si puosono i Giandonati , e Boschi , e que Della Zanella e gli Uccellini , e que Dell'Archa , e Pesci : e questi Pesci furono antichi merchatanti .Poi nella via di Porta santa Maria erono i Girolami consorti di linea maschulina del beato messer san Zanobi , il quale fu vescovo della nostra citta' di Fiorenza Piu' oltre verso santo Stefano si puosono gli Amidei , e Gherardini , e e vennono di Valdisieve , o vero di Montefavoso: e presso alloro i Pulci , questi furono ricchi ,e potentissimi chatanti , e questi erono tra santo Stefano , e santo Piero Scheraggio, e Borgo santo Appostolo . Gli Ardinghi Obriachi stavono presso gli Amidei .Gli Amieri abantico stavono da santa Maria maggiore , poi per innanzi vennano in merchato vecchio , e le case dove oggi sono furono de Nerli antichi gentili huomini .I Guicci stavono presso alla Badia di Fiorenza . Vennono di Valdisieve quelli del Forese, e Mazinghi da Campi , e Monaldi stavono tra porta rossa , ella piaza a santa Trinita , e presso a santa Maria Ughi agiugneano le loro case .E questi mazzinghi havean tributo da Pistolesi dua brachetti , e uno sparviere ogni anno per la festa di messer san Iacopo . Gli Erri consorti de Pigli nel detto si puosono in Porta rossa per certe vie strette , e piu e Pigli loro consorti di ceppo .I Pazzi di Fiorenza si puosono presso i Ravignani presso in porta san Piero , e dirimpetto da Ravignani , e p innanzi vennono da Fiesole merchatanti.Gli Agli si puosono presso agli Arrigucci .fra loro e' san Michele Berteldi . E tutte queste sopradette sei famiglie , o vero casati , i quali si puosono in questi sopra nominati luoghi furono antichissimi gentili huomini nella nostra citta di Fiorenza
IMPORTANZA DELL'ARALDICA NELLA FORMAZIONE DEI COGNOMI Quando non esisteva lo stemma e il cognome i gruppi parentali si scindevano con estrema facilita' in famiglie senza piu' tratti che li mettessero in comune : due fratelli potevano dar luogo a gruppi parentali scissi tra loro completamente L'unico sospetto di parentela per i posteri poteva venire dalla contiguita' delle proprieta' e la certezza dall'indagine genealogica Stemma e cognome diventano fattori unificanti del gruppo parentale Stemma e cognome , come visto , non nascono insieme lo stemma nel fiorentino nasce una settantina di anni prima dell'affermazione nei documenti scritti del cognome La prima identificazione e unificazione di un gruppo parentale avviene quindi non attraverso il cognome ma attraverso lo stemma Probabilmente lo stemma e' inizialmente utilizzato sul terreno di battaglia e sono solo le famiglie dei milites comunali ad adottarlo per prime Che poi e’ come dire il ceto dirigente del tempo perche’ rappresentanti principalmente quella parte della popolazione che poteva mantenere cavalli e armamenti Lo stemma aveva quindi il potere di riunire piu' famiglie di discendenza comune sotto un' unica individuazione quando ancora non vi era l'uso del cognome In un gruppo parentale vi erano individui piu' noti ed altri meno noti . La stessa insegna era agli occhi degli altri segno di legami parentali indiscutibili Si entra poi nella fase confusa di affermazione dei cognomi lo stemma e' la brace da cui si sviluppa il fuoco del cognome Lo stemma fa rinascere uno schema mentale dimenticato Vi e' lo stemma , vi e' l'identificazione di un gruppo parentale da parte della gente che a quel gruppo parentale comincia nei discorsi a dare un unico nome facendo riferimento ai piu' conosciuti del gruppo , ai loro antenati , al loro mestiere , al loro luogo di provenienza , a una caratteristica fisica , a un soprannome, ........... Nasce un'identificazione di quel gruppo parentale radunato sotto uno stesso stemma e la voce popolare a quel gruppo assegna un codice identificativo nei discorsi : il cognome Lo stemma in questo momento svolge un azione di supporto al cognome , svolge un'azione importante cioe' aiuta a riunire piu' gruppi parentali aventi un medesimo stemma sotto un medesimo cognome ; gruppi che altrimenti la voce popolare avrebbe disperso in identificazioni diverse Da notare che mentre il cognome ci verra' dato dagli altri lo stemma era qualcosa che un individuo sceglieva quindi lo stemma era qualcosa di piu' personale del cognome Il cognome che entra nel parlato si rivela utile in molte circostanze : rende molte cose piu' semplici Ovviamente uno stemma non puo' sostituire il cognome in un atto notarile............... Aumentando la quantita’ circolante di denaro. Aprendosi l'eta' della proprieta' il cognome ( l'identificazione che ci davano gli altri e che finiamo per far nostra ) diventa indispensabile per tramandare i propri diritti sui beni A questo punto inizia la lenta fase d'identificazione attraverso il cognome ( al catasto del 1427 solo il 36 % delle famiglie fiorentine ha un cognome ),
Come visto a questo punto , quasi sempre lo stesso gruppo parentale era radunato sotto un unico segno e spesso quando si disgregava in cognomi diversi ( per motivi politici , per liti familiari , per fondazione di un nuovo ramo ) tendeva a mantenere il segno modificandolo ma ricordandolo in qualche modo rivendicando gli antenati e la storia Come nel caso della famiglia Adimari
Un eccezione famosa e' quella della famiglia Alessandri di Firenze Nel 1372 Alessandro e Bartolomeo degli Albizi per sottrarsi alla pressione del periodo storico vollero distaccarsi dai loro parenti mutando stemma e adottando un cognome patronimico : lo stemma e' legato all'appartenenza all'Arte della Lana Alessandri : Sono un ramo della famiglia Albizzi: nel 1372 Alessandro e Bartolomeo di Niccolò degli Albizzi vollero 'farsi di Popolo', mutando stemma e adottando un cognome patronimico: lo stemma è legato all'appartenenza dei due all'Arte della lana. Nell'esemplare del 1° tipo, posto sulla facciata del Palazzo Pretorio di Anghiari e appartenente a Lorenzo degli Alessandri (1517), l'agnello è sormontato da una lucertola piegata a cerchio; in realtà i discendenti di Antonio di Alessandro Alessandri adottarono un serpente attortigliato in ricordo della concessione da parte dell'imperatore Sigismondo di Lussemburgo dell'Ordine Militare del Drago nel 1413 circa. Il capo dell'Impero d'Oriente fu concesso dall'imperatore Giovanni Paleologo nel 1439, durante il Concilio di Firenze a Niccolò Alessandri, gonfaloniere di Compagnia; il capo di Leone X fu concesso dal pontefice ai componenti della Signoria fiorentina nel 1515, al momento del suo ingresso in città. La corona con le foglie di palma fu concessione di Giacomo di Borbone-La Marche, marito della regina di Napoli Giovanna II, nel 1415.
La situazione degli Alessandri va inquadrata nel periodo storico e nell'affermazione di idee politiche in forte contrasto col resto della consorteria
Non si possono dimenticare nella differenziazione con stemmi diversi di un medesimo gruppo familiare le liste di proscrizione per le famiglie ghibelline e le liste di proscrizione anti magnatizie che videro specie a Firenze famiglie rinunciare al cognome e allo stemma per differenziarsi dalle opinioni politiche di parenti irriducibili
vedi studio Michael Pastoureau Strategies heraldiques et changements d'armoiries chez les magnats florentins du XIV siecle
vedi studio Michael Pastoureau e Klapisch - Zuber Parente' et identite' : un dossier florentin du XIV siecle
Ovviamente stemmi uguali in luoghi diversi e distanti tra loro non danno alcuna prova di legami parentali Infatti per quanto siano infinite le combinazioni si trovano facilmente blasoni uguali slegati da qualunque legame parentale talvolta anche in luoghi contigui
http://www.comune.siena.it/main.asp?id=5176 Stemma anonimoN.22 CollocazioneCancelleria di Biccherna (uffici del Sindaco):Rutilio Manetti " Episodio della vita di S.Vittore" (1636 c.a), (P.Terra)BlasonaturaScudo accartocciato:
che sembra essere assai simile allo stemma degli Anchioni di Firenze ma che sicuramente non ha nulla a che fare con loro
PRESUPPONENDO UN LEGAME PARENTALE ( ANCORA DA DIMOSTRARE ) TRA I CARNESECCHI FIORENTINI , I DURANTI DI NESE , I CASTELLANI : Il caso dei Carnesecchi fiorentini e' emblematico di un' altra realta' come vedremo , una realta' pero' comune con altre famiglie del ceto dirigente trecentesco e quattrocentesco ( vedi gli ALTOVITI e i loro parenti differenziatisi nel corso del duecento ) Famiglie che emergono dal buio in un periodo posteriore al 1200 quando cioe' era gia' entrato in uso nel ceto dirigente sia lo stemma che il cognome Famiglie che hanno un passato che si perde nell'anonimato delle famiglie del proletariato fiorentino di fine secolo XII e che ancora nel XIII secolo usano il patronimico Carnesecchi fiorentini, Duranti di Nese , e forse Castellani fiorentini ( ???) avevano molto probabilmente origini comuni nel castelvecchio di Cascia nel Reggello La fortuna politica arrise loro in tempi diversi e forse non avendo un passato comune illustre da ricordare o forse perche' oramai avevano perso completamente i legami parentali iniziali si differenziarono , arrivando al successo politico e sociale utilizzando stemmi completamente diversi
Una considerazione a cui non penso si possa dare una risposta univoca meritano poi i molti stemmi apparentemente simili od uguali che appaiono nel Ceramelli-Papiani Nello stesso luogo stemmi uguali potrebbero , per quanto detto , significare l'appartenenza ad uno stesso gruppo parentale Vedi ad esempio stemma Iacopi ( quello dell'amico generale Massimo Iacopi ) e lo stemma Veneri a Firenze ; ma non e' detto ed ogni caso va studiato genealogicamente cioe' in modo a se stante , ricercando la soluzione nella storia familiare
Gli antichi non amavano il vuoto La dove non sapevano inventavano. E quindi noi dobbiamo far attenzione Statue , quadri , raffigurano ritratti immaginari dei personaggi. Quale era il vero volto di Giovanni di Bicci dei Medici ?....................................... Cosi anche l'araldica ha pagato dazio alla fantasia e questa propensione ci lascia oggi il compito di distinguere il vero dal falso Non cadendo nella trappola di queste menzogne tramandate nei secoli come verita' ecol tempo divenute verita'
PERCEZIONE DELLA QUESTIONE ARALDICA A FIRENZE E PROBABILMENTE IN ITALIA A FINE DUECENTO
Ad inizio trecento quando a Firenze vivevano Dante Alighieri e Giovanni Villani non si aveva la giusta percezione di quando le prime famiglie fiorentine avevano iniziato a utilizzare quello che si potrebbe definire il cognome moderno ne di quando l'araldica aveva iniziato a diffondersi a Firenze e in Italia Con percezione particolare ritenevano che l'araldica esistesse da sempre e quindi tutti i grandi uomini dell'antichita' dovessero avere avuto uno stemma Con questa percezione i vari eruditi non trovando documentazione si sforzarono d'inventarne a ciascuno uno per primi
Lo stemma del marchese Ugo e' uno stemma inventato dalla fantasia di antichi eruditi di cui si e' persa memoria Ai tempi di Dante Alighieri l'invenzione era comunque gia' fortemente consolidata
Ugo di Toscana (o di Tuscia) è una icona di buongoverno da oltre mille anni. Una icona talmente potente che già nel 1300 la sua memoria viene consacrata dai versi di Dante Alighieri: “Ciascun che della bella insegna porta / del gran Baron il cui nome e il cui pregio / la festa di Tommaso riconforta / da esso ebbe milizia e privilegio” (Paradiso XVI, 127-130). Nel tardo 1400 Mino Da Fiesole realizza il suo monumento funebre nella Badia Fiorentina, dove l’alto magistrato riposa. In Badia Fiorentina ogni anno nella ricorrenza della sua morte, avvenuta il 21 dicembre 1001, la figura di Ugo di Toscana viene ricordata dai monaci e dalle autorità civili. Ugo di Toscana, o di Tuscia, detto a volte Il Grande (951/953[2] – Pistoia, 21 dicembre 1001), fu marchese di Toscana dal 961 circa fino alla sua morte e duca di Spoleto e Camerino dal 989 al 996.
La sua “bella insegna”, il suo stemma ( inventato ) è' visibile nella Badia Fiorentina: uno scudo con tre pali d’argento in campo rosso.
Dante Alighieri ci racconta : ............che il marchese Ugo di Toscana concesse il cingolo militare e il privilegio di inserire il suo stemma i "tre pali d’argento in campo rosso” nel loro a poche ( e quindi di antichissima nobiltà ) famiglie fiorentine Dante ci racconta cio' che lui credeva vero ai primi del trecento Dante credeva vero che Ugo di Toscana avesse un suo blasone. Oggi sappiamo che non era possibile Ma questo ci dice qualcosa in piu' Ci dice che qualche erudito molto prima di Dante aveva assegnato al Marchese Ugo un'insegna parto della sua fantasia , Nella convinzione che ogni grande uomo dell'antichita' avesse uno stemma suo , gli eruditi del XIII secolo avevano cioe' inventato cio' che non trovavano e lo avevano cosi imposto alla convinzione comune Dante Alighieri ha fatto da cassa di risonanza a questa invenzione fino ai giorni nostri
UN ALTRO ESEMPIO DI STEMMA DI FANTASIA CHE SI PUO' SCAMBIAR PER VERO
Enrico II il Santo (Bad Abbach o Hildesheim, 6 maggio 973 o 978 – Grona, 13 luglio 1024) è stato re d'Italia dal 1002 al 1024, imperatore del Sacro Romano Impero e ultimo esponente della dinastia degli Ottoni. Figlio di Enrico II di Baviera, alla sua morte, nel 995, divenne duca di Baviera con il nome di Enrico IV di Baviera. Fu anche duca di Carinzia come Enrico III. È stato dichiarato santo. Anche sua moglie, Cunegonda, rientra nel novero dei santi della Chiesa cattolica. La sua tomba, in cui giace assieme alla moglie Cunegonda, capolavoro marmoreo di Tilman Riemenschneider, è custodita nel duomo di Bamberga.
Tilman Riemenschneider (Heiligenstadt, intorno al 1460 – Würzburg, 7 luglio 1531) è stato uno scultore ed intagliatore tedesco, fra i più celebri dell'epoca tardogotica e rinascimentale. Quindi il monumento funebre e' opera molto piu' tarda rispetto all'esistenza in vita di Enrico II e lo stemma gli e' attribuito Enrico II visse in un epoca in cui l'araldica non esisteva
Giustamente l'ingegner Maurizio Tiglieri aggiunge qualcosa : Stemma di fantasia (ma a fine XV probabilmente già consolidato da secoli, e quindi totalmente credibile, e creduto, e "storico") ottenuto inquartando Impero e Wittelsbach (per estensione, "Baviera")
Detto usando parole piu' povere gli eruditi del passato non amavano il vuoto e quando non sapevano inventavano Cosi oggi troviamo ritratti di personaggi illustri , statue , stemmi , antenati ,alberi genealogici , del tutto di fantasia ma creduti veri per cosi tanto tempo che oggi si fa fatica a dichiararli , come sono , falsi
Les collections du Musée des Archives nationales Armorial dit "Le Breton" Armorial dit "Le Breton" du nom du propriétaire l'ayant fait relier à ses armes "Hector Le Breton, sieur de la Doinneterie" héraut d'armes de France au titre de Montjoie (1615-1642). Il a ensuite appartenu à la collection du comte Henri Chandon de Briailles et est parfois qualifié d'armorial "Montjoie-Chandon". Il a été constitué en deux temps : une première partie a été peinte à la fin du XIIIe siècle ou au début du XIVe siècle, une seconde a été réalisée dans la seconde moitié du XVe siècle. Il représente environ un millier de blasons peints. Comme dans tous les armoriaux médiévaux, on y trouve à la fois des armoiries de personnages historiques et d'autres attribuées à des héros imaginaires. Ainsi le pape Calixte III voisine avec le roi Arthur, le roi René avec Hector de Troyes. La présence des armes de Calixte III et de René d'Anjou permet de dater la partie peinte du XVe siècle, entre 1450 et 1458. Il contient environ 950 blasons. Reconnu dès le XVIIe siècle comme un précieux témoignage, plusieurs copies partielles en furent réalisées. Il présente donc la double caractéristique d'être un objet historique en soi et d'être l'un des plus anciens corpus de la documentation héraldique française.
In evidenza : Comme dans tous les armoriaux médiévaux, on y trouve à la fois des armoiries de personnages historiques et d'autres attribuées à des héros imaginaires. Ainsi le pape Calixte III voisine avec le roi Arthur, le roi René avec Hector de Troyes.
Nella Cattedrale di Roma e' presente il monumento sepolcrale di Papa Alessandro III (Rolando Bandinelli +1181),Alla sommità del monumento , dall'aspetto di tabernacolo con colonne di onice e di giallo di Siena e' innalzato uno stemma Bandinelli (d'oro diaprato d'oro ) L'opera e' stata realizzata nel 1658-1659 per volontà del papa Alessandro VII, (scultura di Domenico Guidi) Lo stemma innalzato e' chiaramente uno stemma pontificio presuntivo, dal momento che - come è noto - solo oltre un secolo dopo la morte di Papa Bandinelli inizierà la pratica dell'uso di stemmi da parte dei pontefici romani, verosimilmente con Bonifacio VIII Caetani, la cui arma si trova, rappresentata su lacerto di affresco di attribuzione giottesca, nella stessa navata destra della medesima Arcibasilica Lateranense (anch'essa d'oro, ma alla gemella ondata in banda d'azzurro). Fonte : Don Antonio Pompili forum IAGI Non so quando i Bandinelli iniziarono ad avere uno stemma e quando il cognome
da Maurizio Carlo Alberto Gorra ----Membre associé de l’Académie internationale d’héraldique------uno degli attuali massimi esperti di araldica
L’araldica è fenomeno privo di “data di nascita” precisa, benché la sua origine sia assegnabile ad un’epoca compresa fra XI e XII secolo, e verosimilmente circoscrivibile attorno alla metà di quest’ultimo. La data tradizionale dell’elezione del primo doge è l’anno 697: la durata di tale ciclo storico arriverebbe pertanto a millecento anni esatti. «Comme nous le savons, l’héraldique n’apparaissant que vers le XII siècle, il est bien évident que les armoiries antérieures à cette époque sont apocryphes. Toutefois, au contraire d’autres situations comparables, ici le caractère apocryphe n’est pas totalement gratuit ou anodin. En effet, le Dogat de Venise étant comme nous l’avons vu détenu depuis l’origine par l’aristocratie de cette République, et que même une partie de cette aristocratie provenait de familles patriciennes de l’Empire Romain, plusieurs d’entre elles, ont à tantes époques tenté, sur des bases parfois établies, parfois douteuses de rattacher les premiers Doges à leur famille. Pour ce faire, des armoiries rappelant ces lignages revendiqués ont depuis longtemps été attribuées à ces premiers Doges» (arnaud bunel, Armorial illustré des Doges de Venise, edizione internet 2009, www. heraldique-europeenne.org p. non numerata ma penultima dell’Introduction). La “fanta-araldica” fu fenomeno particolarmente caro a un aspetto della mentalità pre-enciclopedica e cortigiana delineatosi nel medioevo, e rinvigoritosi nel tardo rinascimento e nel primo barocco : ritenendo che ogni personaggio di un qualche spicco non potesse né dovesse essere privo di uno stemma che ne suggellasse il rilievo, gli araldi delle rispettive epoche s’impegnarono con puntiglio a colmare ogni pur minima lacuna blasonica. L’impresa venne compiuta anche sui primi dogi: tutti, a partire da Paoluccio Anafesto , ricevettero un emblema araldico a secoli di distanza e talora dai diretti discendenti i quali, normalmente, non lavorarono troppo di fantasia giacché assegnarono a ogni augusto antenato lo stemma “storico” portato dalla dinastia. L’operazione era coerente con i plurimi legami che a Venezia vincolavano l’esercizio del potere alla dimostrazione di appartenenza al ceto nobiliare: aver avuto un doge in famiglia signiicava consolidare il proprio status, il che comportava positive conseguenze su più piani, sia di prestigio che concreti È dal suo stemma (ovviamente di fantasia) che inizia, ad esempio, la sequenza araldica disegnata a colori nel manoscritto della Cronica de tutte le casade della nobel città de Venetia cioè delli zentilhomeni che sono venuti ad habitar in quella.. con le arme de tutti li zentilhomeni di essa città, Venezia c. 1608-1612, oggi a PhiladelPhia, University of Pennsylvania, Rare Book & Manuscript Library, ms. Codex 278; nonché quella stampata in GioVanni Palazzi, Fasti ducales ab Anafesto I ad Silvestrum Valerium venetorum ducem, Venezia, G. Albrizzi 1696 Dovendo dare una base temporale ai termini della questione qui affrontata, si può indicare attorno al terzo quarto del XII secolo 13 l’epoca in cui l’araldica inizia a lasciare la fase embrionale per divenire come oggi la conosciamo. I rischi connessi agli insidiosi scogli della “fanta-araldica” inducono qui a elencare, fra le famiglie veneziane che diedero dogi alla Serenissima a cavallo di quel lasso di tempo, solo le cinque i cui cognomi compaiono con sicurezza 14 sulle liste più accreditate: Contarini, Falier, Memmo, Michiel e Morosini 15. robert Viel, Le origini simboliche del blasone, Parigi 1972 (trad. it. Roma 1998), p. 90; Michel Pastoreau, Medioevo simbolico, Parigi 2004 (trad. it. Bari 2005), p. 198. È intuitivo che queste date costituiscono un’approssimazione ragionevole e ragionata, al che consegue la necessità di farne uso con un certo margine di tolleranza specie quando si confrontano con datazioni più puntuali. Il fenomeno, peraltro non esclusivo di tali periodi in quanto insito nella “fantasiosità” dell’animo umano, ha portato a ideare e realizzare fra gli altri anche gli stemmi dei pontefici anteriori a Bonifacio VIII, circa i quali vedi supra. .......................................................
(Maurizio carlo alberto Gorra, Habemus papam! La cronotassi pontiicia da Bonifacio VIII a Benedetto XVI, «Speciale di Cronaca Numismatica», 12, (2000); ideM, L’arma di Pietro: ipotesi per un blasonario dei ponteici anteriori a Bonifacio VIII, «Nobiltà », VIII, 39, (2000), pp. 557-576)
NOTA BENE Noi oggi sappiamo che in ITALIA si entra in eta' araldica solo a cavallo della meta' del XII secolo
Da notare che cosi come sono stati inventati stemmi di sana pianta , allo stesso modo noi conosciamo quadri che contengono immagini di fantasia di un personaggio storico : quadri e sculture Entrati talmente nel nostro habitat mentale da considerarli veri
Il passato e i suoi oggetti ci tendono mille trappole con quadri, statue , stemmi genealogie ,storie , tutto splendidamente falso incrostazioni , falsita' che sembrano piu' vere del vero
RETRODATAZIONE DI UNO STEMMA AGLI ASCENDENTI Capita spesso che lo stemma dei discendenti venga attribuito agli ascendenti senza bisogno di ulteriore documentazione
LO STEMMA DEGLI ATTONI O ATTONIDI IMPROPRIAMENTE INDIVIDUAI DAGLI STORICI PER COMODITA' INDIVIDUATIVA COME "I CANOSSA" IN REALTA' ANCHE ATTONI o ATTONIDI E' UN INVIDUAZIONE A POSTERIORI FATTA DAGLI STORICI ( siamo in un eta' precognomica )
Anche attribuire uno stemma a Matilde (di Canossa) e ai suoi ascendenti e' sforzo di fantasia Matilde muore nel 1115 quindi come abbiamo visto in periodo prearaldico e quindi non ha alcuno stemma Ovviamente cio' a maggior ragione e' vero per i suoi ascendenti Bonifacio, Tedaldo, Adalberto Atto , Sigifredo
Lo stemma nasce anche qui dallo stemma di una famiglia che si dichiara discendente ( sembra con una documentazione scarsamente decisiva ) : i Da Canossa ancora viventi Quindi uno stemma arbitrariamente retrodatato
stemma del Podesta Guido da Canossa---1382 ----Bargello -Firenze Dagli ultimi decenni del sec. XIII al 1502 il Bargello, la cui costruzione venne iniziata verso il 1255, fu la sede del Podestà di Firenze, chiamato anche Pretore. Tale carica venne poi sostituita da un Consiglio di Giustizia o Rota e quindi il palazzo dal 1502 al 1574 fu abitato dai Giudici di Rota. Nei secoli successivi l'edificio fu adibito a prigione e a tal scopo modificato; solo fra il 1854 e il 1867 l'architetto Francesco Mazzei e il pittore Gaetano Bianchi lo liberarono dalle sovrastrutture, tentando il recupero dell'edificio trecentesco. Il cortile è decorato dagli stemmi di Podestà e Giudici di Rota che risiedettero nel Bargello; tale usanza era diffusa in Toscana ed esempi simili si trovano sui palazzi pubblici di Fiesole, Colle val d'Elsa, Poppi, San Giovanni val d'Arno e Radda. L'abitudine di lasciare il proprio stemma sembra essere molto antica ed è sancita da alcuni Statuti comunali. La decorazione del cortile comprende inoltre le insegne antiche dei Quartieri e dei Sestieri scolpite in pietra e colorate. Durante i restauri ottocenteschi furono invece dipinte nelle volte i gonfaloni dei quartieri e alcuni stemmi di Podestà. Copie moderne delle insegne personali sono state collocate sulle pareti esterni del cortile. L'edificio è stato restaurato dopo l'alluvione del 1966 e con esso parte degli stemmi. Il presente scudo è l'arme personale di Guido da Canossa di Reggio, Podestà di Firenze nel 1382 come un elenco conservato al museo del Bargello
RETRODATAZIONE DI UNO STEMMA AGLI ASCENDENTI Capita spesso che lo stemma dei discendenti venga attribuito agli ascendenti senza bisogno di ulteriore documentazione , ma talvolta capita che lo stemma venga retrodatato a gente che parenti non sono si trovava logico attribuire ai grandi del passato gli stessi stemmi che i loro "discendenti" usavano correntemente.senza tener conto se fosse gia' o non fosse ancora in uso il dotarsi di uno scudo araldico Questo è il ramo più intrigante e "difficile" della para-araldica: gli stemmi assegnati a personaggi (come i primi Dogi di Venezia) vissuti in epoca pre-araldica, e che quindi mai fecero uso dell'arma loro attribuita.
In una sorta di fase pre cognominale medioevale si usava da parte della gente identificare sovente i castellani dal nome del castello Questo uso e' passato agli storici Ma non mi pare fosse l'identificazione che i castellani davano di loro negli atti notarili . La stirpe degli "Attoni" si estingue nel 1115 in eta' prearaldica e precognominale
Lo stemma degli Attonidi :
la storia dello stemma di Canossa e' molto istruttiva per molti aspetti
C'e' un poco di tutto dentro Cominciamo col dire che la contessa Matilde non si e' mai chiamata Matilde di Canossa Ho avuto finalmente la conferma a questa certezza !!!
Anche attribuire uno stemma a Matilde (di Canossa) e ai suoi ascendenti e' sforzo di fantasia Matilde muore nel 1115 quindi come abbiamo visto in periodo prearaldico e quindi non ha alcuno stemma Ovviamente cio' a maggior ragione e' vero per i suoi ascendenti Bonifacio, Tedaldo, Adalberto Atto , Sigifredo
Furono una potente famiglia feudale di stirpe longobarda che, a partire dai primi decenni del X secolo, si insediò nelle valli dell'Appennino reggiano. Sigifredo, originario di una famiglia di Lucca, è considerato il capostipite della casata e suo figlio Adalberto Atto (da cui il nome della famiglia "Attoni o Attonidi ) fu il primo conte di Mantova e il costruttore del Castello di Canossa,. Utilizzarono presto il titolo di comes (conte) e ricevettero molti altri territori, in prevalenza toscani, dagli Imperatori del Sacro Romano Impero: prima Lucca, poi Mantova nel 940, Modena, Carpi e Reggio nel 962, Brescia nel 980, Ferrara, Parma, Piacenza, Bergamo e Cremona nel 984, e Guastalla nel 991. Nel 1027 la marca di Toscana fu concessa a Bonifacio e nel 1100 la marca di Verona a Matilde, conosciuta come la Gran Contessa. Con Matilde, infatti, il dominio degli Attonidi raggiunse la sua massima estensione e i suoi territori vennero chiamati terre matildiche, ma fu anche l'ultimo grande esponente della dinastia degli Attonidi
Questa stirpe vive in eta' precognominale e prearaldica,questo comporta che non hanno ne' un cognome ne' uno stemma. Gli storici per parlare di loro hanno bisogno di dare loro una individuazione e danno loro quella di Attoni o Attonidi (discendenti da Adalberto Atto) e anche di Canossa . Ma e' un individuazione fittizia ( e questo deve essere molto chiaro !!! )
E' concettualmente errato (ma suggestivo e fortemente indicativo) dire "Matilde di Canossa" Bonifacio si autoidentifica e si sottoscrive come MARCHIO , non come Bonifacio Attonide o come Bonifacio di Canossa Con che logica gente che dominava almeno un sesto dell'Italia avrebbe dovuto usare identificarsi con una fortezza sperduta per quanto importante ? Identificavano se stessi con la carica pubblica che detenevano DUX MARCHIO COMES COMITISSA Titoli che avevano in quel momento ( Riferendosi al Ducato longobardo o alla Marca franca o alla Contea franca ) ben altro valore a quello che quegli stessi titoli avranno solo tre secoli dopo
Quindi per gli Attonidi niente cognome Canossa, niente stemma
L'uso improvvido da parte degli storici di questa identificazione a posteriori come Canossa ha reso piu' facile la confusione con la famiglia effettivamente cognominata da Canossa ( poi Canossa ) che prende effettivamente il cognome dall'aver detenuto poteri signorili sulla rocca di Canossa
A questa famiglia sia il Muratori sia il Tiraboschi assegnano come capostipite conosciuto Albertus de Canusio non collegabile agli Attonidi ,( e io non sono a conoscenza siano emersi successivamente documenti capaci di modificare queste conclusioni )
Per il giudizio moderno sulla parentela tra gli Attonidi ed i Canossa di Verona ( famiglia di suo comunque molto importante) vedi anche la voce Treccani : Bonifacio da Canossa
L'omonimia ( se di omonimia si puo' parlare non potendosi parlare di un cognome Canossa per gli Attonidi) tra le due famiglie passa attraverso il legame che hanno in tempi diversi i due guppi parentali con la rocca di Canossa
quindi pare non esista nessuna commistione tra le due stirpi ed il cane collarinato e' lo stemma dei "Canossa di Verona" non degli Attonidi e quini nemmeno di Matilde che come abbiamo visto non potevano comunque avere uno stemma
In pratica sempre e' invalsa in araldica l'abitudine della RETRODATAZIONE DI UNO STEMMA AGLI ASCENDENTI Capita spesso cioe' che lo stemma dei discendenti venga attribuito agli ascendenti senza bisogno di ulteriore documentazione , Ma talvolta capita pure che lo stemma venga retrodatato a presunti ascendenti anche senza un legame genealogico documentato. Pare che in questo caso sia avvenuto questo Cosi oggi gli Attonidi si ritrovano spesso citati con uno stemma ( il cane collarinato ) che non potevano avere, perche' comunque parentela o meno , sono vissuti in eta' prearaldica E' questo il lato grave della faccenda : introdurre nella storia il pensiero che possa esistere nel 1115 uno stemma della contessa Matilde , facendo dubitare delle nostre conoscenze intorno alla diffusione dell'araldica in Italia Poiche' l'irruzione sulla scena dell'araldica e di conseguenza del cognome a mezzo XII ha un'importanza socio-politica ancora non sufficientemente valutata Non credo che la presunta parentela con i Canossa di Verona cambi la storia. Penso invece la cambi di molto l'introduzione di uno stemma in un tempo prearaldico ( ed anche precognomico )
Insomma un pasticcio molto dovuto all'improvvida scelta degli storici d'identificare gli Attonidi come i Canossa che ha creato una omonimia artificiale ( quandio si adotta una convenzione va sempre indicata come convenzione )
Dai ragionamenti fatti sopra nasce l'errata consuetudine di dotare i due diversi gruppi parentali di uno stesso stemma Lo stemma del cane collarinato appartiene solo ai "da Canossa o Canossa di Verona" vedi stemma al Bargello di Firenze del podesta Guido da Canossa del 1382 E' stato artificialmente retrodatato in nome di quella omonimia forzata ( mai gli ATTONI si sono chiamati CANOSSA ) fino ad assegnarlo anche agli "Attoni che mai ebbero uno stemma ed un cognome" Un messaggio semplicemente falso A) Matilde e i suoi ascendenti non ebbero stemma perche' viventi in periodo prearaldico B) Non esiste allo stato attuale delle conoscenze un legame genealogico tra gli Attonidi e i Da Canossa veronesi per cui non vi e' giustificazione alcuna nella retrodatazione dello stemma
Come abbiamo visto capita assai spesso che lo stemma dei discendenti venga attribuito agli ascendenti senza bisogno di documentazione, occorre pero un legame genealogico che giustifichi un'operazione borderline In questo caso pero' sembra non esistere proprio la giusificazione genealogica cioe' la parentela tra le due stirpi
NOTA BENE Anselmo di Besate , (Milano, 1020 ca. – dopo il 1048) In Parma, probabilmente durante un suo secondo soggiorno (e dopo aver ascoltato le lezioni di Sichelmo in Reggio), A. scrisse la sua opera di maggior rilievo, la Rhetorimachia. I termini cronologici estremi per la composizione dell'opera sono: maggio 1046-maggio 1048. ---- Tedaldo Comes e Marchio figlio di Adalberto Atto (X secolo – 1012) La denominazione de Canussa per designare sia Tedaldo sia il padre, che è sintomo di una precoce formazione cognominale volta a identificare la linea agnatizia di Adalberto Atto, è attestata per la prima volta nella Rethorimachia di Anselmo da Besate (a cura di K. Manitius, 1958, II, cap. 2, p. 141), che menziona il matrimonio di Prangarda, figlia di Adalberto Atto e sorella di Tedaldo, e il marchese arduinico Manfredo. Dalla voce Tedaldo di Canossa di Tiziana Lazzari - Dizionario Biografico degli Italiani - Volume 95 (2019) io credo che l'interpretazione della professoressa di una precoce cognomizzazione sia un poco troppo audace. La prima caratteristica di un cognome e' l'ereditarieta'. Poi occorre trovare nei documenti notarili che riguardano direttamente la persona, la persona stessa nominata con quel cognome precoce Siamo, mi pare, solo in presenza di una personale identificazione di un cronachista da non generalizzarsi e da non confondere con un cognome
Una genealogia dei Canossa di Verona prende spunto da una genealogia che parte dal buio dei tempi ( la gente Atia romana intorno al 400 DC) parto della fervida fantasia di Alessandro Canobbio che allaccia a Matilde di Toscana Origine della nobilissima ed illustrissima famiglia Canossa ...............................Alessandro Canobbio ....... anno 1593
e' veramente difficile accettare che un albero di questo tipo non documentato correttamente possa essere stato nel XVII secolo considerato attendibile ed addirittura messo alle stampe :specchio dei tempi
Cenni intorno all'illustrissima famiglia ............Cesare Cavattoni modena 1859
Varie famiglie illustri di Verona ............Antonio Cartolari 1865
Varie famiglie illustri di Verona ............pag 174 Angelo Ferretti 1884
Una sintesi della faccenda ..................tenendo conto che Guido Guerra e' uno di quelli individuati dagli storici come conti Guidi
IL PERIODO PIU' PERICOLOSO PER LA RICERCA STORICO-GENEALOGICO E' QUELLO QUANDO LA RICERCA ENTRA IN CONTATTO CON L'ERUDITISMO DELL'ANCIEN REGIME INFARCITO DI INFORMAZIONI TALVOLTA DI PURA FANTASIA
importanti questi studi Guido da Canossa ---Treccani---Gherardo Ortalli Bonifacio da Canossa---Treccani--Gherardo Ortalli Il cavallo di Gabrotto di Canossa Storia dei Canossa di Verone e di Mantova
UN ERRORE CHE ANCOR OGGI VIENE TRASMESSO DA ALCUNI TRATTATI DI ARALDICA : DARE UN SIGNIFICATO ALLE FIGURE ARALDICHE CHE COMPAIONO NELLO STEMMA
Cercare di dare un significato alla scelta dei simboli araldici su uno stemma antico cioe' cercare di dare un significato alla struttura simbolica di uno stemma e' un vezzo culturale entrato in auge SOLO tra millesette e milleottocento. Gli stemmi creati prima di questo periodo ubbidivano , solo ai gusti estetici di chi aveva iniziato le fortune della famiglia e si era dotato di uno stemma Non c'e' niente che ci dica ( ad esempio ) che la variazione nel numero delle palle nello stemma dei Medici sia da attribuirsi ad altro che ad un fattore estetico
Inutile quindi cercare di trovare a secoli di distanza significati nelle scelte grafiche che hanno dato vita a uno o ad un altro blasone Ancor oggi molti ritengono erroneamente vero un assunto come questo: "Ogni figura araldica ha un preciso significato: Questo potrebbe esser vero per stemmi molto tardi , cioe' nati nel momento in cui era invalso questa interpretazione araldica . In generale un imposizione interpretativa posteriore e senza fondamento documentario . In generale insomma qualcosa di pressapochistico Oggi noi non sappiamo e difficilmente sapremo mai in futuro pur col progredire della ricerca perche' lo stemma dei Medici e' quello che conosciamo. E difficilmente potremo sapere che aveva in testa l'uomo di questa famiglia che per primo lo ideo' per se e se lo fece costruire da un artefice che probabilmente ci mise anche lui qualcosa di suo
Ginanni, Marc'Antonio, conte Araldista (Ravenna 1690 - ivi 1770), autore dell'Arte del blasone dichiarata per alfabeto (1756), opera di accurata compilazione, giudicata il miglior trattato italiano di araldica anteriore al sec. 19º. Gli animali araldici sono figure araldiche considerate le più nobili e hanno spesso la funzione di simboleggiare le qualità o il potere del titolare dello stemma.Sono rappresentati di norma in una loro posizione naturale e cioè passanti, rampanti, correnti, sedenti, dormienti, ecc. DRAGO: usato in araldica per rappresentare la fedeltà, la vigilanza e il valore militare. ... ELEFANTE: simboleggia la forza, la grandezza d'animo e la stirpe ... Affermazioni come queste non possono essere sempre vere perche' nessuno sa cosa passasse nel cervello del creatore di uno stemma antico nel momento della ideazione
Nel sito del Comune di Bologna : Storia e memoria di Bologna , leggiamo : ................. L'enorme gamma di figure araldiche unita alla possibilità di cambiare la loro posizione nel campo dello scudo, i diversi colori con cui questi si possono dipingere (rosso, azzurro, verde, nero) uniti ai due cosiddetti metalli (oro ed argento), dà luogo ad una immensa varietà di combinazioni. La scelta di una figura piuttosto che un'altra, può essere dovuta ai motivi più disparati: a pura immaginazione per lo più, ma anche ad un fatto d'arme, alle qualità personali del proprietario, ad un evento importante, ad un episodio accidentale ora dimenticato e non più rintracciabile ecc. Per la maggior parte degli scudi il motivo rimane ignoto a meno che non si tratti delle cosiddette armi parlanti, nelle quali gli oggetti rappresentati fanno allusione al nome della famiglia o al mestiere esercitato od a qualche evento storico. E qui si pone il problema del simbolismo in araldica. Esiste in realtà per questa scienza un linguaggio simbolico? In verità esso è solo frutto di credenze popolari o della fantasia degli araldisti classici (Menestrier, Ginanni) che hanno voluto attribuire un significato recondito ai vari colori o figure rappresentate sugli scudi. Il significato simbolico di animali come leoni, aquile, colombe è conosciuto da tutti, ugualmente per le stelle, le croci, i fiori, gli utensili ecc. E questo un simbolismo di tipo popolare: nessun significato esoterico quindi.
In libreria troviamo "L’arte araldica nel Medioevo: gli stemmi medievali tra arte, storia e società". Michel Pastoureau racconta un fenomeno tanto affascinante quanto spesso mal interpretato Emblemi, simboli, armi medievali: c’è qualcosa che risuona istintivamente esoterico e oscuro in queste parole. In realtà, di buio non c’è proprio nulla. Di oscuro, forse, c’è solo il voler rintracciare misteriosi significati in qualcosa che non si conosce. Quando e come l’orso cede il passo al leone come re degli animali? Perché il blu diventa sempre più popolare a partire dal Basso Medioevo? La storia dell’araldica è anche la storia dell’Europa e porta sulla sua pelle i cambiamenti della moda, della società e dei gusti del vecchio continente. Con L’arte araldica nel Medioevo, Michel Pastoureau pone le basi per la comprensione dell’araldica, scienza che ha come oggetto lo studio degli stemmi, e spazza via i grandi equivoci e stereotipi che spesso la infestano. Gli stemmi, al contrario di quanto solitamente si tende a credere, non sono appannaggio della nobiltà cavalleresca; dalla fine del XII secolo sono comunemente usati anche da artigiani, contadini, città e perfino da personaggi immaginari e letterari. La loro origine ha come caratteristica precipua la chiarezza e aborrisce significati nascosti o reconditi: lo spirito araldico più “puro” impone rigore, trasparenza e leggibilità. Per un individuo del Medioevo era naturale essere circondato da stemmi – o arme, armi al plurale – e la loro decifrazione era tutt’altro che impegnativa. Far vagare l’immaginazione in cerca di indecifrabili messaggi massonici è puro esercizio romantico. Per dare il giusto significato a questi particolari emblemi serve uno sforzo da storici, più che da romanzieri. Serve l’aiuto di un Umberto Eco o un Alessandro Barbero, più che di un Dan Brown
Solo al secolo XVII rimontano le prime manifestazioni concrete della codificazione del tratteggio araldico così come si usa tuttora
Philippe de L'Espinoy (1552–1633) of Ghent was a historian, genealogist and heraldist of the Low Countries. He served as the commander of a company of Walloon infantry during the reign of Philip II of Spain. He gave up the military career to devote full-time to genealogical studies that led to the publication of the important volume in 1631, which was partly financed by the magistrate of the city of Ghent. The French heraldist Imbert de la Phalecque and his Italian counterpart Goffredo di Crollanza claim that the work of Philippe de l'Espinoy is the first one in which he adopted the hatching system applied in the blazon. However, the hatchings on the arms do not follow any system. The book does not contain any table of hatching. Looking at the numerous pictures of arms in this elaborate work, at first sight they appear to have hatchings. If one however compares these "hatchings" with the descriptions, then one finds out that there is no system in it at all. For instance Gules is alternately indicated by horizontal or vertical or diagonal lines or is left blank. It seems l'Espinoy considered lines and dots merely as a sort of artistic additions which he put in at random. An earlier book of l’Espinoy in 1628 had Brabantic subjects[4] indicating that the author was also closely connected to the territories where the heraldic hatching system emerged initially. Besides the Flemish subjects of the book it shows a close connection between the French and Brabant-Flemish territories, as also the fact that in 1595 Petrus Zangrius also published a book in Douai.
Marc Vulson de la Colombière Araldista francese (n. nel Delfinato - m. Parigi 1658); fra le altre opere pubblicò Recueil de plusieurs pièces et figures d'armoires (1639), in cui per primo in Francia usò i tratteggi per rappresentare gli smalti, e La science héroïque (1644 e 1669).
Christophe Butkens (1590–1650) was a Cistercian abbot from Antwerp, a historian and a genealogist who developed a new hatching system. According to Philipp Spener some maintained that Butkens was the first to invent a heraldic hatching system, but others gave that honour to Marcus Vulson de la Colombière.
padre Silvestro da Pietrasanta, "Nel XVII secolo, l’araldista francese Vulson de la Colombière codificò definitivamente dei particolari segni per riconoscere il colore degli smalti negli scudi riprodotti in bianco e nero. E l’araldista padre Silvestro di Pietrasanta della Compagnia di Gesù, per primo, ne fece uso nella sua opera Tesserae gentilitiae ex legibus fecialium descriptae, diffondendone, così, la conoscenza e l’uso".
E' evidente la difficolta' nostra nel decifrare uno stemma del secolo XV quando non vi era codifica alcuna e la pietra o i marmi rendevano un bianco -nero o un grigio Evidentemente questo non era una difficolta' per i contemporanei che ben conoscevano l'arme ed i colori Ma oggi in taluni casi pone quesiti insuperabili
CONSIDERAZIONI SUI TANTI STEMMARI DEL PASSATO E SUGLI STEMMARI CHE COMPAIONO IN INTERNET E ESEMPIO VIRTUOSO DEL CERAMELLI PAPIANI
Come dicevo in uno stesso luogo stemmi uguali devono far pensare ad uno stesso stipite genealogico Bisogna pero' far attenzione, ad esempio , le famiglie Iacopi e Veneri hanno apparentemente un medesimo stemma non sembrano avere pero' legami genealogici
Occorre verificare se l'attribuzione degli stemmi e' correttamente basata su documenti lapidei o grafici e non frutto solo di invenzioni erudite cioe' a dire : molti stemmari riportano stemmi che sono solo invenzioni. L'erudito non amava ammettere ignoranza e la dove c'erano dei vuoti spesso li riempiva con la fantasia Occorre quindi sempre esaminare in che periodo si ha la prima prova documentale dello stemma Ed anche occorre esaminare se le famiglie oggi abitanti in uno stesso luogo non provvenissero ieri da luoghi diversi ecc.................. Lo stemma Iacopi e' ancora visibile in molti luoghi a Firenze e nel dominio Dello stemma Veneri esiste una sepoltura in San Marco a Firenze senza colori ( essendo in pietre non colorate) .L'attribuzione dei colori si deve al Priorista Ridolfi e potrebbe anche essere solo una sua fantasia
IN GENERALE OCCORRE DUBITARE DEGLI STEMMARI QUANDO NON SONO DOCUMENTATI DA MANUFATTI COEVI NON TUTTI GLI STEMMI CONTENUTI IN UNO STEMMARIO E' DETTO CHE SIANO CORRETTQMENTE ATTRIBUITI AGLI ERUDITI CAPITAVA DI BARARE , DANDO AD INTENDERE DI CONOSCERE CIO' CHE IN REALTA' NON CONOSCEVANO, O TALVOLTA DI SBAGLIARSI IN BUONA FEDE L'ABITUDINE A NON METTERE IN DISCUSSIONE QUANTO DETTO IN PASSATO HA TRASMESSO ALL'OGGI TUTTA UNA SERIE DI COSE FALSE ANCHE ARALDICHE
LA RACCOLTA CERAMELLI PAPIANI ( IN ARCHIVIO DI STATO DI FIRENZE ) UN UNICUM TRA GLI STEMMARI
Lo stemmario classico si limita ad una raccolta di blasoni attribuiti a varie famiglie di un territorio piu' o meno vasto , nessuna prova documentaria viene allegata Sulla loro verita' fa fede l'autore dello stemmario , che puo' anche sbagliare , mentire , ( far finta di sapere cio' che non si sa per certo ) ............ Il rischio e' di accettare per vero qualcosa che non lo e'
Uno dei piu' SERI e' il BLASONE BOLOGNESE
Il Blasone bolognese, cioè Arme gentilizie di famiglie bolognesi, nobili, cittadinesche e aggregate, è la più importante raccolta di stemmi, o più propriamente scudi, e cimieri dell'area bolognese. L'opera, pubblicata a Bologna tra il 1791 e il 1795, venne concepita da Floriano Canetoli, che si adoperò personalmente nella raccolta degli stemmi, facendo richiesta alle varie famiglie nobili e "cittadine" bolognesi affinché gli trasmettessero l'arma e l'impresa. La raccolta è costituita quasi interamente da tavole calcografiche, tutte le raffigurazioni incise (3623 stemmi, 1088 cimieri, 84 insegne, cornici e figure), sono colorate a mano, ad acquerello, con un effetto cromatico di grande bellezza
una pagina dello stemmario
il vantaggio di un simile stemmario e' la visione d'insieme
La Raccolta Ceramelli Papiani, costituita nel corso di molti anni da Enrico Ceramelli Papiani (1896-1976), e oggi conservata nell'Archivio di Stato di Firenze, è composta da quasi 8000 fascicoli, intestati a famiglie toscane di antica origine; all’interno di ogni fascicolo si trovano notizie genealogiche e araldiche tratte da fonti documentarie conservate nell'Archivio fiorentino o in altri istituti archivistici e biblioteche della Toscana.
Il Ceramelli Papiani documenta quindi quanto illustra con un fascicolo che contiene fotografie , collocazioni , descrizioni ,memorie, Si perde pero' nel Ceramelli Papiani la visione d'insieme dovendo consultare il fascicolo per vedere lo stemma il che non e' il massimo
Fondamentale e imprescindibile
per l’araldica toscana In
ASFirenze la raccolta Ceramelli
Papiani dei blasoni toscani http://www.archiviodistato.firenze.it/ceramellipapiani/ Il
dr Piero Marchi ha fornito un utile
strumento per la consultazione della raccolta : www.carnesecchi.eu/pieromarchiblasonario.pdf .
Quindi il Ceramelli Papiani e' una sorta di stemmario che ha quindi lo svantaggio di mancare della visione complessiva ma ha il vantaggio di documentare cio' che mostra E' suddiviso in tanti fascicoli uno per ogni famiglia di cui tratta Cerca di documentare gli stemmi attraverso manufatti lapidei o dipinti originali e databili Ne mostra le varianti e le modificazioni Questa e' un'idea molto moderna e corretta Non sempre questo gli e' possibile e quindi talvolta e' costretto ad appoggiarsi a stemmari precedenti incontrollati e spesso incontrollabili
Tutti gli stemmari non documentati lasciano ovviamente dei dubbi In Toscana ne esistono molti di questi stemmari. Per l'uso dei Prioristi a famiglie Queste raccolte di stemmi talvolta troppo complete e talvolta assolutamente non documentate. Dal Monaldi in poi fanno pensare che alcuni stemmi possano esser parto della fantasia del realizzatore che intendeva trasmettere al lettore quel senso di completezza dell'opera di cui abbiamo parlato Pure il Benvenuti ed il Mariani ( antiquari ai loro tempi insigni ) cadono in errori sicuramente involontari ma in nome della loro autorita' questi errori continuano a circolare ai giorni nostri , in una sorta di catena di sant'Antonio
La comparazione degli stemmi Iacopi e Veneri mi ha spinto a pensare che in definitiva noi abbiamo ancora cose da chiarire sugli stemmi antichi , e che accettiamo molte cose per scontate E mi e’ venuto quel dubbio che alcuni ( pochi o molti ) stemmi contenuti in alcuni stemmari possano esser fasulli cioe’ inventati dall’autore IN MALAFEDE o erroneamente attribuiti in BUONAFEDE e tramandati di voce in voce sino ai giorni nostri senza manufatti in grado di validarli
Senza uno studio specifico suffragato da fonti primarie non si possono mai trarre conclusioni sui legami genealogici dovuti al possedere uno stesso cognome o apparentemente uno stesso stemma Utilizzare, io credo, l'araldica ha senso solo per stemmari che facciano riferimento a manufatti esistenti o fotografati ( vedi la metodologia del Ceramelli Papiani ) Gli stemmari che raccolgono una lunga serie di stemmi , senza citare come si e' pervenuti alla loro assegnazione , non danno aprioristicamente certezze di verita' Sono raccolte di figurine e basta Utili, perche' sono utili costituendo un punto di partenza ( la stessa cosa che si disse per i Crollalanza , i Litta , ecc ) ,ma che in molte affermazioni debbono esser sottoposti sempre a verifica Gli araldisti del passato non amavano il vuoto e cosi come inventavano uno stemma per re Artu' o per Carlo Magno spesso assegnavano a famiglie omonime di luoghi diversi uno stesso stemma Solo in presenza di manufatti araldici possiamo avere maggiori certezze Anche qui bisogna stare attenti alla vanita' umana che l'omonimia del cognome spinge ad inalberare talvolta uno stemma uguale a quello di una famiglia piu' famosa per fondare una parentela inesistente Detto questo pero' una famiglia mercantile nelle dinamiche medioevali e rinascimentali puo' aver benissimo messo radici in luoghi anche molto distanti dal Comune di origine , in Italia come in Europa I nostri antenati non avevano l'aereo ma si muovevano in maniera stupefacentemente rapida e percorrevano distanze enormi per lavoro La conclusione e' sempre la medesima : nella ricostruzione della storia familiare non vi e' nulla che possa essere escluso , ma tutto deve essere dimostrato a mezzo documentazione I vecchi studi sulle famiglie per la maggior parte ubbidiscono a schemi mentali superati, gli alberi genealogici debbono essere controllati Un lavoro difficile I cognomi italiani sono oltre 350.000 Quasi di nessuno nemmeno dei piu' famosi e' mai stato fatto uno studio esaustivo , che abbia esaminato tutti i rami omonimi o no , notabili o no , ricchi o poveri Io ho provato a iniziare un simile studio per il mio cognome paterno
Lo stemma UBERTI secondo Vincenzo Borghini L'antiquario Vincenzo Borghini (1515--1580 ) nel discorso sull'Arme delle famiglie fiorentine ( pubblicato poco dopo la sua morte nel 1582-1584 ) assegna come stemma iniziale agli Uberti uno scaccato , ma suppongo faccia questo per mera deduzione senza alcuna prova del fatto e come stemma successivo quello partito con l'aquila Questa modifica ( se effettivamente avvenuta ) io suppongo possa essere avvenuta solo a cavallo del 200 , con un partito che utilizza l'aquila imperiale , a voler sottolineare probabilmente la collocazione nello schieramento in campo imperiale Quindi ,se mai lo ebbero , lo scaccato fu uno stemma di brevissima durata e circoscritto tra la meta' del XII secolo e la meta' del XIII Lo stemma partito compare come unico stemma Uberti originale sopravvissuto a Firenze negli avelli esterni nel fronte di Santa Maria Novella, a Firenze ????? Decamerone, Ottava giornata, nona novella: Buffalmacco dice a Maestro Simone, medico di Firenze: A voi si convien trovar modo che voi siate stasera in sul primo sonno in su uno di quegli avelli rilevati che poco tempo ha si fecero di fuori a Santa Maria Novella, con una delle vostre più belle robe indosso, acciò che voi per la prima volta compariate orrevole dinanzi alla brigata (…)
UNA STRANA LAPIDE A FIRENZE (POI RIVELATASI UNA SBAGLIATA RIPRODUZIONE NOVECENTESCA)
Nella città di Firenze sono collocate trentaquattro lapidi della Divina Commedia lungo le facciate di alcuni palazzi. Le citazioni delle terzine sono tratte dalle tre cantiche: 9 dall'Inferno, 5 dal Purgatorio e 20 dal Paradiso, esse passano in rassegna i principali eventi della città e dei suoi illustri cittadini. Le lapidi tracciano un vero e proprio percorso poetico sulle mura; il comune di Firenze incaricò degli illustri dantisti (tra di essi Isidoro del Lungo), nel 1900 di individuare, nelle terzine dantesche, le citazioni dirette alla città per riferimenti topografici e individuare con precisione quei luoghi che fossero adatti per posizionare tali lapidi. Il progetto fu realizzato in soli sette anni.
Attiro l'attenzione ( come ha attirato la mia ) sulla strana scritta sottostante uno stemma degli Uberti fiorentini , la mattonella si e' poi rivelata di fattura novecentesca Intanto non viene segnalato in alcun modo trattarsi di una riproduzione moderna Poi comporta un equivoco storico abbastanza importante foto di Francesco Bini per Wikipedia la scritta DEGLI UBERTI contrasta profondamente con l'evoluzione dei cognomi a Firenze La lapide avrebbe dovuto riportare la scritta UBERTI tale infatti dovrebbe essere il cognome evoluto dei FILIIS UBERTI o de UBERTI o de UBERTIS fiorentini Cosi lascia intendere che lo stemma sia di una famiglia cognominata DEGLI UBERTI mai esistita in Firenze ( non ci sono mai stati dei Degli Uberti ma degli Uberti Farinata era uno degli Uberti : cioe' Farinata degli Uberti non Farinata dei Degli Uberti
Questa lapide fa bella mostra di se nel cortile di Michelozzo in Palazzo vecchio a Firenze foto di Francesco Bini per Wikipedia
In via delle Oche a Firenze ad esempio figura un'altra lapide, della stessa serie ,che ricorda Dante e gli Adimari e giustamente la lapide riporta ADIMARI e non DEGLI ADIMARI foto di Francesco Bini per Wikipedia
E lo stesso abbiamo per gli altri stemmi della serie Abati, Gianfigliazzi, Tosinghi ...............: abolite le particelle DEGLI o DEI che in volgare dai tempi di Dante non hanno mai fatto parte del cognome fiorentino espresso in volgare
Il passaggio di un cognome dalla forma latina latina alla forma italiana in altri luoghi comporta degli adattamenti a volte anche importanti Ma Firenze e' il luogo dove si forma la lingua italiana e dove il volgare e' piu' simile all'italiano dei secoli successivi gia la prosa di Giovanni Villani o di Dino Compagni ci mostrano chiaramente come si doveva tener conto dei cognomi
Evoluzione del cognome fiorentino nei secoli...................Passaggio dalla forma originaria latina al cognome fiorentino
Vincenzo Borghini : scrive infatti giustamente Uberti non Degli Uberti sotto lo stemma che raffigura
UNA COSA CHE NON DOVREBBE ESSER PERMESSA MA ASSAI PIU' COMUNE DI QUANTO SI CREDA: RICOLLOCAZIONE
Citando uno stemma dei Savelli ( Stemma Savelli in Bassano in Teverina ) don Antonio Pompili esperto di araldica , operante sul forum IAGI scrive : Non sempre lo stemma che si trova sulla facciata o all'interno di un palazzo è segno di proprietà (passata o presente). Non sono rari casi di stemmi utilizzati come semplice materiale di recupero a scopo decorativo. Senza entrare nel merito dell'opportunità o meno di simili pratiche, quello che vediamo è un caso di stemma recuperato e ricollocato. E un sospetto può venire osservando i ganci metallici posti a sostegno del manufatto. Si tratta, come è evidente dello stemma Savelli, ma la famiglia non ha avuto alcun legame con il palazzo. "Palazzo dell'eredità (Via del Belvedere, 19) - Facciata (FOTO N.24) Lo stemma è stato acquistato presso un rigattiere dagli attuali proprietari del palazzo e collocato sopra il portone di accesso da pochi anni; è in marmo bianco, di forma gotica" ( Tratto da: Regione Lazio Assessorato ala Cultura - Associazione Intercomunale della Teverina per la Cultura, Stemmi e gonfaloni della Teverina, a cura di Massimo Fordini Sonni, Giancarlo Macculi, Laura Settimi (collana di storia, tradizioni, folclore, 3), Grotte di Castro (VT) 1993, p. 77.) In appendice fotografica dello stesso volume (p. 190) la foto n. 24 citata nel testo. Corrisponde all'immagine qui postata.
Questo non considerare i manufatti araldici come documentazione da tutelare mi turba Io debbo moltissimo all'araldica perche' dopo quasi 20 anni di ricerche l'unico documento che mi ha spiegato le origini dei Carnesecchi fiorentini e' una lapide sepolcrale in Santa Maria Novella a Firenze . Lapide databile 1340 circa e all'uso fiorentino piccolo albero genealogico Dice che quella e' la sepoltura di Piero di Durante di Ricovero e dei suoi discendenti. Sulla lapide lo stemma dei Carnesecchi quando ancora erano i Duranti ( quattro bande anziche' tre ) Nessun altro documento cartaceo dice questa cosa Ancora nel XIX secolo alcuni storici seguivano la lezione dell'Ammirato il giovane che diceva il Durante eponimo dei Carnesecchi come figlio di Buonfantino giudice La perdita' di quello stemma avrebbe rappresentato per me un ostacolo considerevole alle mie ricerche La perdita' di quello stemma avrebbe rappresentato una notevolissima perdita di conoscenze storiche e comunque un elemento perturbativo Buonfantino giudice io sostengo essere un Adimari , che si distacca dalla famiglia Adimari gia' negli anni immediatamente successivi agli Ordinamenti di Giustizia di Giano della Bella ) Comproverebbe quello che diceva il Villari , che da subito ci furono delle spaccature nelle famiglie magnatizie con scelte in senso popolare Quella lapide sepolcrale insomma ha un valore ed ha un valore dove e' collocata insieme con le lapidi con cui e' collocata Cosi come ogni stemma che anche poco documenta sempre qualcosa
Nello stesso Thread si dice : E' molto comune il riuso di stemmi. Per fare un esempio, in un edificio a lato della Scalinata della Trinita' dei Monti, vi e' posizionato uno stemma dei Malatesta molto bello che non ha nulla a che vedere con questo edificio,
DENUNCIA : VOLATILITA' DEI LINK DEI BENI CULTURALI, ED ALTRI Penso che a tutti noi sia capitato di ritornare su una pagina web che ci aveva interessato molto e non trovarla piu' Spesso i topic dei vari forum citano collegamenti ( link ) non piu' esistenti. Io sul mio sito ho risolto parzialmente il problema la dove e' possibile inglobando la pagina nel sito ma su pagine particolarmente complesse la cosa non funziona ed inoltre eticamente non e' una cosa che ritengo trasparente La cosa piu' penosa e' che nella maggior parte dei casi la sparizione dei link e' legata a Siti istituzionali ( Comuni , Provincie Regioni ) e ( peggio che mai ) del Ministero dei Beni culturali In cui nonostante mezzi economici notevoli si assiste ad un girotondo di link poco comprensibile che fa pensare alla completa mancanza di una regia indice di poca considerazione verso gli utenti, come se i link fossero solo di interesse dell'ente e non dell'utente. Questo e' un problema che io ritengo essenziale per le nostre materie e non solo Noi possiamo far crescere la considerazione della "Cultura" sul nostro modo di ricostruire la microstoria solo se imponiamo di darci il rispetto che meritiamo ok A scarsa o nulla considerazione degli utenti : sudditi non cittadini B speculazione : spreco soldi pubblici e comunque nostri Questi spostamento di siti hanno almeno due costi uno economico ed uno culturale la conoscenza e' spesso fatta di gradini Il concetto "l'ha detto lui" puo' ancora avere valore nella ricerca Ma sovente si corre il rischio di fare diventare un errore una verita' solo perche' tanti la ripetono acriticamente La fonte documentaria e' la base per le nostre ricerche Quando non possiamo fornire una fonte documentaria dobbiamo comunque fornire una fonte in letteratura per le nostre ipotesi o affermazioni in modo da non far da cassa di risonanza ad eventuali errori e che dia al lettore la possibilita' di rendersi conto dell'affidabilita' del ragionamento Oggi la letteratura comprende il web Una ricerca appoggiata ad un link che si volatilizza perde talvolta le fonti primarie e secondarie nel mio sito io sento particolarmente la necessita' di stabilita' e considero quindi la cosa un problema molto importante e sollevare il pb : un modo di difendere la cultura storica sempre piu' trascurata proprio da chi la dovrebbe difendere
|
