
contatti : pierluigi18faber@libero.it
ing.Pierluigi Carnesecchi
indice generale : http://www.carnesecchi.eu/indice.htm
CARNESECCHI : Storia del cognome " Carnesecchi "
“....Perché i figli salvano e tengono vivo il nome dei morti, come i sugheri, reggendo la rete, preservano il filo di lino dal fondo del mare..." ESCHILO, Coefore
PRECEDENTE : Storia dei Carnesecchi 1.1

............ CONTINUA A LEGGERE : Storia dei Carnesecchi 1.2
|
Guerra d'Italia del 1494
Preludio : Papa Innocenzo VIII, in conflitto con Ferdinando I di Napoli a causa del mancato pagamento di quest'ultimo delle quote papali, avava scomunicato il re di Napoli con una bolla dell'11 settembre 1489, offrendo il regno al sovrano francese Carlo VIII; nonostante nel 1492 Innocenzo, in punto di morte, avesse assolto Ferdinando, il regno rimase un pomo della discordia lanciato nelle politiche italiane. A questo si aggiunse la morte, quello stesso anno, di Lorenzo il Magnifico, Signore di Firenze e perno della stabilità politica della penisola.
La discesa di Carlo VIII Quando Ludovico Sforza, che aveva finalmente ereditato il Ducato di Milano (controllato già da tempo) nell'ottobre del 1494, si trovò opposto a Alfonso II di Napoli, nuovo re di Napoli, che rivendicava anch'egli il Ducato, il precario gioco di equilibri che aveva sino ad allora retto la pace in Italia crollò. Ludovico decise di rimuovere la minaccia al proprio trono incitando Carlo VIII di Francia, il quale già da tempo reclamava Napoli attraverso la linea angioina oltre che per effetto dell'offerta di Innocenzo, a raccogliere una grande armata, includendo nelle armi d'assedio, per la prima volta in Europa, anche l'artiglieria, e a marciare su Napoli. Carlo VIII invase così la penisola e, dopo aver facilmente sottomesso Firenze, nel febbraio 1495 giunse a Napoli, riuscendo a conquistarla senza ricorrere all'assedio.
La Lega di Venezia La velocità con cui i francesi avanzarono assieme alla brutalità dei loro attacchi sulle città, spaventarono gli altri stati italiani. Ludovico, capendo che Carlo aveva pretese anche sul Ducato di Milano e che non si accontetava con la sola annessione del Regno di Napoli, si rivolse al Papato. Coinvolto in un "potente gioco" tra la Francia e i vari stati italiani e intenzionato ad assicurare feudi secolari per i suoi figli, Papa Alessandro VI, salito al soglio pontificio il 31 marzo 1495 organizzò un'alleanza, conosciuta come la Lega Santa del 1495 o Lega di Venezia, composta da diversi oppositori dell'egemonia francese in Italia: il Papato, Ferdinando d'Aragona, il quale era anche Re di Sicilia, il Sacro Romano Imperatore Massimiliano I, gli Sforza di Milano e la Repubblica di Venezia; quest'ultimo stato vi fece ingresso apparentemente con lo scopo d'opporsi all'Impero Ottomano, mentre il suo reale obiettivo era l'espansione francese in Italia. Quest'alleanza, che s'impegnò per cacciare i francesi dalla penisola, riunì un'armata guidata dal condottiero Francesco II Gonzaga. Carlo, volendo evitare di rimanere intrappolato a Napoli, marciò verso la Lombardia, dove incontrò l'armata della Lega nella Battaglia di Fornovo il 6 luglio 1495. Anche se la sua sconfitta non fu decisiva, nel ritorno in Francia egli dovette abbandonare gran parte dei tesori conquistati durante la sua campagnia in Italia. Tornato in Francia, poco prima di morire, radunò nuovamente le sue forze e tornò in Italia.
da Wikipedia
|


|
L'ALBERO A CUI HO DECISO DI FARE RIFERIMENTO E' QUELLO CHE CHIAMERO' ALBERO PSEUDO--SALVIATI E' A QUESTO ALBERO CHE CONVIENE RAPPORTARE I DATI VIA VIA RACCOLTI
DATI DI ARCHIVIO ...........Albero Carnesecchi ……biblioteca BNC forse del Salviati molto interessante codice 225 tavola 26 il piu' completo e con scarsi errori . Comunque manca di alcuni individui
CON AGGIUNTA DI DATE
DATI DI ARCHIVIO ...........Albero Carnesecchi ……biblioteca BNC forse del Salviati molto interessante codice 225 tavola 26 il piu' completo e con scarsi errori . Comunque manca di alcuni individui
|
e' sicuramente l'albero piu' completo ed affidanbile ( in realta' mancano diversi individui e diversi rami )
|
CADUTA DELLA CASA DEI MEDICI
Storie Fiorentine dal 1378 al 1509 Francesco Guicciardini
Indro Montanelli
............La resa di Piero a Carlo VIII non era piaciuta ai Fiorentini Odiavano il figlio del Magnifico lo chiamavano "il fatuo" e con questo nomignolo anche la Storia lo adotto'. Ma forse Piero lo dovette solo alla sfortuna. Non aveva che venti anni quando gli piombo' sulle spalle una responsabilita' cui il padre non l'aveva preparato.Bel ragazzo dal corpo d'atleta , un po' bighellone e avventato , ma abbastanza colto grazie alla pedagogia del Poliziano,sapeva improvvisare versi con una certa facilita' e soprattutto era un campione nel gioco del calcio , nella sassaiola ,nella scherma e nella giostra. Tutto questo avrebbe potuto farne un idolo della sportiva gioventu' fiorentina , come gia' lo era stato suo zio Giuliano , assassinato dai Pazzi , se egli non vi avesse apportato una protervia che i suoi concittadini , con squisito patriottismo ,addebitavano al sangue romano di sua madre Orsini. All'opposto di suo padre Lorenzo gran maestro nell'arte di perdere, Piero voleva sempre vincere E questo gli valse un'aureola di alterigia ,ch'era proprio la piu' pericolosa in una citta' come Firenze dove il successo , per farsi perdonare , deve ammantarsi di modestia. I Medici avevano sempre praticato questa virtu' e proprio alla loro mancanza di ostentazione e alla semplicita' dei loro modi avevano dovuto la loro perdurante fortuna Piero faceva onesti sforzi per fingerla. Al re di Napoli che gli offriva un feudo ed un titolo nobiliare nel suo regno , rispose : io non sogno degno di si grande onore , ne' voglio essere barone . La risposta fu apprezzata in quella citta' borghese. Ma fu addebitata piu' all'orgoglio che all'umilta' Erano tuttavia difetti di gioventu' da cui avrebbe potuto emendarsi , se ne avesse avuto il tempo Ma gli eventi lo misero subito di fronte a una situazione che sarebbe stata un duro banco di prova anche per il padre Lorenzo e per il bisnonno Cosimo
Indro Montanelli
alla notizia della calata dei Francesi invece di prepararsi alla difesa cerco' di comprare la pace con Carlo VIII con duecentomila fiorini e con la cessione di alcune fortezze e della citta' di Pisa Ma i Fiorentini non gradirono la sua vigliaccheria e cosi' Piero tornando da Sarzana dove si era accordato con Carlo VIII trovo la citta' ostile contro di lui
XI
CONDOTTA POLITICA DI PIERO DE' MEDICI. DISCESA Dl CARLO VIII. FUGA DI PIERO DA FIRENZE (1494).
1494 : Erano in Firenze Lorenzo e Giovanni figliuoli di Pierfrancesco de' Medici, giovani ricchissimi e di gran benivolenzia col popolo per non avere maneggiato cose che dispiacessino; e' quali non sendo bene contenti di Piero, massime Giovanni che era di natura inquietissimo e sollevava Lorenzo uomo bonario, cominciorono a tenere qualche pratica col signore Lodovico per mezzo di Cosimo figliuolo di Bernardo Rucellai, el quale, inimico di Piero, si era partito di Firenze. E sendo in su' princípi, e non avendo ancora trattato cosa di importanza, venuta la cosa a luce, di aprile nel 94 furono tutt'a due sostenuti; e poi che ebbono aperto quello che avevano, benché Piero fussi malissimo disposto con loro, nondimeno non concorrendo a insanguinarsi e' cittadini dello stato furono liberati e confinati fuori di Firenze alle loro possessioni a Castello, e Cosimo Rucellai assente ebbe bando di rubello. Ed in quegli medesimi dí entrorono in Firenze quattro imbasciadori franzesi, e' quali andavano a Roma, ed esposono per transito la deliberazione del re e gli apparati faceva per passare in Italia, richiedendo la città lo favorissi o almeno gli concedessi per le sue gente passo e vettovaglia. Fu per voluntà di Piero, che per intercessione degli Orsini si era tutto dato al re di Napoli, contro al parere di tutti e' savi cittadini, negato l'uno e l'altro, pretendendo non poterlo fare per la lega vegghiava ancora col re Alfonso, e ribollendo ogni dí le cose, furono mandati dalla città imbasciadori a Vinegia Giovan Batista Ridolfi e Paolantonio Soderini, per intendere la intenzione loro circa a questi movimenti e persuadere loro non volessino lasciare andare innanzi la ruina di Italia. E cosí ogni dí piú la città si scopriva per Napoli contro a Francia, con dispiacere universale del popolo, inimico naturalmente della casa di Ragona ed amico di Francia, contro alla voglia ancora de' cittadini dello stato, e' quali vedendo Piero tanto ostinato a questa via non si ardivano contradirgli; e massime che messer Agnolo Niccolini e quegli piú suoi intrinsechi, parlavano sempre nella pratica sanza rispetto per questa parte. Aveva Piero fatto una pratica stretta di cittadini, co' quali si consultavano queste cose dello stato: messer Piero Alamanni, messer Tommaso Minerbetti, messer Agnolo Niccolini, messer Antonio Malegonnelle, messer Puccio Pucci, Bernardo del Nero, Giovanni Serristori, Pierfilippo Pandolfini, Francesco Valori, Niccolò Ridolfi, Piero Guicciardini, Piero de' Medici ed Antonio di Bernardo; a' quali tutti, da pochi in fuora, dispiaceva questa risoluzione, nondimeno sendo favorita da' piú intrinsechi, non si opponevano, eccetto qualche volta e non molto Francesco Valori e Piero Guicciardini. Ma perché Piero in spirito intendeva quanto la sodisfacessi, non conferiva loro tutte le lettere e gli avisi, ma solo quelle cose che diminuivano ed erano in disfavore del re di Francia, el quale tutto dí si metteva in ordine, ed a Genova per conto suo si armavano legni e se ne faceva scala della guerra. Per la qual cosa el re Alfonso, considerando di quanto momento sarebbe el levargli la oportunità di Genova, avendo spalle da alcuni fuorusciti genovesi, fece impresa mutare lo stato di Genova e mandò a Pisa don Federigo suo fratello con una grossa armata; el quale di poi andato a porto Spezie e messo gente in terra, furono quegli che scesono ributtati e rotti; di che don Federigo, non riuscendo la impresa, si ritornò a Pisa. E parendo al re ed a Piero che el tenere bene guardata Serezzana, rispetto allo essere el passo fortissimo, impedissi al re Carlo potere passare da quelle parte, per tòrgli ancora el passo di Romagna, mandorono Ferrando duca di Calavria, primogenito del re, in Romagna con uno esercito grosso, acciò che colle spalle di Cesena, terra della Chiesa, e di Faenza, che era nella nostra raccomandigia, si opponessi a' franzesi. Nel qual tempo el re Carlo, desideroso passare pe' terreni nostri pacificamente, mandò di nuovo uno oratore a Firenze a richiedere del passo, promettendo largamente amicizia e tutti e' favori e commodità potessi fare alla città; la quale cosa sendo pure rifiutata, cacciò del regno suo tutti e' mercatanti nostri. Né per questo si raffreddava la ostinazione di Piero; anzi parte mosso dalla amicizia teneva col re Alfonso e cogli Orsini, parte insospettito dal signore Lodovico, con favore di chi el re Carlo passava, e perché Lorenzo e Giovanni di Pierfrancesco erano partitisi da' confini e rifuggitisi a lui, ogni dí perseverava nella ruina sua, ed attendendo a fortificarsi e fare capo grosso a Pisa per rispetto di Serezzana e di quella banda, vi furono mandati commessari generali per conto di tutta la guerra, Pierfilippo Pandolfini e Piero Guicciardini. Era una parte dello esercito del re Carlo poco innanzi passate l'Alpe, e da poi lui personalmente col resto dello esercito venutone in Italia; nel quale era grandissimo numero di uomini d'arme, fanterie ed artiglierie, ma quanto non so el particulare. Ed era entrata in Italia una fiamma ed una peste che non solo mutò gli stati, ma e' modi ancora del governargli ed e' modi delle guerre, perché dove prima, sendo divisa Italia principalmente in cinque stati, papa, Napoli, Vinegia, Milano e Firenze, erano gli studi di ciascuno per conservazione delle cose proprie, vòlti a riguardare che nessuno occupasse di quello d'altri ed accrescessi tanto che tutti avessino a tèmerne, e per questo tenendo conto di ogni piccolo movimento che si faceva e faccendo romore eziandio della alterazione di ogni minimo castelluzzo, e quando pure si veniva a guerra erano tanto bilanciati gli aiuti e lenti e' modi della milizia e tarde le artiglierie, che nella espugnazione di uno castello si consumava quasi tutta una state, tanto che le guerre erano lunghissime ed e' fatti d'arme si terminavano con piccolissima e quasi nessuna uccisione Ora per questa passata de, franciosi, come per una subita tempesta rivoltatasi sottosopra ogni cosa, si roppe e squarciò la unione dl Italia ed el pensiero e cura che ciascuno aveva alle cose communi in modo che vedendo assaltare e tumultuare le città, e' ducati ed e' regni, ciascuno stando sospeso cominciò attendere le sue cose proprie né si muovere per dubitare che uno incendio vicino, una ruina di uno luogo prossimo avessi a ardere e ruinare lo stato suo. Nacquono le guerre subite e violentissime, spacciando ed acquistando in meno tempo uno regno che prima non si faceva una villa; le espugnazione delle città velocissime e condotte a fine non in mesi ma in dí ed ore, e' fatti d'arme fierissimi e sanguinosissimi. Ed in effetto gli stati si cominciorono a conservare, a rovinare, a dare ed a tôrre non co' disegni e nello scrittoio come pel passato, ma alla campagna e colle arme in mano. Sceso el re in Italia e venendone a Milano, el signore Lodovico, benché fussi passato per introdotto suo e fussi in amicizia seco, nondimeno considerando la infidelità de' principi e massime de' franzesi, e' quali per gli utili e commodi loro tengono poco conto della fede e dell'onore, cominciò a dubitare che el re sotto ombra di volere che lo stato fussi liberamente in mano del duca Giovan Galeazzo suo nipote, non lo levassi di quello governo a qualche suo proposito; per tòrgli ogni occasione di nuocere, gli dette el veleno. Del quale sendo morto lo innocentissimo giovane, fatti subito ragunare e' cittadini di Milano, sendovi alcuni che per suo ordine lo proposono, fu eletto duca, benché del signore morto rimanessi uno piccolo e bellissimo fanciullo. Entrato di poi el re Carlo in Milano e quivi ricevuto onoratissimamente, se ne venne per la via di Pontriemoli con una parte dello esercito alla volta di Lunigiana, avendone mandate una altra in Romagna a rincontro del duca di Calavria; e perché el castello di Serezzana era fortissimo e bene fornito di artiglierie e di tutte le cose necessarie da difesa, per non vi perdere tempo voltosi verso Fivizzano lo prese e saccheggiò con uno grandissimo terrore di tutta quella provincia. A Firenze erano le cose condizionate e disposte male, e lo stato di Piero molto indebolito; ed el popolo vedendosi tirata adosso una guerra potentissima e da non potere reggere, sanza bisogno e necessità alcuna, anzi per favorire e' ragonesi che erano universalmente in odio, contro a' franzesi amati assaí nella città, sparlava publicamente di Piero, massime sapendo essere state deliberazione sua contro la volontà de' primi cittadini dello stato. Aggiugnevasi in genere tutte quelle cagione che fanno e' popoli inimici de' grandi, el desiderio naturale di mutare le cose, la invidia ed el carico di chi aveva maneggiato, inoltre tutti coloro che erano inimici e tenuti sotto dallo stato, risentitisi e venuti in speranza che la città tornassi alla libertà antica, e loro avessino a essere nel grado giudicavano meritare, facevano piú pericolosa questa male disposizione. Concorrevaci che e' governi di Piero in sé, e la natura sua era di qualità, che non solo era in odio agli inimici, ma ancora dispiaceva agli amici, e quasi non la potevano sopportare; lui uomo altiero e bestiale e di natura da volere piú tosto essere temuto che amato, fiero e crudele, che a' suoi dí aveva di notte dato delle ferite e trovatosi alla morte di qualche uomo; sanza quella gravità che si richiedeva a chi fussi in tale governo, conciosiaché in tanti pericoli della città e suoi propri stava tutto dí nelle vie publicamente a giocare alla palla grossa; di natura caparbio, e che non si intendendo delle cose, o voleva governarle secondo el cervello suo, credendo solo a se medesimo, o se prestava fede e si consigliava intrinsecamente con persona, non erano quegli cittadini che avevano esperienzia delle cose della città, e governatola lungo tempo, ed erano tenuti savi, ed avevano interesse nel bene e nel male publico, e naturalmente erano amici di lui, del padre e della casa sua, ma con ser Piero da Bibbiena, con messer Agnolo Niccolini e simili uomini ambiziosi e cattivi, e che lo consigliavano in tutte le cose secondo che ciecamente erano traportati dalla ambizione e le altre cupidità, e per compiacerlo ed essergli piú cari, lo indirizzavano el piú delle volte per quella via per la quale lo vedevano inclinato e vòlto. E però, trovandosi Piero in gran pericolo per el disordine di fuori e la male disposizione di drento, si risolvé essergli necessario accordarsi con Francia, giudicando quello che era vero che posata bene questa parte, ognuno nella città per timore o altro si rassetterebbe, e seguitando adunche, benché in diversi termini e poco a proposito, l'esemplo del padre Lorenzo quando andò a Napoli, una sera furiosamente accompagnato da Iacopo Gianfigliazzi, Giannozzo Pucci ed altri amici suoi, se ne andò a Serezzana a trovare el re, dove era venuto da Milano el duca Lodovico. Quivi doppo molte pratiche e ragionamenti si conchiuse di dare in mano del re per sua sicurtà le fortezze di Pisa, di Serezzana, di Pietrasanta e di Livorno; e di subito gli furono sanza altra licenzia della città e sanza e' contrasegni, consegnate quelle di Serezzana e Pietrasanta da Piero di Lionardo Tornabuoni e Piero di Giuliano Salviati. A Firenze in sulla partita di Piero avendo ognuno preso animo e licentia, non solo si continuava ed accrescevasi nello sparlare publicamente, ma ancora si cominciorono in palagio a risentire e' cittadini fra' quali messer Luca Corsini (che era de' signori e stato fatto da Piero, come confidato e sfegatato dello stato, per rispetto di Piero Corsini suo fratello) ed Iacopo di Tanai de' Nerli e Gualterotto Gualterotti che erano gonfalonieri di compagnia, messi su, come si crede, da Piero Capponi che era inimicissimo del governo, cominciorono nelle pratiche a dire male di Piero, e che la città sotto la cura sua rovinava, e che sarebbe bene levarla di mano sua e della tirannide e restituirla a uno vivere libero e popolare. E di poi sentendosi le convenzione di dare quelle terre in mano del re, e di già essere data Serezzana, si cominciò a gridare per la città che le si dessino in nome del publico e non del tiranno, e però si elesse imbasciadori, che subito cavalcorono al re, fra Ieronimo Savonarola da Ferrara, che predicava in Firenze e di chi di sotto si dirà, Tanai de' Nerli, Pandolfo Rucellai, Pier Capponi e Giovanni Cavalcanti. Era gonfaloniere di giustizia Francesco dello Scarfa, ed e' signori, uomini tutti stati scelti per amici grandi ed affezionati del reggimento; e nondimeno messer Luca si era apertamente scoperto inimico, e con lui concorreva Chimenti Cerpellone, ed el gonfaloniere pareva uomo da lasciare correre. Da altra parte Antonio Lorini, Francesco d'Antonio di Taddeo e Francesco Niccolini favorivano vivamente la causa di Piero; in modo che, sendo una sera venuti a parole, messer Luca corse furiosamente a sonare la campana grossa a martello, e sendo ritenuto da chi gli corse drieto, non poté sonare piú che due o tre tocchi, e' quali sendo uditi per la terra, che era circa a tre ore di notte, el popolo tutto corse in piazza, e di poi non sentendo piú sonare né suscitare in palagio o fuori movimento alcuno, ognuno non bene sapendo quello fussi stato, si ritornò a casa. E cosí stando la città sospesa ed alterata, Piero avendo aviso dagli amici sua come le cose in Firenze transcorrevano troppo, e che ognuno per la assenzia sua aveva preso animo e baldanza, presa licenzia dal re, se ne tornò a Firenze a dí 8 di novembre. Tornata molto dissimile da quella di Lorenzo suo padre quando tornò da Napoli, che gli andò incontro tutto il popolo della città e fu ricevuto con somma letizia, recandone seco la pace e la conservazione dello stato della città, a Piero non andò incontro se non pochi amici sua, e fui ricevuto con poca allegrezza, tornando massime sanza conclusione ferma, se non di avere diminuito e smembrato Pisa e Livorno, occhi principali dello stato nostro, e Pietrasanta e Serezzana acquistate da suo padre con grandissima spesa e gloria. Tomato, andò subito a visitare la signoria, e riferito generalmente quello aveva fatto, gli inimici sua e quegli si erano scopertigli contro, entrati in grandissimo timore, si risolverono che bisognava giucare del disperato. In modo che el giorno sequente, a dí di novembre 1494, che era el dí di san Salvadore, sendosi inteso che el signore Paolo Orsino, nostro soldato, con cinquecento cavalli era venuto alle porte per essere a' favori di Piero, ed essendo la maggiore parte della signoria volta contro a Piero, Iacopo de' Nerli con alcuni altri collegi che lo seguitavano, armato era ito in palagio, e fattolo serrare, si stava a guardia della porta, quando Piero per riscaldare gli amici aveva in palagio, e credendo nessuno avessi animo di vietargli lo entrare, cogli staffieri sua e gran numero di armati, armato ancora egli, benché sotto el mantello, ne venne al palagio; e quivi sendogli risposto che se voleva entrare entrassi lui solo e per lo sportello, sbigottito vedendosi perduto lo stato, si ritornò a casa. Dove come fu giunto, intendendo che e' signori inimici sua chiamavano el popolo, e come el popolo si cominciava a levare gridando: "viva popolo e libertà", e di poi sendogli per uno corriere de' signori notificato come e' signori l'avevano fatto rubello al quale partito concorsono gli amici sua per paura e quasi sforzati per conforto di chi gli era apresso, montato a cavallo prese la via di Bologna. Uditosi Piero essere stato ributtato dal palagio, si mosse solo in suo favore el cardinale e Pierantonio Carnesecchi e' quali con armati ne vennero verso piazza; ma di poi intendendo che el popolo multiplicava contro a Piero e che lui era stato fatto rubello e si partiva, ognuno si ritirò a casa, ed el cardinale in abito di frate si uscí sconosciuto di Firenze; cosí si fuggí Giuliano loro fratello ser Piero da Bibbiena e Bernardo suo fratello, e' quali erano in odio grandissimo del popolo. Giunse in questo tumulto in Firenze Francesco Valori, el quale tornava dal re, dove di nuovo era stato mandato con piú altri cittadini imbasciadore, e perché gli era in somma benivolenzia del popolo sendo sempre stato uomo netto ed amatore del bene, ed avendo fama di essersi opposto a Piero, fu ricevuto con grandissimo gaudio di tutto el popolo, e portatone in palagio quasi di peso in sulle spalle de' cittadini. Corse di poi el popolo furiosamente a casa Piero e la mandò a sacco e di poi voltosi a casa Antonio di Bernardo e ser Giovanni da Pratovecchio notaio delle riformagioni, le saccheggiò ed arse; e loro, benché si fussino nascosti per le chiese e pe' conventi, pure ritrovati alla fine ne furono menati presi al bargello. Corsono di poi a casa messer Agnolo Niccolini, e già avendo messo fuoco alla porta, l'arebbono arsa, se non che messer Francesco Gualterotti ed alcuni uomini da bene dubitando che questa licenzia non troscorressi troppo, còrsivi raffrenorono la moltitudine e la ridussono in piazza che con grandissime voce gridava: "viva el popolo e la libertà"; e quivi per commessione della signoria messer Francesco Gualterotti, salito in sulla ringhiera, notificò essere state levate via le monete bianche. Veduto spacciato lo stato di Piero vennono in piazza a cavallo con compagnia di armati, Bernardo del Nero e Niccolò Ridolfi, gridando: "popolo e libertà"; ma ributtati e cacciati come sospetti e con pericolo di essere morti se ne ritornorono a casa, e la sera per piú loro sicurtà accompagnati bene per commessione della signoria ne vennono in palagio, e cosí Pierfilippo Pandolfini, el quale la sera era tornato da Pisa partitosi sanza licenzia, o perché dubitassi delle cose di Pisa, o perché, avendo inteso a Firenze sparlarsi assai di lui, volessi provedere el meglio poteva a' fatti suoi. Messer Agnolo Niccolini, uno ancora egli degli imbasciadori al re parendogli Piero fussi spacciato, e dubitando di Lorenzo e Giovanni di Pierfrancesco, de' quali era stato inimicissimo e concitatore di Piero contro a loro, partitosi da Pisa e presa la volta per la montagna di Pistoia, ne andò in Lombardia. E cosí cacciato Piero e quietato un poco el tumulto, benché el dí e la notte el popolo stessi armato a guardia della città, si deliberò dalla signoria, che si sospendessi l'uficio degli otto della pratica e de' settanta, e non si potessino ragunare insino a tanto si deliberassi altro. El medesimo dí di san Salvadore, a dí 9 di novembre, el re Carlo avendo ricevute le fortezze di Livorno, Pietrasanta e Serezzana, entrò in Pisa e gli furono consegnate le cittadelle; le quali, secondo le convenzione, avessino a stare in mano del re per sua sicurtà, e nondimeno e' corpi di Pisa e delle altre terre s'avessino come prima a tenere e governare da' fiorentini. Ma la sera medesima ristrettisi insieme e' pisani, andorono a chiedere al re rendessi loro la libertà; la quale sendo conceduta gridando "libertà" andorono per fare villania agli uficiali fiorentini, e' quali, udito el tumulto, si erano raccolti insieme e fuggiti nel banco de' Capponi Tanai de' Nerli, Piero Capponi, Piero Corsini e Piero Guicciardini ed alcuni altri; e quivi avendo avuta una guardia del re, si salvorono dalla malignità e perfidia de' pisani. E vedendo la città al tutto ribellata e, partendosi el re, non vi potere stare sicuri, el dí seguente con lui si partirono e lasciatolo per la via, ne vennono a Firenze. Cosí el medesimo giorno di san Salvadore ebbe dua grandissimi accidenti: la mutazione dello stato nostro e la ribellione di Pisa, le piú principali cose si potessino alterare nello essere nostro. Fu certo cosa mirabile che lo stato de' Medici che con tanta autorità aveva governato sessanta anni e che si reputava appoggiato dal favore di quasi tutti e' primi cittadini, sí subitamente si alterassi per le mani di messer Luca Corsini ed Iacopo de' Nerli, uomini giovani, sanza credito, sanza autorità, sanza consiglio e leggierissimi. La quale cosa non nacque peraltro se non che e' modi ed e' portamenti di Piero e la insolenzia di chi gli era apresso, avevano tanto male disposto gli animi di tutti; e sopra tutto l'aversi recato adosso pazzamente una guerra potentissima e che non si poteva sostenere, e l'avere messo a scotto ed in preda sanza bisogno di cagione alcuna tutto lo stato nostro, che chi si gli scoperse da prima contro trovò la materia disposta in forma che, come gli fu dato principio di muoverla, fece da se medesima. Questo fine ebbe e cosí perdé lo stato la casa de' Medici, casa nobilissima richissima e riputatissima per tutta Italia, e per l'adrieto assai amata nella città, e' capi della quale, massime Cosimo e Lorenzo, avevano con grandissime difficoltà, con grandissime virtú, con tempo ed occasione, fatto conservato ed augumentato lo stato, accrescendo non solo lo stato loro privato, ma eziandio lo imperio publico della città, come fu el Borgo a San Sepolcro, Pietrasanta e Serezzana, Fivizzano e quella parte di Lunigiana, el Casentino, lo stato di Pietramala e Val di Bagno, tutte cose pervenute nella città sotto el governo di quella casa. La quale a ultimo rovinò in brevissimo tempo sotto el governo di un giovane temerario, el quale si trovò in tanti fondamenti di potenzia ed autorità, e sí bene favorito ed appoggiato, che se non si fussi sforzato ed avessi fatto a gara di perdergli, era impossibile non si conservassi; dove la sua pazzia non solo rovinò sé, ma eziandio la città, spogliandola in otto giorni di Pisa, Livorno, Serezzana e Pietrasanta luoghi donde come poi hanno meglio mostro gli effetti, si traeva la potenzia, la sicurtà, la autorità e gli ornamenti nostri. In modo che si può dire che uno di solo cancellassi, anzi lungamente contrapesassi ed avanzassi a tutti e' benefíci che la città nostra aveva mai in tempo alcuno ricevuti da quella casa; perché la perdita massime di Pisa fu sí grande e di sí inestimabile danno alla città, che molti hanno dubitato quale fussi maggiore nel dí di san Salvadore, o l'acquisto della recuperata libertà o la perdita di Pisa; in che, pretermettendo molti discorsi si potrebbono fare, voglio conchiudere aversi tanto piú da stimare l'una cosa che l'altra, quanto egli è piú naturale agli uomini cercare prima avere libertà in se proprio, che imperio in altri; massime che, parlando veramente, non si può dire avere imperio in altri chi non ha libertà in sé. Cacciato Piero, furono per partito della signoria rimessi tutti e' cittadini stati confinati e cacciati per conto di stato dal insino a dí 34 di novembre 1494; le quale cose benché rallegrassino ognuno, erano nondimeno sí pericolosi gli accidenti che andavano atorno, che gli animi non potevono gustare questi piaceri. E certo io credo che già un grandissimo tempo la città non fussi stata in maggiori travagli: drento, cacciata una casa potentissima e che sessant'anni aveva avuto el governo, e rimesso tutti gli inimici di quella; per la quale mutazione rimanevano alterati tutti e' modi del governo, stavano in sommo timore tutti quegli che avevano avuto autorità a tempo di Lorenzo o di Piero, tutti quegli e' quali, o e' maggiori loro, avevano in tempo alcuno offesi gli usciti o e' sua antecessori, tutti quegli che o per compere o per vie di pagamento o di rapine possedevano de' beni di chi era stato rubello; di fuori, smembrato tanto stato e quasi la piú parte del nostro dominio, donde si vedeva la città avere a restare indebolita con meno entrate e forze e con una guerra difficilissima e pericolosissima non solo co' pisani, ma con molti ci impedirebbono la recuperazione. Aggiugnevasi in su e' nostri terreni un re di Francia con tanto esercito, inimico ed ingiuriato da noi, pieno di cupidità e crudeltà, el quale dava timore non solo di guastarci el paese nostro, di fare; ribellare el resto delle terre suddite, ma etiam di saccheggiare la città, di rimettere Piero de' Medici e forse insignorirsi di Firenze el quale se si partissi, el meno male si potessi temere era avergli a dare una somma grandissima di danari ed a votare la città delle sustanzie e sangue suo.
Era il 1494 ed erano passati solo 60 anni dall'inizio della prevalenza medicea su Firenze con Cosimo il vecchio nel 1434 Probabilmente a Firenze non si sarebbe piu' parlato dei Medici se non fosse poi avvenuta l'ascesa al soglio pontificio prima di Leone X poi di Clemente VII
Nel Novembre 1494 questa era la Signoria in carica che diede il bando a Piero dei Medici
Gonfaloniere : Francesco di Martino dello Scarfa Priore : Giovanni di Francesco Lippi Priore : Luca di Bertoldo Corsini Priore : Filippo di Niccolo Sacchetti Priore : Francesco di Otto Niccolini Priore : Chimenti di Francesco Priore : Giuliano di Nofri Lenzoni Priore : Francesco di Antonio Taddei Priore : Antonio di Giovanni Lorini
|
|
storiaaristocraziafiorentina
UNA NOTIZUOLA : GISMONDO DI FRANCESCO
As early as October 4th the King asked for permission to enter Florence with his troops.11 The Signoria withheld a definite answer. But after threats of sack and worse the Signoria by the end of the month had already resigned itself to the inevitable. On November 5th, when Piero was still in Pisa, the Signoria elected new ambassadors to the King. The populace was in tumult. Savonarola urged them to remain peaceful during the bloodless revolution..12 While Piero, followed shortly after by Savonarola and other Florentine emissaries13, storiaaristocraziafiorentina bargained with the King, plans were well underway for the mo- narch’s arrival. As P'rench agents went about the city requisitioning quarters for the great army, the comunal office of the “Camera deH’Arme” undertook to organize the festivities.14 Officials were chosen from each of the city wards to supervise the preparations.15 The route of the King’s projected march through Florence was from the point of entry at Porta San Frediano to the Medici palace via the Ponte Vecchio, Piazza Signoria, and the Cathedra!. Ornament was concentrated at key points. On November 6th payments were made to two painters, Antonio di Jacopo and Andrea di Salvi113, for Ornament at Porta San Frediano.17 The decoration here included two grandstands, one outside and one within the gate, which were hung with tapestries, painted cloths, and sheltered by baldachins.18 The gate itself was hung with garlands and painted with coats of arms.19 A silken baldachino was prepared for the King by Filippo di Giuliano. He also painted blue banners which bore the King’s crest of three lilies sur- mounted by a crown.20
15 Ibid., folio 1 recto, lists the officials according to wards; for Santo Spirito : Tomaso di Jacopo Guidotti, Niccholo d’Alessandro Machiavelli, Pier Franciesco di Giorgio Ridolfi; for Santa Croce : Giovanni di Jachopo Chorsi, Antonio di Giovanni Guigni, Zanobi di Bartolomeo del Zacharia; for Santa Maria Novella : Giuliano di Jacopo Massingbi, Salvestro di Domenicho Federighi, Alessandro D’Andrea di Marietto; for San Giovanni : Gismondo di Francesco Charnesecchi; Proveditore : Nicholaio di Bernardo Cianpelli; Chanceliiere : Ser Giuliano di Ser Domenco da Ripa; Charmarlingo : Alessandro di Nicholo Machiavelli.
BY Eve Borsook : DECOR IN FLORENCE FOR THE ENTRY OF CHARLES VIII OF FRANCE
CARLO CARNESECCHI a Costantinopoli
Spesso le rimesse venivano realizzate contemporaneamente in moneta, metallo prezioso e monili; se poi le somme da recapitare a Firenze erano particolarmente alte si distribuivano tra più operatori addetti al trasporto. Ne è un esempio l’invio disposto nel 1525 da Antonio Gerini a favore di Matteo Botti e dei Capponi di Firenze, per un valore di 18.766 aspri. Carlo Carnesecchi ebbe in consegna 3 verghe d’oro del peso di 129 miticalli e 1/3 (620,8 grammi); tramite Lorenzo Balducci se ne recapitarono 8 pezzi di 121 miticalli (580,8 grammi) e 175 ducati d’oro; per Tommaso Scarlatti si mandarono invece 2 catene, 2 anelli e 2 «smaniglie» (141 grammi complessivi), 180 ducati di Aleppo e 50 ducati d’oro di peso. A.S.FI, Libri di commercio e di famiglia, 712, Firenze-Pera, Matteo Botti ad Antonio Gerini, 27 ottobre 1529, c. 37v. Il miticallo era un’unità di peso, usata per le merci preziose, pari a 4,8 grammi. A. MARTINI, Manuale di metrologia, ossia misure, pesi e monete in uso attualmente e anticamente presso tutti i popoli, Roma 1976, p. 179.
by Angela Orlandi Oro e monete da Costantinopoli a Firenze in alcuni documenti toscani (secoli XV-XVI)
E' lo stesso Carlo Carnesecchi di Cristofano di Bernardo ( nato 1464 ) ottimate fiorentino filomediceo testimone della profezia sulla morte di Lorenzo il magnifico da parte del Savonarola
Andrea Carnesecchi di Paolo ……….Andrea di Paolo Carnesecchi Emino di Costantinopoli
1474 Cosimo di Simone Greve in Chianti
Cosimo Carnesecchi di Simone ……….La galera di Cosimo Carnesecchi viene catturata dai pirati turchi
LEONARDO DI CRISTOFANO DI BERNARDO ( della linea di Bernardo di Cristofano )
Leonardo di Cristofano copia il Driadeo di Luca Pulci ( il Driadeo e ' di Luca Pulci non del fratello Luigi Pulci , piu' noto ) Il Driadeo , poema in ottava rima di Luca Pulci. Precede il poema una lettera in prosa dell'autore a Lorenzo de' Medici : indi segue l'invocazione , compresa in sei ottave , la prima delle quali cosi comincia : ecielso olimpio o bel fiume di santo. Del poema poi , che e' diviso in quattro parti , o canti , ed ha innanzi il seguente titolo : Inchomincia la prima parte del driadeo chompilato per Lucha Pulcro al mangnifico Laurenzio de Medici ec…, e' questo il principio: Poiche' la tema del grieve martoro La quarta parte termina col verso : che dietro allume vostro in tenebre ambulo. E sotto di essa e' la nota : questo libro e di me Lonardo di Cristofano Carnesecchi e scripto di mia propria mano , chominciato adi XV novembre effinito q…. di xv di decembre 1478 Lonardo e' figlio di Cristofano il Gonfaloniere di Giustizia del 1479 ( Cristofano muore in carica il 24 settembre 1479 ) Codice cartaceo in 4 , del secolo XV , di carte scritte , con un fregio a colori alla faccia verso della terza carta , dove il poema contenutovi principia , e appie' di essa l'arme dei Carnesecchi di Firenze
ERRATA CORRIGE
“Bodleian Library Catalogues. “
Il nome “Lonardo” quindi compare in: “A. Mortara, Catalogo dei manoscritti italiani che sotto la denominazione di Codici Canoniciani Italici si conservano nella Biblioteca Bodleiana a Oxford, Quarto Catalogues XI, 1864”
Tuttavia, il nome del copista è stato identificato come "Bernardo" nei successivi cataloghi cartacei e online: “Bodleian Library, J. J. G. (Jonathan James Graham) Alexander, and Otto Pächt. Illuminated Manuscripts In the Bodleian Library, Oxford. Oxford: Clarendon P., 1966- 73.”(Pächt and Alexander vol.ii, manuscript number 311) CatalogoCatalogo
......questo libro e di me Bernardo di Cristofano Carnesecchi e scripto di mia propria mano , chominciato adi XV novembre effinito q…. di xv di decembre 1478 , compare nel verso del foglio 65 “MS. Canon. Ital. 45, fol. 65 verso”. Quindi non Leonardo di Cristofano ma bensi Bernardo di Cristofano Infatti Leonardo di Cristofano non compare in alcun altro luogo se non nella citazione del Mortara che era comunque credibile perche' Cristofano aveva un fratello con questo nome Ho fatto questo errore seguendo l'ipotesi del Mortara ed inserendo Leonardo nelle genealogie ( Leonardo e' comunque nello stock onomastico dei Carnesecchi fiorentini ) Il fatto e' che i battesimi del Duomo non sono cosi completi come si pensa . Basandomi su questa incompletezza ho costruito le genealogie accettando anche attestazioni di studiosi Fatto salvo il sito ( pur con tutte le sue imperfezioni ) esiste pochissimo sulle genealogie dei Carnesecchi ( salvo un albero quasi sconosciuto attribuito al Salviati –anche questo con piccoli errori ) Quindi il Mortara non aveva grandi riferimenti genealogici su cui contare
|
|
storiaaristocraziafiorentina
Gli archivi di tutta Europa ed anche del Nuovo Mondo sono pieni di documenti sconosciuti sui commerci dei mercanti italiani In particolare documenti su compagnie fiorentine Documenti in cui i cognomi compaiono modificati ed adattati alla lingua del posto Vi e' quindi spazio per molto lavoro Ognuno di questi mercanti e' presente in molti luoghi d'Europa trattando le merci piu' diverse o con prestiti piu' o meno rischiosi
particolare Castello di Poppi: Amerigo di Simone Carnesecchi
CARNESIK
Amerigo di Simone di Paolo e' un mercante fiorentino molto attivo alla fine del XV secolo , lo troviamo comparire qui e la per l' Europa e qui e la per Firenze impegnato in varie imprese e con alterne fortune Merita qui la citazione la sua presenza a Southampton ( England ) nel 1478 Southampton Record Society : Publications of the Southampton Record Society H.M. Gilbert & Son, 1938 They did not touch at Southampton on the outward journey but both of them, Armaregi Carnesik and Johannes Symond Tornabone, patrons, arrived at Southampton from Flanders on 19 June 1478 and left again for Florence on 17 August [58, ... ………….Le ultime due galere fiorentine registrate a Southampton furono quelle di Armaregi Carnesik (Amerigo Carnesecchi) e di Johannes Symond Tornabone ( Giovan Simone Tornabuoni o Giovanni di Simone Tornabuoni ) Suggestiva e' la deformazione del cognome Carnesecchi in CARNESIK fatta dagli inglesi
Suggestiva perche' sicuramente cognomizzazione infatti dallo stesso libro si ricava la presenza anche di un non meglio identificato Lorenzo Carnesecchi : Lawrence Carnesik
Che ci induce a pensare che l'attuale cognome Carnesik possa anche avere a che fare con qualcuno che originariamente avrebbe potuto chiamarsi Carnesecchi
Amerigo compare in relazione d'affari con Napoli ( insieme ad altri fiorentini ) Tesi di dottorato di Alessandro Sansoni: Francesco Coppola imprenditore nella Napoli aragonese
Amerigo compare in relazione d'affari con il banco Salviati di Pisa ( nei documenti compaiono anche Piero di Bernardo e Carlo) Il banco Salviati di Pisa: commercio e finanza di una compagnia fiorentina tra il 1438 e il 1489 (non conosco l'autore ).
Amerigo fa battezzare il 19 gennaio 1463: Francesca schiava di Amerigo di Simone di anni 14 RG 2 fg 164
un poco contraddittorio battesimo e shiavitu'
dalla tesi del dr Jean Marc Riviere Répertoire prosopographique du personnel politique florentin de décembre 1494 à mai 1527
vedi : https://hal.archives-ouvertes.fr/tel-01355009/file/R%C3%A9pertoire%20prosopographique%20du%20personnel%20politique%20florentin%20de%20d%C3%A9cembre%201494%20%C3%A0%20mai%201527.pdf
vedi : http://www.carnesecchi.eu/Riviere.pdf
Per quanto riguarda i Carnesecchi lo studio e' abbastanza carente negli uffici elencati ma e' comunque una sintesi utile
UNA STORIA CURIOSA : CARNESEQUA IN PROVENZA
La geneologia e la storia familiare soffrono di autentici stupri effettuati dalla nobilta' ( ricca ) dei secoli XVI XVII XVIII XIX Per lunghissimo tempo i genealogisti su commissione e/o per puro servilismo alterarono profondamente gli alberi genealogici infoltendo di antenati antichissimi ed illustri con cui la famiglia non aveva a che fare , sfoltendo le genealogie e eliminando tutti quei poveri che potevano dare una connotazione plebea della famiglia In realta' , come tutti sappiamo , le famiglie sono fatte di parenti ricchi e poveri , di personaggi notabili ed altri pochissimo conosciuti Questa opera di abbellimento delle genealogie che allora chiamava pomposamente "riordino delle genealogie" ha portato ad autentici furti di individui e di stemmi che vantati dai moderni sono in realta' pura esposizioni di falsi (molto piu' comune di quello che si creda) Purtroppo la reiterazione delle menzogne genealogiche le ha rese credibili Insomma non esiste grande famiglia che non abbia avuto parenti poveri siano giunti o meno ai nostri giorni
Gene Adam Brucker - Firenze 1138 1737 l'impero del fiorino ---- Arnoldo Mondadori editore
L'ottimismo e la spensieratezza della elite fiorentina nel periodo laurenziano (1469-1492 ) sono espressi in un iscrizione che orna uno dei pannelli d'un ciclo di affreschi di Domenico Ghirlandaio , nella cappella maggiore di Santa Maria Novella . Gli affreschi furono commissionati dal ricco banchiere Giovanni Tornabuoni , amico dei Medici . Nel pannello dov'e' dipinta l'annunciazione della nascita di San Giovanni Battista da parte dell'Arcangelo Gabriele , fu inserita la seguente iscrizione latina : << Nell'anno 1490 , quando questa meravigliosa citta' - rinomata per la sua potenza e ricchezza , per le sue vittorie , per le arti ed i suoi palazzi - godeva di grande prosperita' , di salute e di pace >> . Dopo due anni moriva Lorenzo de Medici , e trenta mesi dopo la sua morte era cacciato da Firenze suo figlio Piero . La caduta del regime dei Medici dette inizio a un periodo di instabilita' politica e sociale , che sarebbe cessato soltanto nel 1537 , quando il duca Cosimo de Medici avrebbe preso le redini della citta' , stabilendovi un principato ereditario .Fino a quel momento vi fu una divisione e discordia tra le grandi famiglie fiorentine . Alcune rimasero fedeli all'esiliato partito dei Medici , altre parteggiarono per il nuovo regimo repubblicano del 1494 , fortemente influenzato dal domenicano Girolamo Savonarola . Il frate raccoglieva l'appassionata devozione di molti membri delle piu' importanti famiglie della citta' ma altri lo disprezzavano , e vaggheggiavano la sua rovina . Il cronista Parenti scrive nel 1497 che l'opinione pubblica era profondamente divisa sul Savonarola , per cui << padri con figliuoli , mogli con mariti , fratelli con fratelli , se ne divisono , e non che e cittadini del reggimento , ma e garzoni da 18 in 30 anni diversita' mostravono >>. La restaurazione dei Medici nel 1512 non fece che esarcerbare il conflitto fra i loro partigiani e i cittadini che avevano avuto stretti legami con la repubblica. La fedelta' alle istituzioni e tradizioni repubblicane era molto diffusa nell'aristocrazia fiorentina del primo cinquecento , come testimoniano gli scritti di Niccolo' Machiavelli e Francesco Guicciardini .
Gene Adam Brucker - Firenze 1138 1737 l'impero del fiorino ---- Arnoldo Mondadori editore
Nel 1351 i Carnesecchi ( allora Duranti ) era in lite con alcuni membri della famiglia Medici e ne dove' seguire una pace promossa dalla Signoria Completamente diversi i rapporti negli anni 80 del trecento I fratelli Grazzini appoggiavano fermamente i Medici con cui erano imparentati e questo loro appoggio si fortifico' nei loro discendenti nel legame con Cosimo il vecchio. I Carnesecchi entrarono cosi a far parte dell'oligarchia medicea divenendone una delle forze principali. Il legame mostro' talvolta segni d' incrinatura come quando nel 1464 i Carnesecchi parteciparono alla giostra di Bartolomeo Benci ma rimase abbastanza stabile . Nel 1494 al momento della fuga di Piero dei Medici da Firenze i Carnesecchi erano gia' una parte importante dell'aristocrazia fiorentina . L'irruzione sulla scena politica del Savonarola produce una netta spaccatura tra i vari rami dei Carnesecchi e le posizioni politiche si differenziano fortemente tra Palleschi Arrabbiati e Piagnoni . All'interno di uno stesso ramo si creano divisioni. Ma le posizioni spesso erano incerte : Pierantonio che si era mobilitato in armi a difesa di Piero de Medici aveva simpatie per il Savonarola . Zanobi di Francesco uomo politicamente rilevante Piagnone di peso aveva simpatie medicee e fino all'ultimo tentera' di mediare . Nel periodo del reggimento savonaroliano emerge la figura poco conosciuta di Giovanni Carnesecchi.
Col rogo si spezza la vita del Savonarola ma si spezza anche la coesione politica dei Carnesecchi.
SAVONAROLA Nato a Ferrara nel 1452, lasciati gli studi di medicina per quelli religiosi, nel 1476 si fece domenicano. A Ferrara concluse i propri studi teologici iniziati a Bologna. Nel 1482, nel convento di San Marco a Firenze, fu nominato lettore di sacra scrittura . Divenne ben presto famoso come predicatore, non solo in Toscana: enorme suggestione in particolare ebbero le sue prediche sull'"Apocalisse" e sulla "Genesi", nel 1490-94, che preannunciavano imminenti calamità per Firenze e per l'Italia, insieme a una rigenerazione della chiesa attraverso castighi e sofferenze. Priore di San Marco dal 1491, quando ottenne il distacco del monastero dalla provincia lombarda dell'ordine sembrarono realizzarsi le condizioni per una concreta azione di riforma spirituale e politica che, partendo da Firenze, interessasse tutto il mondo cristiano. Dopo la calata di Carlo VIII e la cacciata di Piero Medici nel 1494, Savonarola fu il principale ispiratore di una repubblica popolare, fondata sui princìpi de "Il regime dei prìncipi" (De regimine principum) allora attribuito a Tommaso da Aquino, pilastro della tradizione sistematica dottrinaria cattolica. Nonostante una condotta politica accorta e in linea con le esigenze e le tradizioni democratiche fiorentine, Savonarola non riuscì a evitare la radicalizzazione in senso puritano dei suoi sostenitori (i "piagnoni"). Le accuse di immoralità mossegli dal papa Alessandro VI gli suscitarono molti nemici, tra cui gli oligarchici (gli "arrabbiati") e i filo-Medici (i "palleschi"). Ben presto si trovò così isolato. Fu scomunicato nel 1497, fu arrestato, impiccato e arso nel 1498 a Firenze. Savonarola fu personalità sconcertante, capace di suscitare odi e fanatismi, amori viscerali e profonde fedeltà. Influenzò letterati come Guicciardini, Botticelli, Buonarroti. Vagheggiò il ritorno al cristianesimo primitivo e istituì i famosi "bruciamenti delle vanità" non condannando una sana fruizione dei beni mondani. Nella sua attività politica mirò ad una città pacifica, che sviluppasse i traffici e fosse allietata da opere d'arte e da feste, purché non contrarie alla morale. E' un atteggiamento che si rispecchia nei suoi scritti: Compendio di logica (Compendium logicum, 1491) riassume la sua filosofia di origine scolastica, Compendio delle rivelazioni (1495), Epistola della sana e spirituale lezione (1497), Trattato circa il reggimento del governo della città di Firenze (1498), il tomistico Trionfo della croce di incerta datazione, in cui si sforza di chiarire come il cristianesimo non sia in contrasto con la ragione. Come dimostrazione pratica di un'arte ispirata religiosamente, realizzò 14 componimenti e alcune laude. Suo capolavoro sono le Prediche, raccolte postume, caratterizzate da una eloquenza concitata e drammatica: nello slancio dei rimproveri e delle esortazioni fa ricorso a grandiose e terrificanti immagini bibliche, accanto a toni raccolti nella meditazione e nel rammarico. http://www.firenze-online.com/artisti-toscani/girolamo-savonarola.php
Tra i sottoscrittori della lettera al Papa in difesa del Savonarola troviamo diversi Carnesecchi
Giovanni di Leonardo di Giovanni ( 1466 - 1527) Zanobi di Francesco di Berto che sara' ai vertici dello stato ai tempi dell'assedio Giovanni di Niccolo ( o Giovanni di Simone ??? ) Bernardo di Francesco di Berto Giuliano di Simone di Paolo
L'esperienza savonaroliana e' breve ma fortemente incisiva nella politica fiorentina Il frate era determinato a percorrere la sua strada fino al sacrificio estremo Il fronte politico fiorentino contro di lui era vasto e variegato Composto da chi era contrario a questa politica teocratica , da chi era per una politica moderata nei confronti del Papato ,dai Medicei . ecc
Treccani breve estratto da articolo di Stefano Dall'Aglio - Dizionario Biografico degli Italiani Molte erano le ragioni di scontento dei fiorentini verso il frate, soprattutto perché i loro sacrifici non sembravano essere ripagati dalla gloria e la ricchezza annunciate per la loro città. Un crescente malumore era provocato dall’opera di moralizzazione forzata, che comportava un asfissiante controllo su moltissimi aspetti della vita pubblica e privata. A questo vanno aggiunti l’insoddisfazione degli ottimati per il succedersi di riforme fiscali e istituzionali che li danneggiavano economicamente e politicamente, e una carestia che portò con sé crisi economica e disoccupazione. Un peso determinante lo ebbero anche le tensioni con il pontefice – la cui minaccia di interdetto era vista con terrore, in particolare dai mercanti – e la delusione verso Carlo VIII, che sembrava avere dimenticato le promesse fatte a Firenze. Il mutato clima politico fu certificato, a partire dal marzo 1497, dall’elezione di gonfalonieri antisavonaroliani per due consecutivi mandati bimestrali. Fu quello un periodo irto di difficoltà per Savonarola, che dovette fronteggiare un tentativo di colpo di mano militare organizzato da Piero de’ Medici alle porte di Firenze e un nuovo divieto della predicazione. Durante la celebre predica dell’Ascensione (4 maggio), fu addirittura ridotto al silenzio dal tumulto di un gruppo di oppositori e dovette lasciare la chiesa. Nel frattempo a Firenze si combatteva un’aspra battaglia libellistica condotta a colpi di scritti pro e contro Savonarola. Era l’inizio della fine, sancito inequivocabilmente dal provvedimento che cambiò per sempre la storia di Savonarola: il breve di scomunica emanato da Alessandro VI il 12 maggio 1497. Nel testo si accusava il frate di avere divulgato una «pernitiosa dottrina» e di avere ignorato le ingiunzioni del pontefice relative alla convocazione a Roma, al divieto di predicare e all’istituzione della Congregazione tosco-romana. E il provvedimento puntava non soltanto a colpire personalmente Savonarola, ma anche a fare terra bruciata attorno a lui, in quanto la scomunica sarebbe stata estesa a chiunque avesse intrattenuto rapporti con il frate o seguito le sue prediche. Fra Girolamo rispose prontamente con due lettere pubbliche, Contro la escomunicazione surrettizia e Contra sententiam excommunicationis, difendendo la sua disobbedienza di fronte alle precedenti ingiunzioni papali e provando a spacciare il breve di scomunica per uno dei flagelli da lui profetizzati. In seguito alla scomunica, com’era prevedibile, il solco che divideva piagnoni e arrabbiati si fece ancora più incolmabile. Quel provvedimento poneva i seguaci di fronte a un bivio: restare con Savonarola voleva dire mettersi contro il capo della Chiesa di Roma, ed erano sempre di meno quelli disposti a compiere una scelta così radicale. Quei pochi, tuttavia, erano straordinariamente determinati e vedevano le crescenti difficoltà come la conferma del fatto che le profezie di fra Girolamo si stavano avverando e che quelle tribolazioni erano il preludio a ricchezza e felicità. La peste, che nell’estate del 1497 si aggiuse a tutti gli altri problemi, aggravò la situazione generale, ma fu vista da molti come l’ennesimo flagello profetizzato da Savonarola. Fu in questo clima che apparvero due petizioni pubbliche in difesa del frate, prodotte rispettivamente dai domenicani di S. Marco e da cittadini laici di Firenze. Savonarola, ridotto al silenzio, si dedicò alla stesura di una lunga serie di scritti di argomento molto diverso, incluse due tra le sue opere più importanti, il Triumphus crucis e il De veritate prophetica. Si tratta di due scritti dottrinali redatti in latino, sofisticati e non polemici. Con il primo Savonarola intendeva ribadire la sua ortodossia celebrando la dottrina cristiana e la vittoria della croce sul peccato. Con il secondo cercava di dimostrare la sua ispirazione profetica su basi scritturali, patristiche e giuridiche. Pochi mesi dopo, nel Trattato circa il reggimento e governo della città di Firenze, Savonarola offrì una sintesi della sua visione politico-istutuzionale, spiegando come il perseguimento del bene comune e l’interesse della collettività potessero essere assicurati soltanto da un «governo civile» di tutti i cittadini. Fallito ogni tentativo di ricucire lo strappo con Alessandro VI, l’11 febbraio 1498 Savonarola tornò sul pulpito per il suo ultimo quaresimale, quello sul libro dell’Esodo (Prediche sopra l’Esodo, a cura di P.G. Ricci, I-II, Roma 1955-1956), trasgredendo platealmente l’ordine comminato dal pontefice. Dopo un silenzio durato nove mesi, il frate decise di abbandonare qualsiasi moderazione e di alzare il livello dello scontro, attaccando non solo la scomunica ma tutti coloro che la rispettavano, e trasformando la contrapposizione tra lui e il pontefice in una lotta tra bene e male. La reazione di Roma non si fece attendere. Preceduti da ulteriori schermaglie, gli ultimi due brevi papali – datati 8 e 9 marzo 1498 – facevano capire che il tempo delle parole era finito. Ormai era chiaro che il pontefice pretendeva non soltanto che Savonarola smettesse immediatamente di predicare e si umiliasse al suo cospetto, ma anche che Firenze aderisse alla Lega antifrancese, il che avrebbe certificato il fallimento del frate sul piano sia politico sia profetico. L’interdetto, un provvedimento con conseguenze devastanti per l’intera città, era la terribile minaccia che pendeva su Firenze in caso di inadempienza. A questo punto la pressione si fece insostenibile: anche la Signoria finì per voltare le spalle a Savonarola e il 17 marzo ordinò al frate di cessare la predicazione. Treccani breve estratto da articolo di Stefano Dall'Aglio - Dizionario Biografico degli Italiani
La Signoria del Marzo era cosi composta
per ordine della Signoria venne decretato l'arresto e l'investigazione del Savonarola I Piagnoni si aspettavano questa decisione e decisero di opporsi all'arresto mano armata contro i birri della Signoria Portarono armi al convento di San Marco e si predisposero alla difesa
Treccani breve estratto da articolo di Stefano Dall'Aglio - Dizionario Biografico degli Italiani lo 8 aprile segui l'assalto al convento che vanificando i propositi dei difensori si risolse con l'arresto del Savonarola e dei due frati a lui piu' vicini che vennero sottoposti a processo il giorno successivo (8 aprile) il convento di S. Marco venne preso d’assalto da alcune centinaia di uomini armati. Poco distante, l’ex gonfaloniere Francesco Valori e la moglie vennero impietosamente uccisi dalla folla. Savonarola non volle approfittare dell’opportunità offertagli dalla Signoria: sette ore di tempo per lasciare il territorio fiorentino prima di essere dichiarato ribelle. A S. Marco si consumò uno scontro molto violento che si protrasse per diverse ore, al termine del quale Savonarola venne arrestato dai commissari inviati dalla Signoria. La stessa sorte venne riservata a due suoi strettissimi collaboratori, i fidati confratelli Domenico da Pescia e Silvestro Maruffi. Treccani breve estratto da articolo di Stefano Dall'Aglio - Dizionario Biografico degli Italiani
Savonarola fu sottoposto a tre processi distinti: due civili (9-19 aprile, 21-25 aprile) celebrati da una commissione di diciassette membri nominati dalla Signoria, e uno ecclesiastico (20-22 maggio) condotto da due commissari apostolici inviati da Alessandro VI: il maestro generale dell’Ordine domenicano Gioacchino Torriani e il giurista domenicano Francisco Remolines. Appare evidente che entrambe le autorità coinvolte – quella fiorentina e quella romana – non soltanto intendevano ottenere una sentenza di condanna, ma miravano anche a screditare l’imputato di fronte ai seguaci.
Giovanni di Leonardo Carnesecchi fu uno dei principali sostenitori del frate , e fu uno dei promotori della sottoscrizione in favore del Savonarola al Papa , uno dei protagonisti del rifornimento di armi al convento di San Marco e della resistenza armata durante l'assalto al convento. Infine a lui si deve un manoscritto che racconta presunti miracoli di cui fu artefice il frate .
nato il 19 marzo 1466 ( vedi albero di Giovanni di Paolo di Berto ) Giovanni Carnesecchi era un frequentatore del convento di San Marco gia' prima dell'epoca del Savonarola Un suo fratello Alessandro aveva infatti preso l'abito domenicano in San Marco e vi aveva fatto la professione di fede il 23 luglio 1483 anche se era morto qualche mese piu' tardi a 19 anni il 6 aprile 1490 Giovanni aveva continuato a frequentare il convento ed era divenuto uno dei piu' fervidi seguaci del frate. Giovanni di Leonardo fu quindi uno dei principali sostenitori del frate , e fu uno dei promotori della sottoscrizione in favore del Savonarola al Papa , uno dei protagonisti del rifornimento di armi al convento di San Marco e della resistenza armata durante l'assalto al convento. Infine a lui si deve un manoscritto che racconta presunti miracoli di cui fu artefice il frate
Giovanni sara' nel Consiglio Maggiore 1494 Scrivano al Monte 1496 Commissario delle prestanze ottobre 1497
Castellano della citta di Pistoia 6 mesi 1 luglio 1502 Podesta di Borgo San Lorenzo 6 mesi 26 agosto 1504 Capitano del Borgo 6 mesi 14 giugno 1512 Priore nel 1511 Capitano della cittadella di Volterra 6 mesi 26 ottobre 1524
Giovanni di Leonardo Carnesecchi ……….Giovanni di Leonardo Carnesecchi un'importante seguace del Savonarola
Condanna a morte per eresia dei tre frati Esecuzione 23 maggio 1498
Il 22 maggio Savonarola e i due confratelli arrestati insieme con lui, Domenico e Silvestro, furono giudicati colpevoli di eresia e scisma e condannati a morte. Privati dell’abito religioso e degradati, il giorno successivo, 23 maggio 1498, vennero impiccati e arsi sul rogo in piazza della Signoria. Le ceneri vennero gettate nell’Arno nel vano tentativo di impedire la raccolta delle reliquie e il culto postumo, anche se il tempo si sarebbe incaricato di dimostrare che la memoria del frate e della sua predicazione non poteva essere spenta così facilmente.
TROVIAMO NOMINATI ANCORA DUE CARNESECCHI IN DUE EPISODI SIGNIFICATIVI DELLA LEGGENDA SAVONAROLIANA : CARLO E LEONARDO L'UNO UN MEDICEO L'ALTRO UN SAVONAROLIANO
CARLO CARNESECCHI
Credo che Carlo debba identificarsi in Carlo di Cristofano di Bernardo di Cristofano maritato con Loretta Valori figlia di Francesco
LA PREDIZIONE DELLA MORTE DI LORENZO Piero de Medici pensa solo a se stesso , incurante , provocatorio , non serve alla patria ma se ne serve . Il popolo comincia a stringersi intorno a Savonarola, che aveva predetto la fine di Lorenzo davanti a cittadini di ogni fede: Alessandro Acciaioli, Cosimo Rucellai e Carlo Carnesecchi Tanto più si rivolgono a lui quando anche la seconda predizione relativa alla morte di Innocenzo VIII si avvera : il papa muore il 25 luglio 1492 These citizens were : Alessandro Acciaioli, Cosimo Rucellai, and Carlo Carnesecchi. As we have before stated, this prediction is mentioned by many writers (vide Note 2, to page 131); and Savonarola frequently alluded to it in his sermons.
L'ASSUNZIONE IN CIELO DEI MARTIRI
Erano suore quelle che videro i tre martiri portati in cielo da angeli : Leonardo Carnesecchi era commissario ad Arezzo quando il 23 maggio 1498 , si formo' un assembramento perche' alcune monache di un monastero cittadino dicevano di vedere angeli pieni di splendore che cantando portavano in cielo tre frati di San Domenico. Il commissario mando' a controllare l'assembramento ed il giorno seguente , ricevute lettere da Firenze che gli notificavano l'esecuzione di fra Girolamo e compagni avvenuta il giorno precedente in piazza della Signoria ,e confrontando l'ora della morte loro comprese che fra Girolamo e compagni erano stati portati in cielo al momento della loro morte .L'edizione della Vita attribuita a fra Pacifico Burlamacchi riporta l'episodio senza fare il nome del capitano : in nota il curatore , cioe' Roberto Ridolfi , avverte che la "Vita latina" da il nome di questo capitano che era Leonardo Carnesecchi padre di quel Giovanni che compilo' una raccolta di miracoli savonaroliani . Da: Il santuario di Santa Maria del Sasso di Bibbiena dalla protezione medicea al Savonarola storia, devozione, arte Armando Felice Verde, Raffaella Maria Zaccaria SISMEL edizioni del Galluzzo, 2000 - 126 pagine
Leonardo di Giovanni di Paolo di Berto Carnesecchi ( 1445 - 1520 ) padre di Giovanni
Stemma a Colle Valdelsa di Leonardo di Giovanni di Paolo
particolare _ da una foto di Francesco Bini.
particolare _ dalla foto di Francesco Bini.
ho dall'architetto dr Filippo Gianchecchi esperto anche di strutture medioevali e di conservazione e restauro di testimonianze araldiche Lo stemma in questione è sicuramente un Carnesecchi e nella iscrizione (molto consumata e restaurata in modo superficiale) io leggo L[E]ONA(R)DO DI GIO(V)AN(N)I CAR(NESECCHI) PO(DEST)A 1.... La composizione classica delle iscrizioni con nome, patronimico, cognome, titolo e periodo di reggenza è rispettata. Ci sono però, come spesso accade nelle iscrizioni o targhe, molte abbreviazioni, alcune pure storpiate e rese irriconoscibili da restauri a dir poco superficiali (molto frequenti purtroppo). Questo perchè spesso quando -fortunatamente - vengono eseguiti restauri, le ditte che si occupano in prima persona del ripristino pittorico sanno tutto sulla composizione chimica delle pitture e dei substrati, ma pochissimo sul "cosa" in effetti stiano restaurando. Spesso quindi viene ripreso il pittorico in maniera estemporanea direttamente dagli operatori che purtroppo non hanno informazioni certe su base storica o documenti, o studi, o inventari o foto antiche. Essi ridisegnano quindi le lettere rovinate o consunte integrando quel poco che riescono a vedere con una enorme dose di immaginazione (il tutto spesso dá origine a grossolani errori). L'abbreviazione restaurata male qui è la prima D di NAD... che in effetti doveva essere una R. l'ultima lettera è una d corsiva (si nota la zampetta a sinistra, simile a un delta minuscolo) e dentro la d c'è la o. Totale: NARd(o)La O e' quello che lei chiama "ghirigoro" dentro la D di LIONARDO (fine primo rigo). Il secondo rigo inizia con DI BIO.. (la B quasi sicuramente è un altro restauro errato di una G gotica). Dentro la O sembrano esserci 3 punti. Anche qui in realtà è una lettera, ovvero una V piccola per gioVanni. Sotto la A c'è una N piccola di giovaNni. Sopra ci sono due trattini orizzontali (di norma hanno la forma di un omega allungato) che identificano quasi tutte le abbreviazioni. Idem sopra CAR c'è un tratto orizzontale che sta per l'abbreviazione di tutto il resto del cognome: CAR(nesecchi). Lo stesso anche nel terzo rigo: POD con la A piccola dentro la O e, sopra la P e la A c'è il solito trattino per l'abbreviazione di PODESTÀ Le uniche cose che proprio non leggo sono gli anni di reggenza. Forse con una foto più nitida o cercando negli elenchi dei podestà di colle val d'elsa si potrebbe svelare l'arcano. dr. Arch. Filippo Gianchecchi
Leonardo di Giovanni di Paolo di Berto Carnesecchi ( 1445 - 1520 ) padre di Giovanni
Priore nel 1483 capitano di Livorno 4 mesi 12 mesi 1493 podesta' di Barga 31 marzo 1498 dispensatori dei beni di San Martino 6 giugno 1498 capitano di Livorno 15 aprile 1501 podesta' della montagna fiorentina 7 settembre 1502 vicario di Valdarno di sotto 6 mesi 3 agosto 1516
La storia di Girolamo Savonarola e de' suoi tempi, Volume 1 Di Pasquale Villari
La storia di Girolamo Savonarola e de' suoi tempi, Volume 2 Di Pasquale Villari
Giornale storico degli archivi toscani che si pubblica dalla ..., Volumi 1-2
|
--------------------------------------------------------------------------------------------------
Pier Soderini (Firenze, 1452 – Roma, 13 giugno 1522) Gonfaloniere a vita a Firenze dal 1502,
carica che però mantenne solo fino al 1512 anno in cui la famiglia Medici rientra nella signoria di Firenze
Piero Soderini era membro di un'antica famiglia fiorentina che aveva dato numerosi politici alla città, fu priore nel 1481. Uomo fidato di Piero il Fatuo de' Medici, per lui svolse la delicata quanto infruttuosa ambasceria al re Carlo VIII di Francia, che, per via degli umilianti accordi che i fiorentini furono costretti ad accettare valse la cacciata di Piero e della sua famiglia (1494) e l'instaurazione del regime teocratico di Girolamo Savonarola.
Con l'instabilità del nuovo regime repubblicano, venne deciso di estendere il mandato di Piero, in quel momento gonfaloniere di giustizia, a vita (1502), tentando un esperimento di dogato come a Venezia o a Genova. Il Soderini veniva infatti giudicato come uomo probo e imparziale che non avrebbe agito nel suo interesse (come i Medici), ma in quello collettivo. Alla sua scelta influi il fatto che fosse senza figli
Alcune sue riforme furono senz'altro importanti, come quella dell'erario con l'introduzione della Decima, e quella dell'ordinamento giudiziario, con la sostituzione di un tribunale della Ruota alle varie magistrature del podestà del capitano del popolo. Nel 1509 Pisa veniva riassoggettata a Firenze dopo la ribellione dell'autunno del 1494. La condotta del Soderini comunque non fu priva di incertezze ed errori, che nel tempo hanno sempre più messo in luce la sua mediocrità e mancanza di polso in una carica così critica, nonostante la collaborazione di alcuni personaggi di prim'ordine tra i quali spiccava Niccolò Machiavelli.
L'errore più grave di Pier Soderini fu comunque quello di aver acconsentito, nell'autunno del 1511, alla convocazione nel territorio della Repubblica dello "scismatico" Concilio di Pisa II, voluto da Luigi XII di Francia, che dichiarò decaduto Papa Giulio II. Il temerario papa Della Rovere si alleò allora con vari signori italiani, compresi i Medici, e inviò in Toscana un contingente spagnolo di armati guidati dal viceré di Napoli Raimondo de Cardona, che, in una prova di forza, mise a segno il Sacco di Prato nell'agosto 1512, spaventando a morte Firenze, che aprì con solerzia le sue porte trattando la resa con gli invasori. Il 31 agosto il Soderini fuggiva dalla città, mentre il giorno dopo vi facevano ritorno i Medici. L'ex gonfaloniere trovò riparo a Roma, dove trovò comprensione e appoggio dall'ex-nemico papa Leone X Medici, morendo nella città pontificia poco dopo la scomparsa del suo protettore, nel 1522.
Fu il gonfaloniere a vita Pier Soderini per primo a preoccuparsi della decorazione del Salone dei Cinquecento in palazzo Vecchio, riuscendo ad accordarsi con i due più grandi artisti fiorentini dell'epoca, Leonardo da Vinci e Michelangelo Buonarroti, per la realizzazione di due grandi affreschi (circa 17x7 metri) per decorare le pareti della sala, con scene di battaglia che celebrassero le vittorie della Repubblica (1503).
Leonardo iniziò a realizzare La battaglia di Anghiari, secondo Vasari sulla parete destra, mentre a Michelangelo venne destinata la parete sinistra per la realizzazione de La battaglia di Cascina.I due geni del Rinascimento ebbero così modo di lavorare per un certo periodo faccia a faccia, ma nessuna delle loro opere fu mai completata: Leonardo sperimentò la tecnica dell'encausto, che si rivelò disastrosa, sciupando irrimediabilmente l'opera, mentre Michelangelo si fermò al solo cartone, prima di partire per Roma chiamato da Giulio II. Entrambe le opere originali sono andate perdute, ma ci sono pervenute delle copie e dei disegni preparatori.
Vedi su questo sito :
Vita di Piero Soderini gonfaloniere perpetuo della repubblica fiorentina ...
Di Silvano Razzi
LA GUERRA PER LA RICONQUISTA DI PISA
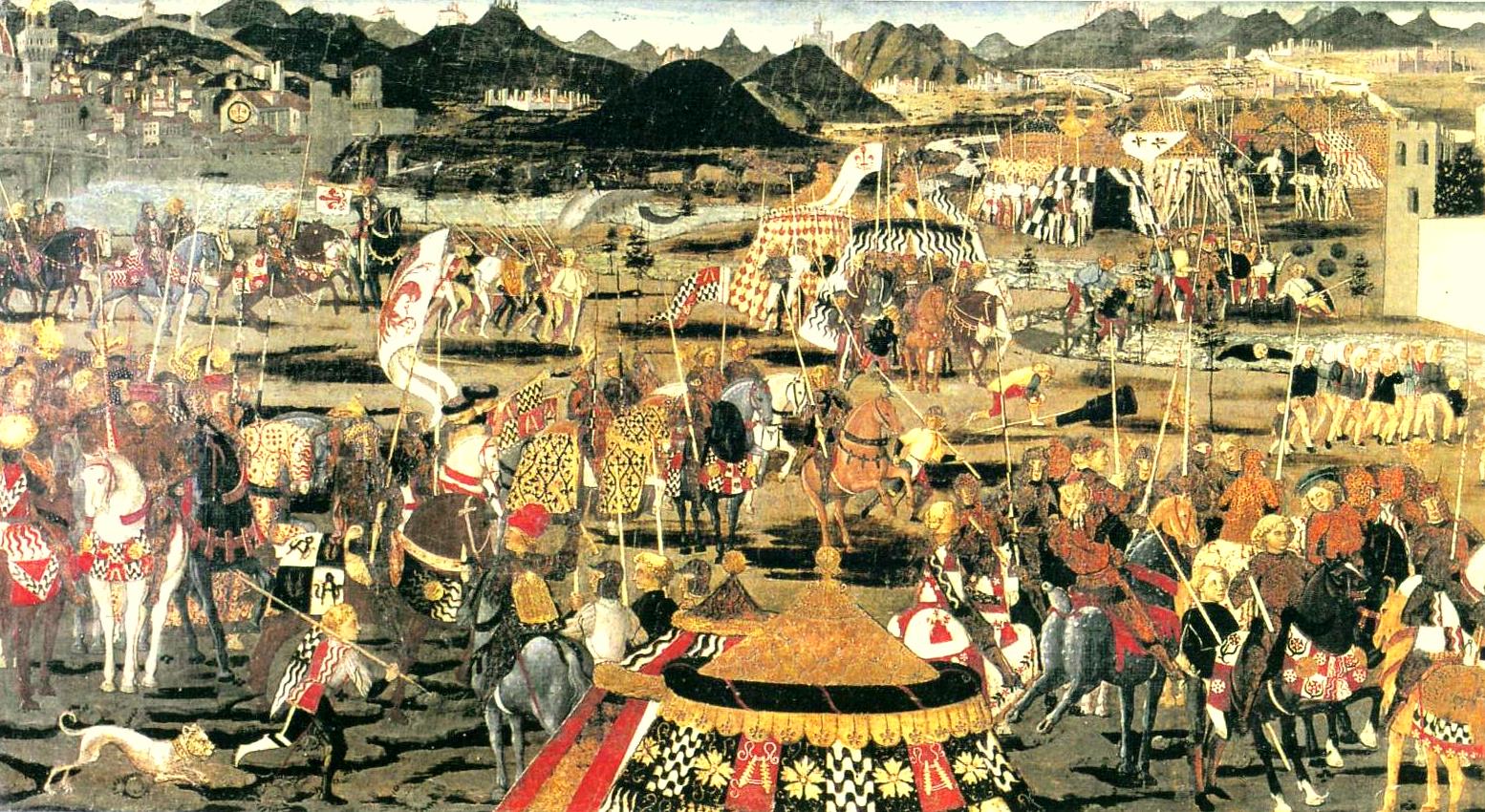
da Wikipedia
Nel 1494 il duro regime a cui la città fu sottoposta e l'orgoglio dei cittadini pisani fece sì che al calare in Italia del re francese Carlo VIII scoppiasse la rivolta.
La mattina dell'8 novembre il sovrano francese, che stava preparando la discesa verso Napoli, entrò in città. Dopo l'incontro con una delegazione delle principali famiglie pisane la popolazione, convinta di aver ottenuto una promessa di sostegno alla causa della propria libertà, scese in piazza e nei due giorni successivi riuscì a cacciare tutte le autorità fiorentine. In realtà lo scopo di Carlo VIII era di poter giungere incontrastato a Napoli e nei mesi successivi tenne un atteggiamento ambiguo promettendo ai fiorentini che Pisa sarebbe tornata sotto il loro dominio ma solo al termine della propria spedizione; nel contempo forniva qualche aiuto alla città ribelle. Intanto rinascevano le istituzioni comunali e si stabilivano positive relazioni diplomatiche con Lucca, Siena e Genova in funzione antifiorentina (anche Milano inviò segretamente degli aiuti) mentre l'esercito della città gigliata procedeva a rioccupare le principali città della pianura pisana. Questa situazione di attesa perdurò fino all'agosto del 1495. Il giorno 22 di quel mese Carlo VIII convinto dalle pressioni e dalle cospicue somme d'oro versategli dai fiorentini decise per la restituzione della città di Pisa e delle località di Livorno, Pietrasanta e Motrone. Nel frattempo i pisani cercavano aiuti presso Ludovico il Moro, il Doge di Venezia, Genova, l'Imperatore (che vantava i diritti dell'Impero sulla Toscana) e il catalano papa Alessandro VI, mentre il comandante D'Entrangues che capitanava le truppe presenti a Pisa dichiarava che non avrebbe ceduto la città ai fiorentini. In quei mesi la città pisana assistette all'arrivo e alla partenza dei più disparati contingenti: milanesi, veneziani e francesi su tutti ma anche svizzeri (al seguito dei francesi), tedeschi (inviati da Massimiliano d'Austria), genovesi e lucchesi in un intricato gioco diplomatico tra tutte queste forze; un gioco che aveva il suo nucleo nei rapporti tra Milano e Venezia e nella volontà dei milanesi e di Federico di Napoli di allontanare Firenze dalla Francia per impedire il ritorno in Italia di Carlo VIII, giustamente considerato come una potenziale minaccia per la loro indipendenza. Sul versante opposto i principali sostenitori della causa pisana erano i veneziani e Alessandro VI.
Il 15 settembre vi fu il primo scontro coi fiorentini che, cannoneggiati dal capitano francese, fallirono l'assalto alla porta San Marco ma conquistarono Livorno. Il 1º gennaio 1496 D'Entrangues dietro lauto compenso cedette alla città il comando delle fortificazioni e nei mesi successivi, soprattutto per merito del contingente veneziano, furono liberate diverse località fino a Terricciola durante scontri nei quali trovò la morte il commissario dei fiorentini Piero Capponi.
Due anni dopo la situazione si era modificata con il tradimento dei milanesi passati a sostenere Firenze e l'aumentato impegno militare della Serenissima in favore di Pisa motivato da considerazioni diplomatiche e di prestigio. Occasionali scontri coi fiorentini avevano alterne fortune ma non riuscivano a far pendere decisamente l'ago della bilancia verso uno dei due contendenti.
Nel 1499 si ebbe infine anche la defezione dei veneziani causato dalle forti spese sostenute fino a quel momento che gravavano sulle casse cittadine, dall'offensiva che i turchi stavano preparando contro di loro nel Mar Egeo e dal rimborso delle spese di guerra promesso da Firenze. Cercando di sfruttare il momento favorevole, il 1º agosto le truppe fiorentine attaccarono Pisa forti di 15.000 tra fanti e cavalieri e di 80 pezzi d'artiglieria. Dopo 10 giorni di combattimenti furiosi le truppe guidate da Paolo Vitelli riuscirono a occupare il bastione di Stampace a Porta a mare. Tuttavia Vitelli non riuscì ad approfittare del vantaggio acquisito e i rinforzi giunti a Pisa da Lucca, uniti alle perdite subite dai fiorentini per mano pisana e per causa della malaria, dopo un ultimo tentativo di sfondare le mura, lo costrinsero a sospendere gli attacchi di fanteria. L'8 settembre Vitelli toglieva il campo abbandonando tutta l'artiglieria (che venne recuperata dai pisani), atto che gli costò l'accusa di tradimento e la condanna a morte.
Dall'anno successivo la situazione mutò radicalmente per la conquista da parte di Luigi XII, nuovo Re di Francia, del ducato di Milano. Risolto il principale ostacolo nella penisola Carlo XII si volse come suo padre in direzione di Napoli ma decise che era tempo di stabilire un legame solido con Firenze a scapito di Pisa. Rispose quindi negativamente alle ambasciate pisane per rispettare l'antico impegno sulla restituzione della città ai fiorentini e giunse a porre un assedio alla città di Pisa ingente per gli uomini impiegati ma blando per intensità e che si concluse solo con qualche discussione tra francesi e fiorentini.
Nel 1501 si ebbe poi una spedizione di Alessandro VI contro lo stato fiorentino che si concretizzò nella conquista di Piombino, dell'Isola d'Elba e di Pianosa mentre i francesi tentavano la conquista del regno aragonese di Napoli.
Questa semplificazione degli equilibri politici nella penisola spinse Pisa a considerare come unici possibili interlocutori i Borgia a cui si rivolsero e che in effetti inviarono più volte aiuti in armi e denaro ma, in un primo momento, senza opporsi a Firenze con sufficiente decisione.
Nel 1503, dopo che l'anno precedente la questione pisana aveva fatto fallire una proposta francese per una lega di stati italiani, i Borgia mutarono atteggiamento. In primavera inviarono via nave truppe, armi e denaro mentre i fiorentini si limitavano a colpire i raccolti del contado e impedire rifornimenti via terra. In agosto si concludeva il patto di soggezione con Alessandro VI con cui i pisani rinunciavano alla loro libertà in cambio di un sostegno deciso contro Firenze ma pochi giorni dopo il pontefice moriva lasciando Pisa quasi isolata viste anche le cattive condizioni di salute di Cesare Borgia. Quando esso venne arrestato Firenze non ebbe più ostacoli diplomatici e tentò inizialmente di prendere la città per fame e anche per sete col fallito progetto della deviazione dell'Arno, quindi cinse nuovamente d'assedio l'antica rivale.
Il 7 settembre 600 cavalieri, 6000 fanti e vari pezzi d'artiglieria iniziarono l'attacco tra Porta Calcesana e Porta a Piagge causando brecce nelle mura ma senza che i fanti vi penetrassero, ragion per cui l'esercito si ritirò, e in Firenze si giunse alla conclusione che la città era quasi imprendibile se attaccata con truppe mercenarie. Da quel momento in poi i fiorentini si accontentarono delle consuete scorrerie nel contado per affamare la città, sostenuta solo dai pochi rifornimenti che giungevano dalla vicina Lucca e volte da Genova.
Nel 1509 i Dieci di Balia decisero che era tempo di porre termine a una questione che si trascinava ormai da troppo tempo. Gli spazi per la diplomazia pisana erano ormai chiusi e Firenze riusciva invece ad ottenere il consenso sia della Francia che della Spagna (anch'essa ultimamente coinvolta nella questione) alla riconquista. Furono pagate grosse somme in denaro a questi sovrani per assicurarsene la neutralità e fu quindi stretto il cerchio dell'assedio puntando subito sulla conquista per fame. Le truppe fiorentine riuscirono a bloccare ogni afflusso di risorse provenienti da Lucca e da Genova, compirono numerose scorribande nel territorio lucchese, particolarmente in Versilia e si assicurarono il controllo dell'Arno con un ponte di legno fortificato. Gli effetti si fecero sentire in breve e in una città che da più di una decade combatteva per la propria libertà i contadini iniziarono a premere perché si trattasse. Vi fu ancora un ultimatum di uscire dalla città in cambio della vita salva per tutti che venne respinto ma il 4 giugno gli ambasciatori inviati a Firenze firmarono l'inevitabile resa. Le condizioni furono tutto sommato favorevoli visto che vennero rimessi tutti i debiti e i beni mobili già confiscati, ristabilite le franchigie sui traffici e i privilegi, concesso un certo grado di autonomia alle autorità locali.
L'8 giugno 1509 Antonio da Filicaja, Averardo Salviati e Niccolò Capponi entravano quindi in città alla testa delle truppe fiorentine. Forse questa disponibilità fu dovuta anche a Massimiliano d'Austria che negli accordi di Cambrai aveva fatto accenno alla questione pisana ma la riconquista ebbe comunque l'effetto di allontanare altre famiglie pisane che espatriarono soprattutto in direzione di Palermo, Lucca, della Sardegna e della Francia.
da Wikipedia
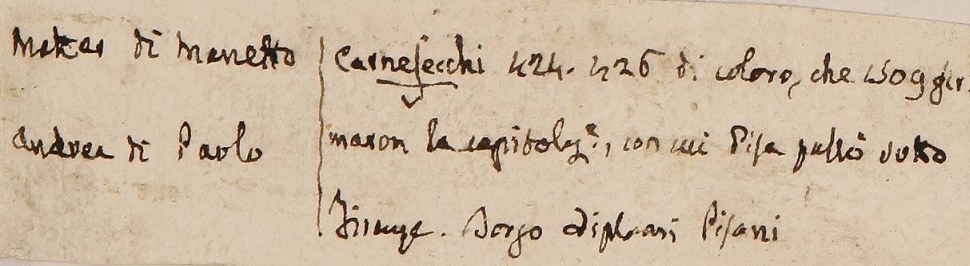
|
storiaaristocraziafiorentina
Pierantonio Carnesecchi era un uomo che non si nascondeva
Uditosi Piero essere stato ributtato dal palagio, si mosse solo in suo favore el cardinale e Pierantonio Carnesecchi e' quali con armati ne vennero verso piazza; ma di poi intendendo che el popolo multiplicava contro a Piero e che lui era stato fatto rubello e si partiva, ognuno si ritirò a casa, ed el cardinale in abito di frate si uscí sconosciuto di Firenze;
Era figlio del grande mercante Francesco di Berto e fratello di Zanobi e di Bernardo Esercito la mercatura sicuramente in Francia dove fu consigliere della Nazione fiorentina Pierantonio fedelissimo mediceo fu in rapporti strettissimi nonostante la giovane eta con Lorenzo il magnifico e suo figlio Piero il fatuo Ovviamente ostile al Savonarola Molto amico di Niccolo' Machiavelli Nonostante la conclamata fede medicea fu tuttavia stimato dai repubblicani antimedicei ed e' a questa stima che deve la nomina a commissario della Maremma in un momento delicatissimo cioe' nel tempo della guerra per la riconquista di Pisa ( citta' sotto il dominio fiorentino dal 1405 e persa per l'ignavia di Piero de Medici durante la discesa di Carlo VIII Le lettere a lui indirizzate da Niccolo' Machiavelli durante questo conflitto contenenti le disposizioni dei Dieci della guerra rimangono ad eternarlo
http://www.carnesecchi.eu/Pierantonio_Carnesecchi_di_Francesco.htm
Arezzo :Palazzo Pretorio di Arezzo: lo stemma che ricorda Pierantonio in una bella foto del dr Angelo Gravano Bardelli
UN UTILIZZO MALDESTRO DEL PERSONAGGIO PIERANTONIO
Matteo Di Giulio : romanzo "I delitti delle sette virtù" Utilizza Pierantonio Carnesecchi come uno dei personaggi del suo romanzo
Luca Rinarelli esalta la fatica di Di Giulio negli Archivi fiorentini :
Di Giulio è uno scrittore serio e s’è fatto il mazzo. Mesi e mesi di ricerche nelle biblioteche fiorentine. Casate, palazzi, la vita quotidiana in città a fine Quattrocento. L’autore è un appassionato di storia e si vede. Di quella storia che indaga la vita quotidiana degli uomini in un certo tempo e in un certo luogo. Ho notato un’impostazione da annalista francese, alla Le Goff. La lingua forse non è velocissima, ma è perfetta per questo tipo di romanzo. Chicca: la figura di Girolamo Savonarola. Di Giulio rende alla grande il predicatore domenicano, tirando fuori dal cilindro un personaggio che spacca. Luca Rinarelli http://www.occhiopesto.com/savonarola-matteo-di-giulio-i-delitti-delle-7-virtu-sperling-kupfer/
E non e' il solo , in diverse occasioni la presentazione del libro richiama la serieta' degli studi fatti per l'ambientazione storica del romanzo
-------------------- mio commento : Non do giudizi , mi limito ad analizzare lo studio storico su Pierantonio Carnesecchi . Ho avuto modo di protestare con la casa editrice e con l'autore , per la caratterizzazione di questo personaggio
Vi fosse il reato di diffamazione post mortem ve ne sarebbe il sospetto . Senza passare mesi e mesi di ricerche nelle biblioteche fiorentine nel caso di Pierantonio Carnesecchi bastava digitare il suo nome su Google per evitare di utilizzare maldestramente la sua figura che e' di un certo rilievo storico
Di storico nel romanzo su Pierantonio di Francesco Carnesecchi c'e' solo che Pierantonio era uno degli Otto di Guardia nel periodo del romanzo , come si vede in una pagina di questo sito , ma in altra pagina la figura di Pierantonio appare come descritta dalle fonti e bastava consultarla per capire che non era il caso Che poi uno degli Otto potesse comportarsi come ipotizza Di Giulio mi sembra alquanto fantasioso
https://teca.bncf.firenze.sbn.it/ImageViewer/servlet/ImageViewer?idr=BNCF0003834017
|
|
storiaaristocraziafiorentina
il legame dei Carnesecchi con gli Strozzi: Zanobi di Francesco di Berto Carnesecchi con Bernardo Strozzi
Alessandra Galilei chiede di raggiungere il marito Berto Carnesecchi a Castrocaro
Ritengo si tratti del Berto di Matteo poi comandante dei Fossi a Pisa Esiliato dopo la fine della Repubblica
Matteo il padre di Berto figura come copista di un documento mentre e' ufficiale nella stessa Castrocaro
DATI DI ARCHIVIOCopisti di opere latine avanti la stampa
Arezzo : Stemma di Matteo di Manetto Carnesecchi per la cortesia del dr Angelo Gravano Bardelli
L'arma Carnesecchi è magnificamente scolpita in felice connubio con un interessante cimiero parlante (un teschio), il che crea un insieme araldicamente stupendo. Il teschio e' la componente "parlante" dello stemma, dove "parlante" è il termine araldico che sottolinea il legame immediato ed evidente fra la figura, e il nome del titolare. Per i Carnesecchi, quale figura può essere più "parlante" di un teschio, simbolo per eccellenza di un qualcosa che fu "carne" ed ora è "secco"? ( bellissima interpretazione dell'esperto di araldica Maurizio Carlo Alberto Gorra )
Arezzo :Palazzo pretorio : foto da internet
|
DUE FATTI DETERMINANTI
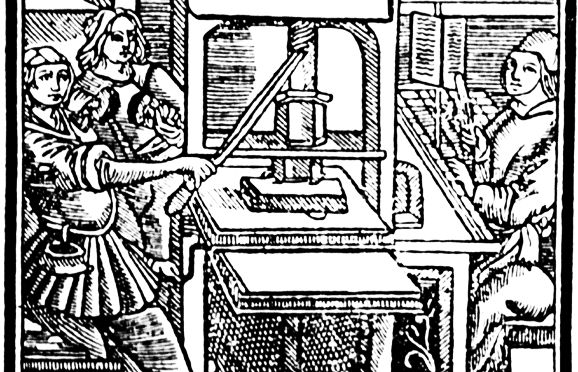
Johannes Gutemberg (1400 ca - 1468 )
I caratteri mobili aumentano enormemente la produttivita' e permettono la diffusione dei libri e della cultura

Theodore de Bry : Amerigo Vespucci (1454 - 1512)
Le ricchezze delle Americhe cambiano la storia dell'Europa e dell'Italia in particolare
la diffusione della stampa sancira' la separazione culturale tra il mondo cattolico e il mondo protestante
In particolare la decadenza della cultura italiana
Gli eserciti spagnoli sanciranno il decadimento delle terre italiane in qualche modo quasi tutte soggette alla Spagna ed al suo malgoverno
L'abbraccio della Spagna alla Chiesa di Roma sara' venefico
|
Scrive l'Orsi - "La nuova repubblica Fiorentina, inauguratasi sulle rive dell'Arno nel 1527, era sorta specialmente per opera degli antichi fautori del SAVORANOLA, cioè dei "Piagnoni", ai quali parve di vedere nel sacco di Roma la conferma delle profezie del frate; si comprende quindi come in mezzo alle calamità che afflissero allora Firenze, fra gli orrori della pestilenza, che infierì in modo terribile, e le preoccupazioni e paure sulla marcia delle "ciurme barbare" imperiali che avevano saccheggiato Roma, molta parte della popolazione non vedesse altra salvezza che nelle pratiche religiose, per modo che la, capitale del Rinascimento italiano riapparve in quei giorni immersa nel più completo misticismo; anzi il 9 febbraio del 1528 il gran consiglio deliberò di acclamare Cristo a re perpetuo del popolo fiorentino, decreto che, ad eterna memoria, si volle ricordarlo in una iscrizione sulla porta del palazzo della Signoria..."" (Orsi) I Piagnoni che governavano Firenze, pur essendo sinceramente repubblicani, erano divisi in due partiti: quello degli ottimati e quello dei popolani. Questi ultimi, animati da fierissima avversione alla famiglia de' Medici, erano capeggiati da BALDASSARRE CARDUCCI; gli altri erano guidati dal gonfaloniere NICCOLÒ CAPPONI, il quale, favorito dai Palleschi, (così si chiamavano i filo-medicei) non voleva scendere ad aperta lotta contro il Papa e, animato da propositi pacifici, desiderava salvaguardare la libertà della repubblica accordandosi con l'imperatore e con Clemente VII. Malgrado il suo desiderio di pace, il Capponi fu costretto dal fervore dei suoi concittadini ad una politica di armamenti senza i quali più tardi la città non avrebbe potuto sostenere il coraggioso assedio che doveva finire con la perdita della sua libertà. Trecento giovani si erano volontariamente arruolati per fare la guardia al palazzo della Signoria, e poiché essi erano repubblicani intransigenti guardavano con sospetto il contegno del gonfaloniere troppo riguardoso verso i Medici. Allora Niccolò Capponi, che era sempre stato contrario agli armamenti, per procurarsi un sostegno contro la guardia del palazzo propose ed ottenne il 6 novembre del 1528 che si costituisse una milizia cittadina. Questa fu composta di tremila cittadini dai diciotto ai quaranta anni, distribuiti in sedici compagnie agli ordini dei sedici gonfalonieri che formavano il collegio della Signoria. A comandare la milizia fu chiamato STEFANO COLONNA di Palestrina. Altre forze di cui la repubblica disponeva erano le così dette bande dell'ordinanza, reclutate nel territorio fiorentino, le quali contavano circa diecimila uomini e formavano trenta battaglioni. Sul finire del 1528 la repubblica elesse capitano generale del suo esercito ERCOLE d' ESTE figlio del duca Alfonso di Ferrara, il quale, perché sposo di Renata, cognata di FRANCESCO I, e perchè apparteneva ad una famiglia nemica dei Medici, dava affidamento di lealtà. Nello stesso tempo i Fiorentini stabilirono di completare le fortificazioni cominciate nel 1521 per ordine del cardinale Giulio dei Medici, e affinché la difesa di queste non richiedesse un gran numero di armati si decise di restringerne il circuito. L' incarico di fare il disegno e di dirigere i lavori venne dato a MICHELANGELO BUONARROTI, famoso pittore, scultore ed architetto, il quale --come dice il Nardi-- "dedicò il suo ingegno alla prima delle arti che è quella della difesa della patria".
|
Senza i due Papi medicei : Leone X (Giovanni di Lorenzo di Piero ) e Clemente VII ( Giulio di Giuliano di Piero ) il predominio dei Medici su Firenze durato circa 60 anni sarebbe finito come era finito il predominio degli Albizi
Se Clemente VII non avesse avuto il figlio Alessandro da sistemare , probabilmente non si sarebbe accanito contro Firenze , anzi avrebbe avuto un atteggiamento maggiormente benevolo verso i suoi concittadini
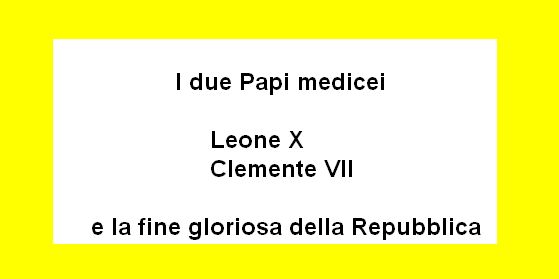
|
--------------------------------------------------------------------------------------------------
IL SACCO DI PRATO E IL RITORNO DEI MEDICI A FIRENZE
Giulio II, per contrastare i francesi di Luigi XII in Italia, costituì la Lega Santa alla quale nel 1511 aderirono l'Inghilterra, il Sacro Romano Impero, il Regno di Spagna e la Repubblica di Venezia. Lo scontro avvenne l'11 aprile 1512 nella sanguinosa battaglia di Ravenna i Francesi, nonostante le numerose perdite, ebbero la meglio e si diressero verso Milano, ma sapendo che un esercito imperiale stava scendendo dalla Svizzera, furono costretti ad abbandonare la Lombardia. Giulio II si rese conto che per ostacolare i francesi in Italia doveva ostacolare uno dei loro principali alleati, cioè la Repubblica di Firenze, e quindi favorire l'ascesa dei Medici, che erano stati costretti a fuggire dalla città dopo la morte di Lorenzo il Magnifico. Per fare questo fu deliberato che l’esercito spagnolo si volgesse verso Firenze La notizia del loro arrivo fu appresa dai Fiorentini solo quando gli Spagnoli del Vicerè di Napoli Ramon Cardona, da Bologna si diressero verso la città. Probabilmente si decise di piegare Prato per dare un forte avvertimento a Firenze. Furono inutili le richieste di aiuto che Prato rivolse a Firenze . Prato era difesa da circa 2000 fanti e doveva fronteggiare un esercito spagnolo forte di circa 10.000 uomini forti di molte artiglierie Dal sito : http://www.crprato.it/sito/index.php?option=com_content&view=article&id=140&Itemid=83Il giorno 28 Agosto del 1512 gli Spagnoli che si erano attestati presso Calenzano, mossero alla volta di Prato. Nel pomeriggio intorno alle ore 16 dopo avere piazzato due Falconetti (pezzi di artiglieria) iniziarono il sacco colpendo le mura e la porta Mercatale, che però resistette bene. Intanto il Cardinale Giovanni De Medici, al seguito delle truppe, (legato pontificio) seguiva l’andamento della battaglia dalla zona di S. Anna dove aveva dei possedimenti. Lo scontro del primo giorno finì senza che gli Spagnoli riuscissero a sfondare. Il giorno dopo, 29 Agosto,visto che quel punto era troppo resistente, spostarono la batteria dei due Falconetti verso porta del Serraglio riprendendo con più slancio la pugna, riuscirono in breve tempo a formare una breccia nelle mura dalla quale iniziarono ad entrare. In quel punto si concentrarono i pratesi, e riuscirono a bloccare i soldati spagnoli. Questi, visto che non riuscivano nel loro intento, cambiarono tattica e scalarono le mura. La monovra riuscì, i soldati pratesi vedendo che ben presto sarebbero riusciti ad entrare si diedero alla fuga, permettendo agli Spagnoli di penetrare all’interno. Questi al grido di " Ammazza ! Ammazza !" si introdussero all’interno della città uccidendo chiunque si trovasse loro davanti. In breve furono padroni della Piazza. Intanto nelle chiese si erano rifugiate moltissime persone, per lo più donne bambini, anziani, pensando che i luoghi sacri non venissero profanati, ma non fu così, gli Spagnoli non ebbero pietà di nessuno. Uccisero, violentarono, saccheggiarono. I pratesi non ebbero scampo, dato che le porte attraverso le quali sarebbero potuti scappare erano state murate, per cui non ebbero più nessuna via di fuga. In si tanta sofferenza dobbiamo ricordare un episodio prodigioso accaduto nel convento di S.Vincenzo. Tre capitani spagnoli entrati all'interno del sacro luogo, si bloccarono cadendo in ginocchio davanti alla statua della Madonna, mostrata loro da Suor Brigida,che in questo modo riuscì ad eviatare il saccheggio. Da allora, la bella statua fu chiamata "Madonna dei Papalini" ed ancora oggi il 29 Agosto di ogni anno le suore ricordano l'evento. Il sacco durò 21 giorni. Fu un atroce mattanza, il sangue e l’odore della morte erano in ogni luogo. Furono uccise circa seimila persone. Alcuni fra quelli che vennero catturati vennero uccisi più tardi fra atroci tormenti, mentre una parte di questi furono lasciati in vita per ottenere un riscatto. Prato in pratica pagò al posto di Firenze con la vita di tantissimi cittadini, e Firenze visto lo scempio fatto ai pratesi spalancò le porte ai vincitori così che i Medici poterono rientrare liberamente nella loro città. http://www.crprato.it/sito/index.php?option=com_content&view=article&id=140&Itemid=83
--------------------------------------------------------------------------------------------------
GLI OTTO ANNI DI PAPATO DI LEONE X ( GIOVANNI DEI MEDICI ) : Papa dal 1513 al 1521
Giovanni era il quartogenito (il secondo figlio maschio) di Lorenzo de' Medici e Clarice Orsini e portò alla corte pontificia lo splendore e i fasti tipici della cultura delle corti rinascimentali. Fu l'ultimo Papa a essere semplice diacono al momento dell'elezione
Il breve papato di Leone X ebbe pesanti conseguenze conseguenze per il futuro repubblicano di Firenze Riprendendo le abitudini nepotiste ( comunque comuni praticamente a tutti i Papi ), creò cardinale il nipote Innocenzo Cybo ed il cugino Giulio che in futuro sarà papa Clemente VII. Clemente VII il Papa che porra' fine alla storia repubblicana fiorentina attraverso le armi spagnole di Carlo V
Dopo il sacco di Prato , Firenze sara' in pratica governata dal Cardinale Giulio de Medici
Settembre del 1513, Leone X risolve in favore di Firenze un arbitrato sul dominio di Pietrasanta, città fino a quel momento parte della Repubblica di Lucca
Durante il papato di Leone X inizia anche la Riforma protestante con la pubblicazione delle 95 tesi di Martin Lutero La goccia che fa traboccare il vaso e' la vendita delle indulgenze inventata dalla curia papale per far fronte al continuo bisogno di denaro
--------------------------------------------------------------------------------------------------
L'INCREDIBILE IMPERO DI CARLO V E IL SUO SOGNO DI UN IMPERO UNIVERSALE SOTTO GLI ASBURGO
La scomparsa prematura di tutta la discendenza maschile della dinastia castigliano-aragonese, unitamente alla scomparsa prematura del padre Filippo "il bello" ed alla infermità della madre Giovanna di Castiglia, fece sì che Carlo V, all'età di soli 19 anni, risultasse titolare di un "impero" talmente vasto come non si era mai visto prima d'allora, neppure ai tempi di Carlo Magno. Carlo fu incoronato Imperatore dall'Arcivescovo di Colonia il 23 ottobre 1520 nella cattedrale di Aquisgrana[2]. Carlo di Gand, come Imperatore del S.R.I., assunse il nome di Carlo V, e come tale è passato alla Storia.
Nel dettaglio i possedimenti di Carlo V erano così composti: Eredità di Maria di Borgogna (1506): I Paesi Bassi (con gli importanti e ricchi feudi delle Fiandre, del Brabante, dell'Olanda, dell'Artois e del Lussemburgo) e la Franca Contea di Borgogna (Besançon).
Carlo V aveva ereditato dalla nonna paterna anche il titolo di Duca di Borgogna che era stato appannaggio, per pochi anni, anche di suo padre Filippo. Come Duca di Borgogna era vassallo del Re di Francia, in quanto la Borgogna era territorio appartenente, ormai da tempo, alla corona francese. Inoltre i Duchi di Borgogna, suoi antenati, appartenevano ad un ramo cadetto dei Valois, dinastia regnante in Francia proprio in quel momento. La Borgogna era un vasto territorio ubicato nel Nord-Est della Francia, al quale, in passato e per interessi comuni, si erano uniti altri territori come la Lorena, il Lussemburgo la Franca Contea e le province olandesi e fiamminghe, facendo di queste terre le più ricche e prospere d'Europa. Esse erano situate, infatti, al centro delle linee commerciali europee ed erano il punto di approdo dei traffici d'oltremare da e verso l'Europa. Tant'è che la città di Anversa era diventata il più grande centro commerciale e finanziario d'Europa. Suo nonno l'Imperatore Massimiliano, alla morte della consorte Bianca nel 1482, tentò di riappropriarsi del Ducato per condurlo sotto il governo diretto degli Asburgo, cercando di sottrarlo alla corona di Francia. A tal fine intraprese un conflitto con i francesi protrattosi per oltre un decennio, dal quale uscì sconfitto. Fu quindi costretto, nell'anno 1493, a sottoscrivere con Carlo VIII d'Angiò Re di Francia la Pace di Senlis, con la quale rinunciava definitivamente ad ogni pretesa sul Ducato di Borgogna, mantenendo però la sovranità sui Paesi Bassi, l'Artois, e la Franca Contea. Questa forzata rinuncia non fu mai veramente accettata da Massimiliano e il desiderio di rivalsa verso la Francia, si trasferì parimenti al nipote Carlo V, il quale, nel corso della sua vita, non rinunciò mai all'idea di riappropriarsi della Borgogna.
Eredità di Isabella di Castiglia (1516): la Castiglia, la Navarra, Granada, le Asturie, i possedimenti in Africa settentrionale, nell'America centrale (Messico) ed in quella caraibica (Cuba, Haiti, Porto Rico).
Eredità di Ferdinando d'Aragona (1516): i Regni d'Aragona, Valencia e Maiorca e le contee sovrane di Barcellona, Rossiglione e Cerdagna nonché i Regni di Napoli, Sicilia e Sardegna. Eredità di Massimiliano I d'Asburgo (1519): Arciducato d'Austria con Stiria, Carinzia, Tirolo, Alsazia e Brisgovia.
Nel 1519 Carlo V riuscì a farsi eleggere Sacro Romano Imperatore dai Principi Elettori (a quel tempo gli stati che componevano il Sacro Romano Impero erano vassalli dell'Imperatore anche se, soprattutto i più vasti e potenti, godevano di ampie autonomie) Il fratello Ferdinando inoltre acquisì per matrimonio con Anna Jagellone nel 1526 i regni di Boemia e di Ungheria, facendoli così entrare definitivamente nell'orbita austro-asburgica.
Nel corso del suo governo Carlo V raccolse anche molti successi, ma certamente la presenza di altre realtà contemporanee e conflittuali con l'Impero, come il Regno di Francia e l'Impero ottomano, insieme con le ambizioni dei principi tedeschi, costituirono l'impedimento più forte alla politica dell'Imperatore che tendeva alla realizzazione di un governo universale sotto la guida degli Asburgo. Egli, infatti, intendeva legare agli Asburgo, permanentemente ed in forma ereditaria, il titolo imperiale, ancorché sotto forma elettiva, in conformità delle disposizioni contenute nella Bolla d'oro emanata nel 1356 dall'Imperatore Carlo IV di Lussemburgo, Re di Boemia. Il Re di Francia, Francesco I di Valois-Angoulême, infatti, attraverso la sua posizione fortemente autonomistica, unitamente alle sue mire di espansione verso le Fiandre ed i Paesi Bassi, oltre che verso l'Italia, si oppose sempre ai tentativi dell'Imperatore di ricondurre la Francia sotto il controllo dell'Impero.
|
m
|
storiaaristocraziafiorentina
ASFi : Raccolta Ceramelli Papiani :stemma di Bernardo di Andrea di Bernardo Carnesecchi , sormontato dal capo di Papa Leone X
In occasione della visita di Leone X ( Medici ) a Firenze nel novembre del 1515 Il 30 novembre 1515 papa Leone X, al secolo Giovanni di Lorenzo de’ Medici, entra trionfalmente a Firenze, accolto da un articolato programma celebrativo che coinvolge la città, percorsa da sud-ovest a nord-est, secondo un itinerario simbolico pianificato con cura in tutte le sue parti. Si tratta di un percorso encomiastico – incentrato sull’esaltazione del papa e della sua famiglia, oltre che sull’enfatizzazione del legame fra Firenze e Roma – che attraversa le strade e le piazze, punteggiato da apparati effimeri di significato politico-culturale e di qualità artistico-architettonica, immaginifico suggello della riconquistata egemonia medicea sulla città, dopo il “sacco” di Prato e la cacciata di Pier Soderini nel 1512. ................. Le onoranze tributate a Leone X nella città d’origine rappresentano una prima occasione per la famiglia di dare prova tangibile della riaffermata autorità a Firenze dopo i lunghi anni di esilio. L’episodio diviene un costante riferimento per le cerimonie festive successive, sia per la singolarità dell’arredo urbano sia per la definizione topografica del percorso trionfale. L’itinerario traccia idealmente la pianta-immagine di un contesto urbano che non corrisponde ai confini della città storica, ma allude al quadrilatero della Florentia romana. Si recupera così il mito di Firenze “parva Roma”, che caratterizzava gran parte della letteratura celebrativa delle origini della città, e che proprio con la figura di Leone X acquisisce nuove valenze, rianndodando l’ideale filo rosso che lega le due città ab origine. estratto da : Emanuela Ferretti (Università di Firenze) Portale Storia di Firenze
Bernardo di Andrea di Bernardo di Cristofano Carnesecchi era un acceso partigiano mediceo e sara' successivamente senatore sotto Cosimo I Priore al momento della visita di Leone X sara onorato insieme con tutti gli altri membri della signoria col titolo di Conte palatino e con la concessione di poter apporre nello stemma familiare il capo di Leone X
Il Monaldi ne sbaglia il nome e anziche' come Bernardo lo cita come Benedetto e altri poi ne seguono l'errore
Signoria dell'ottobre novembre 1515
Gonfaloniere Piero di Niccolo Ridolfi Priore Battista di Battista Dini Priore Lorenzo di Iacopo Mannucci; Priore Buonarrota di Lodovico Simoni *** Priore Giannozzo di Bernardo Salviati Priore Cosimo di Francesco Sassetti Priore Piero di Leonardo Tornabuoni Priore Bartolomeo di Francesco Panciatichi Priore Bernardo di Andrea di Bernardo Carnesecchi
Non ho mai visto l'uso di questo stemma e nemmeno l'uso del titolo di conte nella discendenza di Bernardo di Andrea di Bernardo
*** Nota Bene parente di Michelangelo Buonarroti Simoni ,( Michelangelo nato nel 1475 ) il padre di Michelangelo era Lodovico di Leonardo di Buonarrota |
--------------------------------------------------------------------------------------------------
IL SECONDO PAPA MEDICEO
Clemente VII, nato Giulio di Giuliano de' Medici (Firenze, 26 maggio 1478 – Roma, 25 settembre 1534), esponente della famiglia fiorentina dei Medici, fu il 219º papa della Chiesa cattolica e il 127° sovrano dello Stato Pontificio dal 1523 alla morte.
Giulio era figlio naturale, poi legittimato di Giuliano de' Medici, ucciso nella Congiura dei Pazzi un mese prima della sua nascita, e di una certa Fioretta, forse figlia di Antonio Gorini. Da giovane fu affidato, dallo zio Lorenzo il Magnifico, alle cure di Antonio da Sangallo. Dopo poco tempo, però, lo zio lo prese direttamente sotto la sua protezione. Nel 1488 riuscì a convincere Ferdinando I d'Aragona a concedergli il priorato di Capua dell’Ordine di San Giovanni di Gerusalemme, beneficio prestigioso e molto remunerativo.
Nel 1495, a causa delle sollevazioni popolari contro il cugino Piero, scappò da Firenze per rifugiarsi prima a Bologna, poi a Pitigliano, Città di Castello e Roma, dove visse per molto tempo ospite del cugino cardinale Giovanni, il futuro papa Leone X.
Il 9 maggio 1513 fu eletto arcivescovo di Firenze dal cugino papa Leone X e il 14 agosto dello stesso anno Giulio fece il suo ingresso a Firenze che dopo il sacco di Prato aveva subito il ritorno dei Medici al governo cittadino . Alla morte del cugino Lorenzo duca di Urbino divenne anche signore della città. Sia come arcivescovo che come governatore si dimostrò un abile uomo di governo. Pur ricevendo spesso incarichi e missioni diplomatiche per conto del Papa non trascurò mai la sua arcidiocesi e con la collaborazione del suo vicario generale Pietro Andrea Gammaro volle conoscere, attraverso i singoli inventari, la situazione di tutte le chiese sotto la sua giurisdizione. Nel 1517 tenne un sinodo di tutto il clero. Da cardinale diacono nel frattempo fu dichiarato cardinale prete con il titolo di San Clemente (26 giugno 1513) e poi di San Lorenzo in Damaso.
Sventò una congiura tramata contro di lui e fu inflessibile contro i suoi nemici (1522).
Nel 1513, con l’elezione di Leone X, Giulio ebbe la concessione dell’arcidiocesi di Firenze e, il 29 settembre dello stesso anno, dopo una serie di procedure e dispense per superare lo scoglio della sua nascita illegittima, fu creato cardinale. Dopo questa nomina iniziò la sua ascesa, caratterizzata da una grande ricchezza di benefici ecclesiastici e da un ruolo molto delicato all'interno della politica pontificia. Tra le sue azioni è da ricordare il tentativo di costituire un’alleanza con l'Inghilterra per aiutare Leone X a contrastare le mire egemoniche di Francia e Spagna; per questo motivo fu nominato cardinale protettore d'Inghilterra. La caratteristica principale della politica di questo periodo fu la ricerca di un equilibrio tra i principi cristiani e l’indizione del Concilio Lateranense V (1512-1517), durante il quale Giulio si interessò di lotta contro le eresie.
Il 9 marzo 1517 fu nominato Vicecancelliere di Santa Romana Chiesa, incarico che gli diede modo di mettere alla prova le sue qualità diplomatiche, mostrando un contegno serio e apparentemente illibato in confronto a quello mondano e dissoluto del cugino. Mentre cercava di organizzare una crociata contro i turchi, che Leone X reputava assolutamente necessaria, dovette risolvere due problemi: la protesta luterana, e la successione dell'Impero che, dopo Massimiliano I, toccò al nipote Carlo, già re di Napoli. Nel corso del 1521 la situazione di Firenze (di cui era Governatore cittadino) lo fece allontanare abbastanza spesso da Roma, ma l'improvvisa morte del papa, avvenuta nello stesso anno, lo costrinse a tornare a Roma per partecipare al conclave. Fu eletto Adriano VI, di cui aveva sostenuto la candidatura per ottenere l’appoggio di Carlo V. L’anno successivo fu vittima di una congiura, senza conseguenze, ordita dai repubblicani.
Il 3 agosto 1523 l’opera diplomatica di Giulio giunse alla sua conclusione: venne ratificata l'alleanza tra il papato e Carlo V. Poco dopo, nel settembre 1523 morì Adriano VI e Giulio, con l’appoggio dell’imperatore, dopo un conclave lungo (50 giorni) e difficoltoso, fu eletto al soglio di Pietro. Il 19 novembre Giulio de' Medici assunse il nome di Clemente VII.
L’elezione del nuovo pontefice venne salutata con entusiasmo, anche se certe aspettative si dimostrarono mal riposte: Giulio de' Medici risultò incapace di risolvere con decisione i problemi che dovette affrontare. Cercò di mantenere una politica di neutralità nella contesa tra Carlo V e Francesco I di Valois per il predominio sull'Italia e sull'Europa; Carlo V era intenzionato a restaurare l'Impero ammodernando le sue strutture amministrative e perseguendo una politica espansionistica che lo portava in rotta di collisione con il re di Francia. Nell’ottobre 1524, quando Francesco I conquistò Milano, il delicato apparato diplomatico messo in piedi da Clemente VII andò in crisi. Il papa, mentre l’arcivescovo di Capua, Niccolò Schomberg, lo spingeva a intraprendere una politica filoimperiale, mandò a trattare il datario apostolico, il filofrancese Gian Matteo Giberti, che dovette tornare indietro all’arrivo delle truppe imperiali in Lombardia. In quel periodo anche la Riforma si andava espandendo sempre più in Germania. Nella seconda dieta di Norimberga, del febbraio 1524, gli stati tedeschi ratificarono l'editto di Worms come legge dell'Impero, promettendo, però, al legato pontificio, cardinale Lorenzo Campegio, di mandarlo in esecuzione soltanto "nei limiti del possibile" e chiedendo un concilio nazionale che avrebbe dovuto aver luogo a Spira nello stesso anno. Sia il papa che l'imperatore negarono tale eventualità.
Il 24 febbraio 1525 le truppe imperiali sconfissero quelle francesi a Pavia, catturando lo stesso Francesco I e deportandolo a Madrid. Francesco venne umiliato, dovette perdonare Carlo di Borbone e reinsediarlo nelle sue terre, fu costretto a lasciare in ostaggio i suoi due figli e fu invitato a sposare la sorella di Carlo V, Eleonora. Nel 1526 fu costretto ad accettare la pace di Madrid, secondo la quale doveva rinunciare a Milano, a Napoli e alla Borgogna; dopo aver firmato la pace, il 18 marzo, Francesco I fu rilasciato.
Francesco I, dopo essere tornato in Francia, lamentando di essere stato costretto con la violenza ad accettare i patti, si rifiutò di ratificare il trattato di Madrid. Il 22 maggio 1526 a Cognac sur la Charente, stipulò con Clemente VII, Firenze, Venezia e Francesco Maria Sforza, una lega per scacciare gli imperiali dall’Italia. I confederati si obbligavano a mettere insieme 2.500 cavalieri, 3.000 cavalli e 30.000 fanti; Francesco I avrebbe dovuto mandare un esercito in Lombardia e un altro in Spagna, mentre i veneziani e il pontefice avrebbero dovuto assalire il regno di Napoli con una flotta di ventotto navi. Cacciati gli spagnoli, il papa avrebbe dovuto mettere sul trono napoletano un principe italiano, che avrebbe dovuto pagare al re di Francia un canone annuo di 75.000 fiorini. Francesco I non tenne mai fede ai patti e, per tutto il 1526 non partecipò alle operazioni, preferendo trattare con Carlo V il riscatto dei figli.
Queste notizie si abbatterono come fulmini su Carlo V che definì pubblicamente Francesco I uno spergiuro e considerò imperdonabile il voltafaccia del Papato, il quale nei suoi confronti aveva un debito enorme (infatti Carlo V aveva condannato Lutero durante il processo per favorire il papa, anche se si era guadagnato l'antipatia di molti sudditi).
Il fatto più grave che occorse al papa fu il tradimento del cardinale Pompeo Colonna, questi, incoraggiato da Carlo V con promesse e ricompense, nella notte tra il 19 ed il 20 settembre 1526, occupò con un esercito di 8000 uomini la porta di San Giovanni in Laterano e Trastevere, spingendosi lungo il Borgo Vecchio fino al Vaticano. Clemente VII si rifugiò a Castel Sant'Angelo lasciando che il Vaticano venisse saccheggiato dalle truppe del cardinale. Il papa, vedendo che gli alleati non onoravano i patti, concluse una tregua di 8 mesi con l’imperatore, ma Carlo di Asburgo non accettò l'armistizio.
Il 31 marzo l'imperatore passò il Reno nei pressi di Bologna e si diresse verso la Toscana. Le truppe della Lega comandate da Francesco Maria I della Rovere e dal marchese di Saluzzo si accamparono vicino a Firenze per proteggerla dall'esercito invasore, ma questo attraverso il territorio di Arezzo e quindi di Siena si diresse verso Roma. Lungo il tragitto Carlo di Borbone devastò Acquapendente e San Lorenzo alle Grotte, occupò Viterbo e Ronciglione. Il 5 maggio gli invasori giunsero sotto le mura di Roma, che era difesa da una milizia piuttosto raffazzonata comandata da Renzo da Ceri.
IL SACCO DI ROMA : 1527
L’assalto alle mura del Borgo iniziò la mattina del 6 maggio 1527 e si concentrò tra il Gianicolo e il Vaticano. Per essere di esempio ai suoi, Carlo di Borbone, fu tra i primi ad attaccare, ma mentre saliva su una scala fu colpito a morte da una palla d'archibugio, che Benvenuto Cellini si attribuiva il merito di aver tirato. La sua morte accrebbe l'impeto degli assalitori, che, a prezzo di gravi perdite, riuscirono ad entrare in città.
Durante l'assalto Clemente VII pregava nella sua cappella privata e, quando capì che la città era perduta, si rifugiò a Castel Sant'Angelo insieme ai cardinali e gli altri prelati. Nel frattempo gli invasori trucidavano i soldati pontifici. L’esercito imperiale era composto di circa 40.000 uomini, così suddivisi: 6.000 spagnoli agli ordini di Carlo di Asburgo, a cui si erano aggiunte le fanterie italiane di Fabrizio Maramaldo, di Sciarra Colonna e di Luigi Gonzaga "Rodomonte"; molti cavalieri si erano posti sotto il comando di Ferrante I Gonzaga e del principe d'Orange Filiberto di Chalons, che era succeduto al Borbone; inoltre si erano accodati anche molti disertori della lega, i soldati licenziati dal papa e numerosi banditi attratti dalla speranza di rapine. A questi si aggiunsero i 14.000 lanzichenecchi comandati da Georg von Frundsberg, mercenari bavaresi, svevi e tirolesi, tutti luterani esasperati dalla fame e dal ritardo nei pagamenti, che consideravano il papa come l'anticristo e Roma come la Babilonia corruttrice, attratti dalla possibilità di arricchirsi saccheggiando la città.
Furono profanate tutte le chiese, furono rubati i tesori e furono distrutti gli arredi sacri. Le monache furono violentate, così come le donne che venivano strappate dalle loro case. Furono devastati tutti i palazzi dei prelati e dei nobili, ad eccezione di quelli fedeli all'imperatore. La popolazione fu sottoposta ad ogni tipo di violenza e di angheria. Le strade erano disseminate di cadaveri e percorse da bande di soldati ubriachi che si trascinavano dietro donne di ogni condizione, e da saccheggiatori che trasportavano oggetti rapinati.
L’8 maggio il cardinale Pompeo Colonna entrò a Roma seguito da molti contadini dei suoi feudi, che si vendicarono dei saccheggi subiti per ordine del papa saccheggiando tutte le case in cui ancora rimaneva qualcosa da rubare o da distruggere.
Tre giorni dopo il principe d'Orange ordinò che si cessasse il saccheggio; ma i lanzichenecchi non ubbidirono e Roma continuò ad essere violata finché vi rimase qualcosa di cui impossessarsi. Il giorno stesso in cui cedettero le difese di Roma, il capitano pontificio Guido II Rangoni, si spinse fino al Ponte Salario con una schiera di cavalli e di archibugieri, ma, vista la situazione, si ritirò ad Otricoli. Francesco Maria della Rovere, che si era riunito alle truppe del marchese di Saluzzo, si accampò a Monterosi in attesa di novità.
Il 6 giugno Clemente VII capitolò, obbligandosi a versare al principe d’Orange 400.000 ducati, di cui 100.000 immediatamente e il resto entro tre mesi; era inoltre pattuita la consegna di Parma, Piacenza e Modena. Clemente VII, per evitare di ottemperare alle condizioni imposte dall'imperatore, abbandonò Roma e, il 16 dicembre 1527, si ritirò ad Orvieto.
RIBELLIONE DI FIRENZE E NUOVA CACCIATA DEI MEDICI
Firenze approfitto' della crisi tra Papato ed impero per ribellarsi e scacciare nuovamente la famiglia Medici
ACCORDO TRA PAPA ED IMPERATORE A DANNO DELLA REPUBBLICA FIORENTINA
Allo scopo di farsi perdonare l'inaudito attacco al papato, Carlo V si fece piu' conciliante cosi alla fine del 1529, fu stipulata la Pace di Barcellona, secondo i termini della quale, il Papa, il 24 febbraio 1530, incoronò Carlo V imperatore, come segno di riconciliazione tra papato e impero. Carlo si impegnò anche ad aiutare il papa a restaurare i Medici a Firenze abbattendo la repubblica fiorentina e a concedere la Borgogna a Francesco I, che si impegnava a disinteressarsi degli affari italiani.
Firenze fu promessa ad Alessandro de' Medici (figlio illegittimo di Clemente VII ), a cui fu promessa sposa Margherita, figlia naturale di Carlo V.
Ufficialmente Alessandro de' Medici, figurava essere figlio di Lorenzo Duca di Urbino ma pare che egli fosse in realtà figlio del papa stesso, nato nel 1511 quando Giulio era ancora cardinale, da una relazione con una serva di sua zia Alfonsina Orsini, chiamata Simonetta da Collevecchio e probabilmente di colore.
Firenze stritolata dall'accordo si trovo quindi a dover fronteggiare l'esercito imperiale e l'esercito papalino da sola senza piu' alcun alleato
Si apriva una delle pagine piu' eroiche della storia fiorentina.
Infatti dopo alcune battaglie di avvicinamento le truppe imperiali iniziarono l'assedio il 14 ottobre 1529; la feroce quanto inaspettata resistenza della ricca città e di alcune fortezze del contado, la lunghezza dell'assedio, la morte in battaglia di alcuni tra i migliori comandanti dell'esercito imperiale, il timore che le gesta dei difensori ispirassero altre città alla ribellione indussero gli assedianti ad intavolare trattative per una resa onorevole della città, che escludevano il saccheggio e la sottrazione di territorio al governo cittadino.
Della difesa della città fu incaricato in qualità di Capitano Generale Malatesta IV Baglioni che in realtà mirava principalmente ad ingraziarsi il papa per tornare in possesso della città di Perugia, arrivando probabilmente a tradire il prode capitano Francesco Ferrucci nella battaglia di Gavinana, unica importante ma disastrosa sconfitta per le truppe fiorentine nelle vicinanze della città.
Sicuramente il Baglioni forzò la resa della città: estromesso dal comando in quanto oramai vi erano forti dubbi sulla sua condotta, si ribellò ed introdusse in città una piccola pattuglia di imperiali che conquistò Porta Romana e voltò le artiglierie verso la città; i fiorentini non reagirono compatti e ciò portò alla resa, firmata il 12 agosto 1530 presso la Chiesa di Santa Margherita a Montici.
Altro importante personaggio che collaborò alla difesa della città fu Michelangelo Buonarroti, che venne incaricato di rafforzare le fortificazioni. Prima si dedicò con tutto l'impegno all'opera, salvo fuggire dalla città per poi rientrarvi quando era già assediata, a rischio della vita; al momento della resa dovette restare nascosto a lungo per sfuggire alla collera del papa. Molti suoi disegni di fortificazioni ancora conservati, che rappresentano una pietra miliare negli studi teorici sulla fortificazione alla moderna, si riferiscono alle opere esterne delle mura di Firenze; non sappiamo però in che misura questi disegni siano stati tradotti in reali strutture.
Durante l'assedio, a scherno degli assedianti fu giocata una storica partita di calcio che ogni anno viene rievocato nella storica sede di piazza Santa Croce.
Pronotario apostolico di Papa Clemente VII fu Pietro Carnesecchi
Suo padre Andrea di Paolo era un ferventissimo mediceo
--------------------------------------------------------------------------------------------------

Dopo il trattato di Barcellona ,conchiuso il 29 giugno del 1529, poche speranze rimanevano alla Repubblica fiorentina , osteggiata dal Papa sostenuto a sua volta dalle armi dell'Imperatore. Clemente VII , che aveva abbandonato Francesco I e si era unito a Carlo V vedendo in lui un sostegno piu' valido per il conseguimento dei suoi fini ambiziosi , vergognosamente benedisse le armi dei manigoldi scampati alle forche , alla peste di Roma , alla fame di Napoli ; e senza rimorso impiego' i tesori della Chiesa per mantenere eserciti in danno di un popolo libero ed innocente.
Nonostante il desiderio dei piu' , fosse di richiamare i Medici in Firenze come cittadini principali senza tirannide, per non sottoporre la citta' alle funeste conseguenze della guerra , nella Consulta del 30 settembre quasi tutti si accordarono nel dire :
<< gustata la liberta' e' da posporsi a lei ogni cosa umana >>
Parole queste , osserva il prof. Falletti , memorande che danno grandezza all'Assedio di Firenze e che non possono essere pienamente comprese da chi nato in liberi tempi , non ha mai provato che sia servitu' ( Falletti Fossati Assedio di Firenze pg 381 )
Cosi il popolo ispirandosi agli esempi e agli insegnamenti del Savonarola , invocando la benedizione di Cristo suo re , si preparo' alla difesa , riflettendo che in guerra si puo' perdere ma si puo' anche vincere ; e nella resa si perde senza speranza di poter vincere
( da Carlotta Borgia Lotti : Lorenzo Carnesecchi o il secondo Ferruccio )
|
storiaaristocraziafiorentina
CARNESECCHI PROTAGONISTI AI TEMPI DELL'ASSEDIO
I Carnesecchi che erano stati sempre vicino ai Medici , iniziarono ad esser coinvolti in profonde divisioni ai tempi del Savonarola . Alcuni di loro furono fortemente coinvolti dal messaggio profetico del martire La fede nelle istituzioni repubblicane , il messaggio profetico , l'amicizia personale coi Medici spinsero i Carnesecchi su strade assai diverse
ZANOBI di FRANCESCO dittatore di Firenze durante l'assedio
In Zanobi troviamo la fede in Savonarola,l'amicizia per i Medici , la fedelta' alla Repubblica Tentava di conciliare queste esigenze cosi diverse ritenendo che si dovesse comunque trovare un accordo col Pontefice Eletto tra i sette dittatori la sua azione sara' sempre limitata da questa convinzione Zanobi di Francesco di Berto Carnesecchi ………………. Zanobi Carnesecchi il mercante ai vertici dello stato : uno dei sette dittatori
Zanobi di Francesco Carnesecchi, leale e diritto mercatante non che pratico e prudente popolano, il quale dopo lunga e posata orazione conchiuse con queste parole: " Accordando si smarrisce e non si perde la libertà; dove non accordando ed essendo vinti, non si smarrisce a tempo, ma si perde per sempre. "
ANDREA di PAOLO di SIMONE
Andrea Carnesecchi ( il padre di Pietro ) e' l'uomo che prepone i suoi legami coi Medici alla fedelta' alla Repubblica ,sara' imprigionato nei giorni dell'assedio essendo sospetto ai Fiorentini
Andrea di Paolo di Simone Carnesecchi …………. …….Andrea di Paolo di Simone carnesecchi senatore del ducato di Toscana
Milano, Archivio storico civico e Biblioteca Trivulziana, Trivulziano, Triv.464 presumibilmente questo libro di orazioni appartiene a Caterina di Mico di Uguccione Capponi prima moglie di Andrea di Paolo di Simone Andrea era stato a servizio degli Sforza , ed in tale circostanza ( come ricorda Pietro durante l'ultimo processo ) aveva conosciuto il padre del cardinal Morone che gli aveva usato diverse cortesie Questa ragione di gratitudine adduce Pietro per giustificare la sua conoscenza ed intimita' col cardinal Morone
Antecedente a questo periodo lombardo questo dono del Marchese di Mantova ( Andrea nel 1485 aveva 17 anni )
Il Busini su Andrea di Paolo di Simone
Parlando dell'eroica resistenza fiorentina non posso tralasciare di accennare a :
Francesco Ferrucci alcune note sulla vita e la morte di Francesco Ferrucci
Amico d'Arsoli dei Passamonti Amico d'Arsoli dei Passamonti uno dei capitani di Francesco Ferrucci ( Ricevo da Vincenzo Passamonti )
E non possiamo dimenticare " il gran soldato" emulo di Francesco Ferrucci nella Romagna fiorentina LORENZO di ZANOBI di SIMONE
Lorenzo di Zanobi di Simone e' l'uomo fermo nelle sue convinzioni repubblicane ,che quando fu chiamato alla prova tutto diede alla patria fiorentina : vita e beni
Pochi fiorentini conobbero il valore di Lorenzo Carnesecchi ,assediati dagli imperiali e chiusi tra le mura della citta' riponevano la speranza in Francesco Ferrucci l'eroico commissario di Empoli che combatteva nei dintorni del territorio fiorentino con valore e intrepidezza leggendarie
Del valore di Lorenzo non potevano giungere che vaghe notizie a Firenze troppo distante era il tearro delle sue gesta Ed infatti pochissimi hanno scritto compiutamente di lui Nel 1912 Carlotta Lotti e recentemente Alessandro Monti
Dice Carlotta Lotti :
Sfogliando un giorno le Istorie Fiorentine del Varchi, rimasi sorpresa di trovare spesso accanto al nome del Ferruccio quello di un cittadino sconosciuto, di Lorenzo Carnesecchi. " Nè si dubita dagli uomini prudenti ", scrive il Varchi a proposito del governo di Firenze durante l' assedio, " che se avessono eletto uno solo senza guardare ad altro che alla sufficienza, come esempigrazia il Ferruccio o Lorenzo Carnesecchi o alcuno altro ancora di minore virtù e fattolo dittatore da dovero, le cose sarebbono state per avventura governate altramente ch'elle non furono e per conseguenza avuto altro fine ch'elle non ebbero ".. Egli asserisce inoltre che il Papa temeva molto questi due valorosi e quando Firenze perdè quasi tutto il suo dominio , ultime fedeli alla Repubblica rimasero Empoli, Pisa, Livorno difese dal Ferruccio e Castrocaro " dov'era Commissario quasi un altro Ferruccio, Lorenzo Carnesecchi ". Non possiamo mettere in dubbio la verità delle parole di questo autorevole storico, che fu presente e prese parte agli avvenimenti da lui narrati. Anche il Busini , il Nardi , il G iannotti e più tardi, sulle orme del Varchi, il Perrens il Guerrazzi, il Capponi e perfino il Frassineti ed il Mini nelle loro illustrazioni del Castello di Castrocaro, sono tutti d'accordo nel lodare il Commissario della Romagua fiorentina: ma nessuno si è curato di far conoscere l' opera complessiva di questo guerriero, tantochè il nome di lui non si trova nei dizionari biografici storici. Solamente Eugenio Albèri, insieme con alcuni documenti sull'Assedio di Firenze, pubblicò una lettera del Carnesecchi col seguente avvertimento: " Benchè non strettamente pertinente " ai fatti dell'Assedio di Firenze ci è parsa importantissima la presente lettera, sia per spargere alcuna luce sulle cose poco conosciute dei Fiorentini in quelle parti, sia per offerire un onorevole documento intorno uno dei migliori cittadini che a quei di vantasse la Repubblica ". Mentre nell'animo di tutti è viva l'immagine di Francesco Ferrucci, mentre l' Italia si accinge a consacrarne la memoria con un monumento degno di lui che sorgerà a Gavinana, dove egli cadde gloriosamente combattendo per la patria, riandando col pensiero ai gloriosi difensori della, Repubblica Fiorentina, ho voluto pubblicare questo modesto scritto su Lorenzo Carnesecchi per far conoscere agli Italiani un altro guerriero, ignorato dal piu' e degno di avere un posto nella Storia tra quelli che amarono la patria e la libertà. ………………………………………………………………………………………………….. Lorenzo Carnesecchi adunque fu un grande patriotta, un ardito guerriero, una di quelle figure luminose che di tratto in tratto s'innalzano dalla polvere del mondo e dedicano la loro vita ad una grande idealità dell' anima, facendoci acquistare la fiducia nel bene e la virtù di operarlo. E quando la storia segue le vicende di uno di questi eroi e ne narra le gesta " non é più solamente la maestra, osserva il prof. Del Lungo, sì anco la Poesia della vitá ".
Lorenzo di Zanobi di Simone Carnesecchi ……….Lorenzo Carnesecchi il gran soldato Il secondo Ferruccio : L'uomo che mise una taglia sulla testa del Pontefice
Carlotta Borgia Lotti Lorenzo Carnesecchi di Carlotta Borgia Lotti parte prima
Carlotta Borgia Lotti Lorenzo Carnesecchi di Carlotta Borgia Lotti parte seconda
NOTIZUOLE AL MARGINE DELL'ASSEDIO
……Francesco Ferrucci casualmente libera i figli di Bastiano Carnesecchi e di Niccolo’ Machiavelli caduti prigionieri degli imperiali
CARNE DI CAPPONE E CARNE SECCA Non so se questo episodio dei tempi dell'Assedio sia vero o inventato di sana pianta , comunque lo riportano in diversi senza darne la fonte ( ad esempio Luciano Berti in Pontormo e il suo tempo) Come talvolta avviene si mettono in moto dei passaparola di cui si perde l'origine Caterina Ridolfi seconda moglie di Ludovico Capponi ,donna di rinomata bellezza con la figliastra Francesca , e con altre due fanciulle de' Carnesecchi loro parenti si erano rifugiate nella cittadella di Volterra per evitare il blocco che cingeva Firenze La città si era schierata dalla parte dei Medici, sostenuti dall'imperatore Carlo V e papa Clemente VII. Ma Volterra da luogo sicuro venne a trovarsi in prima linea nelle vicende della guerra Francesco Ferrucci, commissario della Repubblica, la occupò e vi si asserragliò con i suoi uomini nell'estate del 1530. La città venne assediata dalle milizie di Fabrizio Maramaldo e dalle truppe spagnole ma i volterrani dettero aiuto al Ferrucci temendo il saccheggio . L'assedio fu lungo e più volte vennero tentati degli assalti poi gli imperiali furono costretti a togliere l'assedio e a ritirarsi. Si dice che mentre Volterra era assediata dagli Imperiali , che ne pregustavano le violenze del saccheggio , Ferdinando Gonzaga avesse dichiarato lussuriosamente di volersi cibare di 'carnesecca ', e il famigerato Fabrizio Maramaldo a sua volta di 'carne di Cappone». Erano spacconerie da soldati ma in quei tempi spesso alle parole seguivano i fatti Come racconta la Storia contro l'arroganza degli imperiali prevalse il valore e la resistenza di Francesco Ferrucci e dei Volterrani
Francesca Capponi, primogenita di Ludovico Capponi e di Marietta Martelli e' stata immortalata dal Pontormo : Ritratto di Francesca Capponi in sembianze di Maddalena Francesca nata nel 1511 mori durante l'assedio quindi di 19 anni , E' possibile che le fanciulle dei Carnesecchi fossero figlie di Andrea di Paolo di Simone Carnesecchi che era stato sposato con Caterina di Mico di Uguccione Capponi
L'episodio potrebbe avere una sua realta' Immagino che le donne si fossero rifugiate in una Volterra filomedicea perche' sia Lodovico che Andrea erano filomedicei ( Andrea , come detto , fu tra coloro che vennero imprigionani nei giorni dell'assedio di Firenze come persone sospette ) Che quindi avessero inviato le loro donne in un posto che all'inizio della guerra ritenevano sicuro e che era poi divenuto una trappola ( in quei tempi durante un saccheggio non faceva davvero distinzioni tra amici e nemici e qualunque cosa anche lo stupro diveniva lecita )
Di Andrea conosco pero' solo queste figlie femmine Camilla nata nel 1492 ( da Caterina Capponi ) e Vaggia nata nel 1509 ( da Ginevra Tani ) ma puo' essere che mi sia sfuggito qualcosa Occorerebbe consultare i catasti cosa che non ho potuto fare
Lodovico Capponi seniore era figlio di Gino Capponi e di Adriana Gianfigliazzi, fu banchiere fin da giovane, lavorando per il banco dei Martelli a Roma e sposandone una componente, Marietta. Nella città papale fu tra i promotori della fondazione della chiesa di San Giovanni dei Fiorentini. A Roma fu in contatto con i principali artisti della corte pontificia, compreso Raffaello. A Firenze, dove era tornato dopo la morte di Leone X nel 1522, fu prima contrario al dominio mediceo e poi lo appoggiò. Nel 1525, ormai quarantenne, iniziò a preoccuparsi per la sepoltura sua e della propria famiglia, acquistando dalla famiglia Paganelli la cappella già Barbadori, nella chiesa di Santa Felicita, dall'architettura brunelleschiana. Fu lui a commissionare al Pontormo la decorazione pittorica della cappella comprendente la famosa Deposizione. Poco lontano dal palazzo di famiglia, il palazzo Capponi delle Rovinate in via de' Bardi. I lavori durarono tre anni, fino al 1528, e compresero la realizzazione della pala, dell'affresco dell'Annunciazione e dei quattro tondi con Evangelisti, ai quali collaborò anche il giovane Agnolo Bronzino. Perduto è invece l'affresco col Giudizio Universale nella volta, distrutta nel Settecento per permettere l'affaccio in chiesa tramite il corridoio Vasariano......... da wikipedia
Da Caterina Ridolfi Lodovico ebbe sette figli
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Tra il 14 ottobre 1529 e il 12 agosto 1530 la Repubblica di Firenze, restaurata nel 1527 con l’estromissione dei Medici dal governo della città, subisce un drammatico asse-dio da parte delle truppe imperiali di Carlo V. Per esorcizzare il terrore della guerra e schernire i nemici, il 17 febbraio del 1530 alcuni fiorentini organizzano una gara di calcio storico in piazza Santa Croce.
Benedetto Varchi ricostruisce in questi termini l’avvenimento patriottico, che simboleggia il coraggio e la fierezza dei cittadini di fronte all’esercito aggressore: i giovani, sì per non intermettere l’antica usanza di giocare ogn’anno per carnovale, e sì ancora per maggior vilipendio de’ nimici, fecero in sulla piazza di Santa Croce una partita a livrea, venticinque bianchi e venti-cinque verdi, giocando una vitella; e per essere non soltanto sentiti, ma veduti misero una parte de’ sonatori con trombe e altri strumenti in sul comignolo del tetto di Santa Croce, dove dal Giramonte fu lor tratto una cannonata; ma la palla andò alta, e non fece male né danno a nissuna persona.
L’orgoglio dei giovani si manifesta in modo temerario e provocatorio attraverso un gioco inserito da tempo tra le pratiche distintive della civiltà fiorentina.
( Matteo Bosisio)
La caduta della Repubblica : la perdita della liberta'
|
LA CADUTA DELLA REPUBBLICA FIORENTINA
La caduta della Repubblica e l'avvento del Principato ha immensi riflessi sulle vicende di tante persone , sull'economia , sulla politica , sulla storia .
12 agosto 1530 una Firenze stremata e tradita da Malatesta Baglioni e' costretta a firmare la resa alle forze imperiali
20 agosto 1530 Una Balia di partigiani dei Medici depone le istituzioni repubblicane e ripristina la dominazione medicea sulla citta'
Atto di capitolazione della Repubblica fiorentina 12 agosto 1530
dalla "Storia fiorentina" di Benedetto Varchi
I quattro ambasciadori dopo qualche contrasto, e massimamente in chi s'aveva a rimettere la riforma del governo, o nel papa o nell'imperadore, e quanti danari s'avevano a pagare, conchiusero l'accordo. Non volevano ancora, che vi si ponesse quelle parole, Intendendosi sempre che sia conservata la libertà; ma Pierfrancesco, Lorenzo e lacopo dissero, che non potevano convenire altramente, e che quel popolo eleggeva prima d'andar a fil di spada; e Pierfrancesco ebbe parole con messer Bardo, e lo sgridò perché egli separatamente da loro andava favellando a solo a solo, ora col commessario e ora con don Ferrante per acquistarsi la grazia loro, non altrimente ingerendosi, che se in lui fosse stato il tutto rimesso. Tornarono la sera a sei ore di notte co' capitoli, i quali furono approvati agli undici, e a' dodici si stipulò il contratto, il quale m'è paruto di porre tutto di parola a parola:
|
|
storiaaristocraziafiorentina
vai alla pagina 25 prima parte Storia dei Carnesecchi : periodo dal 1494 al 1532 vai alla pagina 25 seconda parte Storia dei Carnesecchi : periodo dal 1494 al 1532 vai alla pagina 25 terza parte Storia dei Carnesecchi : periodo dal 1494 al 1532 vai alle note alla pagina 25 Note al periodo 1494-1532
BENEDETTO VARCHI
Storia fiorentina ………………………Storia fiorentina di Benedetto Varchi volume 1 Storia fiorentina ………………………Storia fiorentina di Benedetto Varchi volume 2 Storia fiorentina ………………………Storia fiorentina di Benedetto Varchi volume 3
Se leggere Benedetto Varchi e le lettere del Busini e' imprescindibile per saperne qualcosa , dobbiamo oggi rivolgerci a quegli storici che ad anni di distanza hanno ripensato a quei momenti Se l'immediatezza dei fatti rende piu' facile raccogliere le informazioni , la distanza dei fatti rende la loro lettura piu' scevra dalle passioni e piu' libera dalle catene dei potenti
sono quindi imperdibili per conoscere di piu' sono i libri di Alessandro Monti sull'argomento L'assedio di Firenze (1529-1530) Politica, diplomazia e conflitto durante la guerra Pisa University Press 2015 La guerra dei Medici. Firenze e il suo dominio nei giorni dell'assedio (1529-1530) “Firenze 1530. L’assedio, il tradimento. Vita, battaglie e inganni di Malatesta Baglioni, capitano dei Fiorentini” di Alessandro Monti, Collana Manes - Editoriale Olimpia, 2008
Quando terminò, con la resa della Repubblica fiorentina il 12 agosto 1530, la “Guerra dei Medici”, a spregio degli accordi di pace che prevedevano l’impunità per tutti combattenti, i vincitori: l’imperatore Carlo V e il papa Clemente VII, mai nome fu più inappropriato, lasciarono che si scatenasse la vendetta dei vincitori. I Medici tornarono a dominare Firenze e la Toscana fino all’avvento dei Lorena nel 1737. La guerra sconvolse dal 1529 al 1539, tutta la Toscana e la Romagna toscana; vide all’opera per la difesa di Firenze il genio di Michelangelo Buonarroti, coinvolse condottieri spregiudicati e geniali come Malatesta Baglioni, uomini d’onore nel senso vero del termine come il Duca d’Orange. Si deve al bel libro di Alessandro Monti “La guerra dei Medici”, un resoconto preciso delle varie fonti storiche, una narrazione appassionata del “blitz” di Castelfiorentino e la presa di San Miniato al Tedesco; le gesta eroiche di Lorenzo Carnesecchi a Castrocaro, la morte di Francesco Ferrucci a Gavinana, il massacro di Lastra a Signa da parte dei Lanzichenecchi di Carlo V, l’ imboscata di Montopoli dove fu vendicata la strage della Lastra. Dal sacco di Empoli, all’assedio di Volterra, alla battaglia di San Donato in Polverosa a nord fuori le mura della città di Firenze, questo “romanzo” dove atti eroici e viltà si intrecciano mettendo a nudo in quella prima metà del Cinquecento, la fragilità dei patti, la ferocia dei combattenti, tutte le sfaccettature del potere sia laico che clericale, offre uno spaccato di vita terribile dietro la magnificenza delle corti e gli splendori delle arti. by https://www.gonews.it/2020/10/29/guerra-dei-medici-la-storia-vera-tra-san-miniato-e-castelfiorentino/
L’ASSEDIO DI FIRENZE (1529-1530) Politica, diplomazia e conflitto durante le Guerre d’Italia tesi di dottorato di Alessandro Monti
ed anche Paolo Simoncelli Fuoriuscitismo repubblicano fiorentino 1530-1554 La Repubblica fiorentina in esilio. Una storia segreta: 1
|
C'e' un equivoco su una Ravenna Carnesecchi
Una ( ipotetica figlia di Piero ) viene detta bisnonna di Francesco come moglie di altro Francesco ( di Bindo )
Una Ravenna figlia di Filippo di Piero Carnesecca e' ricordata nel diario del Velluti come sposa di un Francesco Velluti
Ambedue vengono dette vedove di un Mancini
Che fa pensare ad un equivoco ancora da risolvere
|
Francesco Ferrucci (+ 1377), fu commerciante; Gonfaloniere di compagnia nel 1369, castellano di Colle nel 1369, dei Capitani di Parte Guelfa nel 1372, dei Priori delle Arti nel 1373, Scrittore e Ragioniere dell’Ufficio della condotta sui soldati nel 1373, Podestà di Pescia nel 1377. Sposa nel 1363 Ravenna, figlia di Piero Duranti (della stirpe dei Carnesecchi), già vedova di Duccino di Giachetto Mancini
Figlio
Leonardo (+ 21-9-1417), Vicario di Lari nel 1410, dei Priori delle Arti nel 1411, Capitano del Popolo di Pistoia nel 1412, Podestà di Chiusi nel 1415. sposa Nanna (+ 28-7-1466).
Da http://www.sardimpex.com/files/FERRUCCI.htm
|
Compaiono un Francesco Velluti e un Francesco Ferrucci
Francesco di Bindo predetto, fu , ed è grande e impersonato , e bene complesso , e bene intendente e subito, e assai adattato alla mercatanzia. E' stato a mercatanzia con altrui in Firenze, Vinegia, Mompolieri, e in più altre città, e paesi. Tornato da Mompolieri dopo lamortalità del 1363. tolse per moglie Monna Venna, figliuola di Filippo di Piero Carnesecca vedova , la quale era stata moglie d' un figliuolo di Giachetto Mancini , la quale poco tempo era stata col primo marito, giovane, grande della persona, e oggi è grossa.. E' il detto Francefco d' età da'trenta a' trentacinque anni. Quello, dilui , e de' suoi discendenti seguirà , io, o altri il.potrà scrivere qui da piè. Fece una fanciulla femmina adì 13. di Gennaio 1367. e poi un' altra nel 1369. Fu il detto Francefco Gonfaloniere di Compagnia di Maggio 1369. .per-la borsa del 1360. sicchè è imborsato all'Uficio del Priorato della detta borsa. . . . ,'
da la :
La cronica domestica: scritta fra il 1367 e il 1370
di Donato Velluti, Paolo Velluti, Isidoro Del Lungo, Guglielmo Volpi - 1914 - 358 pagine
Pagina 128
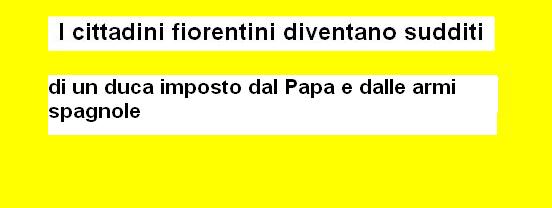
|
ESTRAZIONE A SORTE DELLA SIGNORIA by VITI E ZACCARIA ESTRAZIONE A SORTE DELLA SIGNORIA by VITI E ZACCARIA
DAL SITO DELLA BROWN UNIVERSITY : studio sulle tratte Online Tratte of Office Holders 1282-1532 by David Herlihy, R. Burr Litchfield, Anthony Molho and Roberto Barducci.
Lo studio della cultura politica del Rinascimento fiorentino richiede la capacità di saper valutare chi occupava gli uffici, e i vari modi nei quali mutava nel corso del tempo l’elite politica effettiva. Fin dal diciottesimo secolo, come sappiamo, sono state pubblicate liste (prioristi) di nomi di individui eletti agli uffici del Gonfalonierato di Giustizia e del Priorato, componenti la Signoria. Ma Herlihy intendeva allargare la valutazione del gruppo dei più importanti detentori di uffici, selezionando dai Giornali delle Tratte (le registrazioni originali dei nomi degli uomini sorteggiati) anche i componenti degli altri due Collegi sussidiari che completavano i “Tre Maggiori” (i Buonuomini e i Gonfalonieri di Compagnia). Inoltre egli voleva esaminare, della Signoria e dei Collegi, non soltanto i “seduti” in ufficio, ma anche quelli rifiutati durante le estrazioni periodiche. Egli pianificò sicuramente, in vista di un’analisi informatica che si sarebbe presentata di grande estensione, ciò che egli avrebbe potuto ricavare da queste liste codificate.
L’esercizio degli uffici a Firenze funzionava a livelli differenti: 1) i “Tre Maggiori” (Signoria e Collegi—gli uffici esecutivi), 2) gli uffici amministrativi (gli Otto di Guardia e Balia, Capitani di Parte Guelfa, ecc., più i Vicari e i Podestà inviati nelle città del dominio fiorentino.), e 3) (al più basso livello) i Consoli delle Arti delle 21 Arti Maggiori e Minori.
I Tre maggiori (Serie 05). I Tre Maggiori, i più alti uffici esecutivi della Repubblica fiorentina, erano formati dal Gonfaloniere di Giustizia e dai Priori (assistiti da un notaio), e da due consigli consultivi: i Buonuomini e i Gonfalonieri di Compagnia. Il Gonfaloniere di Giustizia e i Priori venivano chiamati la “Signoria”; i due consigli consultivi i “Collegi”. L’iter legislativo era iniziato dalla Signoria, discusso in consultazione con i Buonuomini e i Gonfalonieri di Compagnia, e poi, in certi casi, approvato oppure rigettato dal Consiglio generale del Popolo o dal Consiglio del Comune. In alcune circostanze speciali Balie temporanee elette ad hoc, i cui membri comprendevano gli uomini correntemente eletti ai Tre Maggiori, ma anche molti altri, venivano incaricate di trattare materie di particolare peso e significato politico. . . 1282 -- Giugno. Furono eletti i primi tre priori (Priori delle Arti): Bartolo di Iacopo Nardi (dell’Arte di Calimala e del Sestiere di Oltrarno), Rosso Bacherelli (Arte del Cambio, Sestiere di S. Piero Scheraggio), e Salvi di Chiaro Girolami (Arte della Lana, Sestiere di S. Pancrazio). I precedenti governi della città erano stati per la maggior parte nobili. In agosto il numero dei priori aumentò a sei (in rappresentanza di diverse arti e di ciascuno dei sei Sestieri della città). I Priori erano eletti con vari metodi, ma almeno inizialmente per cooptazione in consultazione con i Priori uscenti, i Savi e i Consoli delle Arti Maggiori. . . .1293 – Dal novembre 1292 fino alla primavera del 1293: “Ordinamenti di Giustizia”. Questi ultimi definirono ulteriormente i più alti uffici e affrancarono qualcuna delle Arti Minori. Essi difesero i caratteri “Guelfi” del regime escludendo i nobili (“magnati”, spesso “Ghibellini”) dall’accesso alle cariche. Un settimo priore apparve come Gonfaloniere di Giustizia (“vexillifer iustitiae”), con il compito di eseguire le sentenze giudiziarie pronunciate dal Podestà (ufficiale giudiziario principale—sempre forestiero) e di assumere la guida della milizia delle arti. . . 1293 – Febbraio. Primo Gonfaloniere di Giustizia: Baldo Ruffoli del Sestiere di Porta del Duomo. Egli è conosciuto (secondo il Davidsohn) per essere stato un protetto di Giano della Bella, il cui nome è spesso associato agli Ordinamenti di Giustizia e che era uno dei Priori nominati nel febbraio 1293. . . La costituzione fiorentina si avviò a farsi decisamente stabile. Comunque, le circostanze politiche influenzarono l’elezione dei Tre Maggiori in molti e significativi punti. Le politiche fiorentine del quattordicesimo secolo furono influenzate dalle contese interne e dai rapporti internazionali, e da un raffinamento del processo elettorale. (Per una esauriente e dettagliata discussione dello sviluppo del sistema politico nel quattordicesimo secolo, vedi John M. Najemy, Corporatism and Consensus in Florentine Electoral Politics, 1280-1400. [Chapel Hill: University of North Carolina Press, 1982].) . 1301 – Nella continua lotta fra i Guelfi “Bianchi” (Cerchi) e “Neri” (Donati), Corso Donati (sostenuto dalle truppe di Carlo di Valois) entrò in città in ottobre, liberò i prigionieri, attaccò il Palazzo della Signoria ed impose il 7 novembre l’elezione di una Signoria alternativa (tutta “Nera”), che rimase in carica fino all’entrata in ufficio della successiva, regolarmente eletta il 15 dicembre. Quindi nel novembre del 1301 ci furono due liste di priori. I “Bianchi” non tornarono al potere. Dante Alighieri (che aveva servito una volta come priore) fu esiliato da Firenze nel 1302 nel pieno della crisi. . 1304 e 1313-16 – Come risposta alle ulteriori lotte civili il gruppo al potere prese la precauzione di raddoppiare quasi il numero dei priori nelle elezioni del febbraio e dell’aprile 1304, fra le elezioni dell’aprile 1313 e quelle dell’agosto 1314, e in quelle dell’ottobre e del dicembre del 1316. Perciò in questo periodo troviamo un numero doppio di priori. . 1328 – Una riforma del sistema elettorale stabilì che l’elezione per gli uffici più importanti dovesse effettuarsi per sorteggio (estraendo a caso da borse: la Tratta, al plurale le Tratte) dopo periodici scrutini preventivi dei candidati eleggibili. Nonostante che i dodici Buonuomini (due per ciascun Sestiere – dal 1321) e i diciannove Gonfalonieri di Compagnia (portabandiera della milizia urbana – quattro dal Sestiere di Oltrarno e tre da ciascuno dei rimanenti Sestieri -- dal 1304-06 circa) esistessero da prima, la prima lista di nomi del Priorista di Palazzo (registrazione ufficiale dei membri della Signoria) per i Gonfalonieri di Compagnia è disponibile a partire da quelli entranti in ufficio il 7 dicembre, e per i Buonuomini da quelli entranti il 12 dicembre 1328. . 1343 – Successivamente al tentativo di Gualtieri di Brienne (il cosiddetto Duca d’Atene) di assumere la Signoria di Firenze (dal settembre 1342 fino al luglio 1343), il gruppo che lo destituì varò una riforma del sistema di selezione per i più alti incarichi. In agosto, quattordici Riformatori sotto la guida del vescovo di Firenze, Agnolo Acciaioli, rimossero senza indugio la proibizione dell’accesso alle cariche nei confronti dei “magnati” (“grandi”). I nomi del consiglio consultivo eletto in quel mese in sostituzione dei Buonuomini assommavano quattro “grandi” (Bartolo di Iacopo Bardi, Domenico di Iacopo Cavalcanti, Nepo di Doffo Spini e Beltrame Pazzi) a quattro “popolani” (Adovardo Belfredelli, Francesco di Lotto Salviati, Piero di Feo e Piero Rigaletti). . I Riformatori ristrutturarono la città dai sei Sestieri esistenti in quattro Quartieri, più adatti questi ultimi a contenere l’espansione della popolazione verso il terzo cerchio di mura, costruito di recente. Il Sestiere di Oltrarno divenne il quartiere di S. Spirito, il Sestiere di S. Piero Scheraggio e un terzo di quello di S. Piero Maggiore si trasformarono nel quartiere di S. Croce, i Sestieri di S. Trinita e di S. Pancrazio composero il quartiere di S. Maria Novella, e il Sestiere di Porta del Duomo e due terzi del Sestiere di S. Piero Maggiore dettero vita al quartiere di S. Giovanni.
La soluzione adottata per il nuovo sistema di selezione dei priori riservò un posto sicuro ai “grandi”. Nell’elezione di dodici priori nell’agosto del 1343, uno per ciascun quartiere fu scelto fra i “grandi, e due fra i “popolani”. Ma i “grandi” priori furono espulsi dalla città il 22 settembre e la contro-soluzione adottata dai rimanenti priori “popolani” dall’agosto fino alla successiva elezione dei priori (ottobre 1343) avviò un sistema destinato a continuare: il Gonfaloniere di Giustizia e il Notaio, otto Priori (due per ciascun quartiere), esclusione dei “grandi” dalle cariche degli uffici, elezione dei priori sia dalle Arti Maggiori che da quelle Minori (in differenti, ma variabili proporzioni). La distribuzione dell’ufficio fra diverse Arti fluttuò durante gli anni ’40 e i primi anni ’50. Il numero dei Buonuomini rimase di dodici dopo la riforma del 1343, ma il numero dei Gonfalonieri di Compagnia fu ridotto da 19 a 16, nel rapporto di uno per ciascuno dei quattro Gonfaloni componenti ciascun quartiere. (Nessun nome di regolari Buonuomini fu registrato nel Priorista di Palazzo o nei Giornali delle Tratte tra l’elezione del maggio del 1342 e il giugno 1346, o dei Gonfalonieri di Compagnia fra il luglio 1342 e il dicembre 1345.) Cambiarono anche le date d’ingresso in ufficio. Se in precedenza il Gonfaloniere di Giustizia, il Notaio e i Priori cominciavano il loro periodo di due mesi il 15 del mese, adesso essi sarebbero entrati in carica il primo giorno del mese successivo all’elezione: gennaio, marzo, maggio, luglio, settembre e novembre. I Gonfalonieri di Compagnia cominciavano il loro periodo di quattro mesi il 7 del mese seguente a quello delle elezioni: gennaio, giugno e settembre. I Buonuomini invece cominciavano il loro periodo di tre mesi il 15 (dicembre, marzo, giugno e settembre) ed erano estratti intorno al 12 di quello stesso mese. In un dato anno il primo termine dell’entrata in carica per Gonfaloniere di Giustizia, Notaio e Priori, e per i Gonfalonieri di Compagnia cominciava nella prima settimana di gennaio dopo la loro elezione negli ultimi giorni di dicembre del precedente anno; il primo termine per i Buonuomini per quello stesso anno cominciava il 15 dicembre del precedente anno. (Nonostante che secondo il calendario fiorentino, in uso fino al 1751, l’anno cominciasse il 25 marzo, il primo termine degli incarichi per un anno cominciava nondimeno in dicembre-gennaio, quando l’intero complesso degli uffici cambiava contemporaneamente). . 1348 – La Morte Nera decimò così radicalmente la popolazione di Firenze, che le borse dello scrutinio del 1343 dovettero essere aperte e i nomi letti a voce alta per verificare chi fosse ancora tra i viventi, e nuove borse furono create (Borsa vecchia, Borsa dei Morti, Borsa nuova). Prima del 1348 la popolazione di Firenze poteva aver raggiunto all’incirca i 100.000 abitanti; in seguito essa fluttuò intorno ai 50.000, con forse 20.000 in meno nel tardo Trecento e nel primo Quattrocento, e forse 20.000 in più nel tardo Quattrocento e nel primo Cinquecento. . . Scrutini : Il primo passo per conseguire l’ufficio era quello di superare uno degli scrutini periodici dei candidati considerati eleggibili. I candidati dovevano essere iscritti ad una delle arti e (almeno inizialmente) esercitare un lavoro effettivo. Gli scrutini erano tenuti, e i nomi proposti poi votati, da speciali commissioni che avevano una composizione varia. Teoricamente, uno scrutinio veniva indetto all’incirca ogni cinque anni, ma, come ogni altro aspetto, anche quello relativo agli incarichi agli uffici implicava considerazioni di tipo politico. Poteva infatti essere di grande vantaggio per il gruppo al potere procrastinare l’organizzazione di uno scrutinio e la creazione di nuove borse. Comunque, una crisi politica generalmente sollecitava un nuovo scrutinio. . . Estrazioni e divieti : Le borse contenenti le cedole con il nome erano tenute sotto chiave nella sacrestia della Basilica di Santa Croce. La cassetta in cui erano conservate veniva portata nel Palazzo della Signoria e aperta in presenza del Gonfaloniere di Giustizia, dei Priori, dei Collegi e di altri ufficiali. Le estrazioni eseguite dal Notaio della Signoria (uno degli ufficiali amministrativi subordinati) cominciavano con il più vecchio gruppo di borse (un nuovo scrutinio non negava il diritto degli individui scrutinati precedentemente di aspirare agli uffici -- e le Borse più vecchie erano talvolta unite insieme). I nomi erano estratti e la loro corrente eleggibilità era così determinata. La pura e semplice estrazione iniziale significava che un uomo era stato “VEDUTO”, ma questo non voleva dire che egli fosse anche “SEDUTO” in ufficio. I divieti (proibizioni all’accesso alla carica) potevano scaturire dal fatto che un individuo aveva avuto un incarico di recente, oppure che un esponente della sua famiglia lo deteneva in quel momento. In modo crescente, via via che il sistema si sviluppava, i padri immettevano negli scrutini i loro figli minori, e l’individuo estratto poteva non raggiungere l’età richiesta per quell’ufficio. Inoltre, altri individui potevano essere assenti da Firenze, in arretrato con le tasse (speculo), o soggetti ad una grande varietà di condizioni. Ancora, l’individuo in questione poteva essere morto da quando il suo nome era stato posto inizialmente in una borsa. L’estrazione dei candidati considerati eleggibili continuavano fino a che il numero esatto degli incaricati era “seduto”. Il nome degli uomini estratti agli uffici (“VEDUTI” e “SEDUTI”) erano registrati nei “Giornali” delle Tratte (la nostra fonte principale). Le entrate nei giornali cominciarono il 29 dicembre 1345, ma all’inizio non tutti i nomi furono inseriti ed inoltre c’erano alcune lacune negli stessi Giornali. Prima e dopo il 1345 abbiamo recuperato i vuoti della Signoria grazie al Priorista di Palazzo. Ma questo non è stato possibile per i due Collegi, essendo i Giornali l’unica loro fonte continuativa; ecco perché, soprattutto nel quattordicesimo secolo, per questi uffici sono rimaste delle lacune (vedi le “Notes on the coding and editing of the data file”). Comunque, per quanto ne sappiamo, non è restata per nessun altro sistema elettorale una fonte tanto antica e dettagliata, come quella contenuta nei Giornali delle Tratte. 1378 – Il tumulto dei “Ciompi”. La vana rivolta dei Ciompi, organizzata dalle Arti Minori e dagli uomini fuori dalle corporazioni (“scorporati”), mirava alla riduzione dell’assoluta prevalenza esercitata negli uffici dagli uomini delle Arti Maggiori. I turbulenti e sanguinosi eventi di quella estate si riflessero nell’identità degli uomini estratti ai Tre Maggiori. La nuova Signoria eletta il 26 luglio si evidenzia per le occupazioni inusuali attribuite al Gonfaloniere di Giustizia e ai Priori, poi per le sostituzioni fatte il 2 settembre, ed infine per l’elezione di una Signoria, sotto l’egida dei Ciompi in agosto/settembre, tratta da tre borse rappresentanti differenti tipi di arti: Arti Maggiori, Arti Minori e “Popolo di Dio” (i lavoratori non organizzati). Ancora si possono notare una frequente e particolare mortalità, nonché varie sostituzioni avvenute fra i Gonfalonieri di Compagnia nel 1378. La distribuzione degli uffici (“distributio”) fra le Arti Maggiori e quelle Minori . Non soltanto gli uffici venivano rigorosamente distribuiti fra le differenti circoscrizioni urbane, ma un’ulteriore selezione veniva fatta in base all’appartenenza alle Arti Maggiori o Minori, determinando la creazione di differenti borse. Questa particolarità fu ben evidente durante gli anni ’40 e al tempo dei Ciompi, e i caratteri della distribuzione ebbero ulteriori sviluppi nelle due decadi seguenti al tumulto. Per quanto riguarda le implicazioni politiche del sistema elettorale, anche le arti vi contribuirono, mutando nella loro organizzazione, e venendo così a rappresentare non tanto lavori individuali economicamente distinti, quanto coalizioni politiche di attività (tra le Arti Maggiori i Medici e gli Speziali; tra le Arti Minori gli Oliandoli e i Pizzicagnoli). Dalla fine degli anni ’40 l’ufficio del Priorato era distribuito in modo che due degli otto priori per ciascuna elezione provenissero dalle Arti Minori; il resto da quelle Maggiori. La selezione del Gonfaloniere di Giustizia ruotava ogni volta secondo il quartiere, e il quartiere del Gonfaloniere ero lo stesso dei due priori provenienti dalla Arti Minori. Tale distinzione si evince dalle occupazioni riportate per i priori, e là dove i Giornali delle Tratte o i Prioristi non la rilevano, noi l’abbiamo invece aggiunta fra il 1350 e l’elezione dei priori nel 1378 (TPURS ’99’ vuol dire Arti Maggiori o “sconosciuta” e ‘03’ Arti Minori). La distinzione fra le borse è chiaramente indicata nei Giornali del 1378. Comunque, nelle due decadi dopo il 1378 (fino a quando nel 1399 i Giornali ripresero ad annotarla) il sistema continuò a svilupparsi, e perciò non è sempre certo da quale borsa gli individui venissero estratti, tanto che non abbiamo corretto il codice TPURS. Gli utilizzatori dell’archivio-dati dovrebbero saper dedurre l’arte alla quale appartenevano gli individui dalle loro occupazioni, quando riportate. Noi abbiamo colmato le lacune nel codice TPURS relativo alla Signoria per le Arti Minori dal 1399 fino alla fine della serie. Pure, in forma continuativa all’incirca dal 1382, vennero fatte distinzioni fra Buonuomini e Gonfalonieri. Ciò implicò un più complesso sistema di rotazione, che, comunque, non venne annotato nei Giornali fino al settembre del 1406 per i Buonuomini, e fino al dicembre dello stesso anno per i Gonfalonieri di Compagnia. Non abbiamo aggiunto distinzioni per le borse mancanti prima del 1406, ma in seguito abbiamo colmato le lacune ritenute ovvie. Nel sistema di rotazione un quarto degli uomini scelti per ciascuna elezione provenivano dalle Arti Minori. Per i Buonuomini questo significava tre su dodici individui per ciascuna elezione (uno per ciascuno di tre quartieri), che comportava l’esclusione delle Arti Minori da un quartiere per ogni assegnazione (per l’elezione di dicembre S. Maria Novella, per marzo dell’anno successivo S. Giovanni, in giugno S. Spirito e in settembre S. Croce). Per i Gonfalonieri di Compagnia il sistema era ancora più complesso: in ciascuna elezione quattro uomini delle Arti Minori erano scelti per rotazione fra i quattro “gonfaloni” di ciascun quartiere (ad esempio: in S. Maria Novella,Vipera [codice 31] per una elezione, seguita da Unicorno [32] nella successiva, Leon Rosso [33] in quella dopo, ed infine Leon Bianco [34], poi di nuovo Vipera, e così via.). . . Controlli elettorali . Un ulteriore problema nel sistema dell’estrazione per tratta, al di là di un’apparente, equa distribuzione degli uffici per circoscrizioni urbane e per gruppi di corporazioni, era quello di assicurare incaricati, o perlomeno uomini leali, al gruppo al potere. Già negli anni ’40 del Trecento venivano usati in certi casi gli “accoppiatori”, per preselezionare candidati prima dell’estrazione. Per conseguire tale scopo, fu adottato anche un altro mezzo, e cioè la selezione a favore delle Arti Maggiori della metà dei priori mediante uno speciale “Borsellino”, composto da artigiani “veri guelfi”, ritenuti leali verso il gruppo al potere – “quelli cittadini li quali paresse loro [la Signoria del 1387] che fossero molto confidenti allo Stato loro” -- come un cronista (Boninsegni) scrisse. Sembra che l’uso del Borsellino fosse cominciato all’incirca nel 1387, ma non fu annotato nei Giornali delle Tratte fino al 1404. Un’indicazione che gli uomini nel Borsellino fossero pre-selezionati è data dal fatto che nelle estrazioni per gli uffici riservati allo stesso Borsellino, prima che uno risultasse eletto (“seduto”), veniva “veduto” (codice 02) un numero inferiore di individui, rispetto alla borsa generale delle Arti Maggiori (codice 01). In sostanza la cerchia degli eleggibili era più ristretta. Comunque, nonostante questo vantaggio iniziale, anche gli uomini pre-selezionati avrebbero in seguito trovato .lo sbarramento dei Divieti. Anche se lo troviamo con minor frequenza nei Giornali dopo il 1440, il Borsellino venne usato per tutto il quindicesimo secolo fino alla sospensione delle Tratte da parte del Consiglio Maggiore nel 1495. Dopo la restaurazione dei Medici nel 1512, esso non fu più annotato nei Giornali delle Tratte. L’uso degli accoppiatori, benché non fosse attuato in tutti gli anni, fu un importante elemento del sistema elettorale nel quindicesimo secolo sotto il dominio dei Medici, e andò ben oltre la selezione di qualche priore attraverso il Borsellino. Per l’elezione d’ottobre nel 1403 e ancora per le elezioni d’ottobre del 1433 e 1434 (dopo il bando e poi appena dopo il ritorno di Cosimo de’ Medici) i nomi della Signoria mancano dai Giornali delle Tratte; perciò li abbiamo trascritti dal Priorista di Palazzo. Là dove emerge la lacuna c’è un’annotazione: “hic deficit prioratus”. Questo potrebbe indicare che gli uffici erano eletti a mano (cioè, in effetti, per nomina). (Il sistema del controllo elettorale sotto i Medici è approfonditamente discusso nell’opera di Nicolai Rubinstein, The Government of Florence under the Medici (1434-1494). [Second edition, Oxford: Clarendon Press, 1997].) . . . Registrazioni di nascita . In conseguenza della crescente tendenza dei padri ad inserire negli scrutini i loro figli al di sotto dell’età richiesta, ed alle richieste di età per gli incarichi agli uffici, gli individui nati dopo il 1381 furono invitati nel 1429 a dichiarare la loro data di nascita ai Conservatori di Legge. Ci fu un’ulteriore legislazione sulla materia nel 1457. Le “approvazioni di età” dei Conservatori di Legge non esistono più; i registri dell’Archivio delle Tratte dai quali abbiamo estratto le “date di nascita” per la Serie 10 sono per la maggior parte elenchi alfabetici adibiti ad uso interno delle stesse Tratte al tempo delle estrazioni. Dopo il 1457 sono segnate anche le date di registrazione della nascita. Qualche individuo, al tempo della registrazione, fornì la propria età, piuttosto che la data di nascita esatta e qualche data di nascita era dichiarata retrospettivamente fino agli ’80 del Trecento. Dopo il 1457 le date di nascita di circa metà degli uomini giovani erano dichiarate prima che essi raggiungessero i 20 anni. Tre quarti di secolo prima la media di tali individui si aggirava sui 30 anni. Le dichiarazioni erano più numerose negli anni dello scrutinio. Per l’esattezza, molti individui dei quali furono registrate le date di nascita mai occuparono un ufficio. . La legislazione del 1429 richiedeva che tutti gli individui aspiranti ad un incarico d’ufficio presentassero ai Conservatori di Legge una dichiarazione della loro data di nascita. Le dichiarazioni originali, che potessero inizialmente trovarsi nell’Archivio dei Conservatori di Legge, non esistono più da tempo. I registri contenuti nell’Archivio delle Tratte sono poderose compilazioni alfabetiche fatte dagli ufficiali addetti per uso interno al tempo delle estrazioni. Ciò fa di questi registri un qualcosa di davvero difficoltoso da usare, dal momento che alcuni sono copie più o meno complete di altri, e che al loro interno esiste qualche discrepanza nel complesso delle informazioni fornite. Dopo il 1457, in alcuni registri che sembrano i più originali e lungi dall’essere mere compilazioni, erano inclusi sia la data della registrazione della nascita, che il nome del notaio che l’aveva stesa. Un altro problema sorge dal fatto che alcuni individui registravano la loro data di nascita più di una volta, e in qualche caso con lievi variazioni nell’informazione fornita. Molti individui (circa il 30 per cento del totale che era registrato) mai tenne un incarico—essi possono essere morti o aver lasciato la città prima di raggiungere l’età richiesta.. Per evitare confusione, abbiamo rimosso puntualmente dall’archivio-dati le registrazioni di nascita doppie (circa 400 records), lasciando le datazioni più vecchie; comunque le registrazioni con informazioni variate sono state lasciate. Al presente valutiamo che il file possieda date di nascita per circa l’80 per cento degli individui che ottennero uffici dopo gli inizi del quindicesimo secolo. . . 1434 – Inizio del dominio dei Medici. Nel settembre del 1433 Cosimo di Giovanni de’ Medici, un oppositore del gruppo al potere capeggiato da Rinaldo di Maso degli Albizzi, fu arrestato e bandito da Firenze. Ciò provocò una crisi politica. La Signoria eletta nell’agosto del 1434, che entrò in ufficio il 1° settembre, indisse un’assemblea generale di cittadini, un “Parlamento”, che approvò la creazione di una Balia. Questa si riunì il 28 settembre, richiamò Cosimo il 29, poi esiliò Rinaldo degli Albizzi e qualcuno dei suoi seguaci. Ci fu di conseguenza un nuovo scrutinio di aspiranti agli uffici e vennero create nuove borse. I Medici esercitarono il loro dominio e la leadership su Firenze, occupando non molto spesso gli incarichi pubblici, come si può facilmente accertare dai registri delle Tratte. Alla morte di Cosimo de’ Medici (Pater Patriae), il 1° agosto 1364, gli successe come capo-famiglia suo figlio Piero (Il Gottoso), che morì il 3 dicembre. Egli fu seguito dal suo famoso figlio Lorenzo (Il Magnifico), che a sua volta spirò l’8 aprile del 1492. Il figlio di Lorenzo, Piero, fu espulso da Firenze nel novembre del 1494, in parte a causa degli errori diplomatici in cui incorse durante la crisi internazionale provocata dall’invasione dell’Italia da parte di Carlo VIII, re di Francia, che entrò in Firenze per breve tempo in quel mese. . . 1478 -- La cospirazione dei Pazzi. Un gruppo di cospiratori tentò di assassinare Lorenzo de’ Medici e suo fratello Giuliano in duomo, il 26 aprile del 1478. Lorenzo fuggì; Giuliano invece rimase ucciso. Iacopo di Andrea de’ Pazzi fu arrestato ed impiccato; il suo corpo fu profanato. L’elezione di nuovi Gonfalonieri di Compagnia il 28 aprile fu rimandata all’8 maggio. La cospirazione dei Pazzi probabilmente influenzò la creazione del Consiglio dei Settanta nel 1480, che assorbì alcuni dei poteri della Signoria; inoltre determinò il declino dell’influenza dei Tre Maggiori, che proseguì ulteriormente sotto il Consiglio Maggiore del 1494. . . 1494-1512 – Il Consiglio Maggiore. Nella reazione anti-medicea del novembre del 1494, un nuovo Parlamento e una Balia crearono il Consiglio Maggiore il 24 dicembre, un ingombrante consiglio con oltre 3000 membri (chiunque fosse stato eletto in precedenza ai Tre Maggiori, lui o un membro della sua famiglia, poteva parteciparvi). Il grande salone assembleare nel Palazzo della Signoria fu frettolosamente approntato per le sue riunioni. Il salone doveva essere inizialmente affrescato da Michelangelo e da Leonardo da Vinci; l’attuale decorazione fu commissionata dal duca Cosimo I de’ Medici a Giorgio Vasari negli anni ’60 del Cinquecento, quando fu eretto anche il soffitto della sala. In risposta all’incertezza dei tempi furono nominati nuovi accoppiatori, e il numero dei Gonfalonieri di Compagnia fu triplicato nelle elezioni del dicembre del 1494. La predicazione carismatica di fra’ Girolamo Savonarola, un frate domenicano di Ferrara diventato Priore del Convento di S. Marco nel 1490, influenzò ulteriormente la situazione politica. Egli fu infine arrestato, scomunicato, torturato, impiccato e bruciato sul rogo in Piazza della Signoria il 23 maggio 1498. Il quadro politico di Firenze venne inoltre complicato (fino agli anni Trenta del Cinquecento) dall’intervento della Francia e della Spagna nelle guerre d’Italia. Da questo periodo turbolento scaturì l’intensa discussione politica riflessa nelle opere di Niccolò di Bernardo Machiavelli (che mai fu tratto ai Tre Maggiori) e di Francesco di Piero Guicciardini (che servì una sola volta come priore). . Il Consiglio Maggiore sospese la selezione degli incarichi d’ufficio attraverso le Tratte e vi sostituì un sistema selettivo all’interno del Consiglio mediante Elettori (che erano ineleggibili agli uffici). Tale selezione cominciò nel maggio del 1495. Con la sospensione delle Tratte, anche i relativi Giornali cessarono presto di esistere; per cui abbiamo dovuto prelevare i nomi degli incaricati da altre fonti. Soltanto i nomi degli uomini “seduti” in ufficio sono reperibili fra il 1497 (quando i Giornali terminarono) e la restaurazione dei Medici nel settembre 1512, e per molti di essi. alcuni dettagli sono indisponibili . 1502 – Piero Soderini “gonfaloniere a vita”. Nel tentativo di stabilizzare le politiche del Consiglio Maggiore, Piero di Tommaso Soderini fu eletto “Gonfaloniere di Giustizia a vita” nel settembre del 1502. Perciò, a partire dalla sua elezione, non vi furono più nomi di Gonfalonieri di Giustizia fino alle elezioni dell’ottobre 1512, dopo la restaurazione dei Medici. . . 1512 – La restaurazione dei Medici. Con l’esercito spagnolo accampato a Prato, Piero Soderini fuggì in esilio alla fine d’agosto del 1512. I membri restanti della Signoria lo sconfessarono. Un nuovo Parlamento (limitato ai sostenitori dei Medici) e una Balia restaurarono i Medici nella persona effettiva del cardinale Giovanni de’ Medici (secondo figlio di Lorenzo il Magnifico) che fu poi capo-famiglia. Egli era stato fatto cardinale nel 1489 e fu eletto papa con il nome di Leone X nel marzo del 1513. Morì nel 1521. Il partito mediceo tentò di ripristinare il sistema politico così come era stato sotto Lorenzo, con il Gonfaloniere di Giustizia, i Priori e i due Collegi, scelti ancora con il metodo delle Tratte, anche se le elezioni venivano ora controllate dal partito mediceo. Le prime elezioni mediante le Tratte furono quelle dell’ottobre del 1512. Il Consiglio Maggiore fu rimpiazzato dal Senato dei 70 e dal Consiglio dei 100. (Una succinta e dettagliata relazione dell’ultimo periodo della repubblica è in J. N. Stephens, The Fall of Florentine Repubblic, 1512-1530. [Oxford: Clarendon Press, 1983].) . . 1527-1530 – L’”ultima repubblica”. Dopo il sacco di Roma ad opera delle truppe mercenarie dell’imperatore Carlo V nel maggio 1527, e la fuga ad Orvieto di papa Clemente VII (Giulio de’ Medici), il gruppo anti-mediceo a Firenze prese il potere. Giulio de’ Medici era un figlio di Giuliano, il fratello assassinato di Lorenzo, e da cardinale aveva guidato il regime in Firenze; egli era stato eletto papa nel 1523. In Firenze, una nuova Balia si preparò a restaurare il Consiglio Maggiore del 1494. Incaricati sostitutivi per la Signoria e i Collegi furono scelti il 31 maggio, e i nomi di quelli eletti dal Consiglio Maggiore furono registrati nei Giornali delle Tratte. I Gonfalonieri di Giustizia eletti ebbero ancora un periodo di carica piuttosto lungo: Niccolò di Piero Capponi (maggio 1527), Francesco di Niccolò Carducci (aprile 1529), Raffaello di Francesco Girolami (gennaio 1530). . . In conseguenza della riconciliazione fra papa Clemente VII e l’imperatore Carlo V, Firenze fu assediata dalle truppe imperiali capeggiate dal principe di Orange dall’autunno del 1529 fino alla resa della città, il 12 agosto del 1530, dopo la battaglia finale di Gavinana. . 1530-32 – Il Ducato. I Medici furono reintegrati nell’aprile del 1531 da Carlo V nella persona di Alessandro de’ Medici, che fu fatto signore di Firenze. Alessandro era un figlio illegittimo di Lorenzo de’ Medici, il duca di Urbino, e perciò un nipote di Piero e un pronipote di Lorenzo il Magnifico. Un anno dopo, nell’aprile del 1532, dodici Riformatori della fazione medicea dell’elite fiorentina cambiarono la costituzione. La riforma del 1532 riconobbe Alessandro de’ Medici come duca, abolì la Signoria e i Collegi, e stabilì un nuovo Magistrato Supremo saldamente controllato dal Duca, che sovrastava un Senato dei 48 e un Consiglio dei 200. Gli ultimi Gonfalonieri di Compagnia furono selezionati nell’aprile 1531, gli ultimi Gonfaloniere di Giustizia, Notaio e Priori nel febbraio 1532, e gli ultimi Buonuomini in marzo. . . Quando Alessandro de’ Medici venne assassinato nel gennaio 1537 (dal suo parente Lorenzino de’ Medici – chiamato “Lorenzaccio”) l’elite fiorentina riconobbe come duca Cosimo de’ Medici. Cosimo era il figlio di Giovanni dalle Bande Nere, un lontano cugino di Cosimo Pater Patrie, vissuto nel secolo precedente. Sotto il Duca Cosimo I (che fu fatto Granduca nel 1570) si svilupparono le più caratteristiche istituzioni burocratiche del Granducato mediceo. . . Elezioni delle Arti . (Serie 06). Si è spesso detto che la repubblica fiorentina scaturisse inizialmente dalle Arti, dal momento che l’appartenenza ad esse era un requisito basilare dell’elezione agli uffici.. Il numero delle Arti riconosciute venne fissato in 21 nei primi anni del Priorato: sette “Arti Maggiori” e quattordici “Arti Minori”. . Le sette “Arti Maggiori” erano l’Arte dei Giudici e Notai; Calimala [o dei Mercatanti]; l’Arte del Cambio; l’Arte della Lana; l’Arte della Seta [o Por S. Maria]; l’Arte dei Medici e Speziali; e l’Arte dei Vaiai e Pellicciai. . Le quattordici “Arti Minori” erano l’Arte dei Beccai; l’Arte dei Calzolai; l’Arte dei Fabbri; l’Arte dei Linaiuoli e Rigattieri; l’Arte dei Maestri di Pietra e di Legname; l’Arte dei Vinattieri; l’Arte degli Albergatori; l’Arte degli Oliandoli e dei Pizzicagnoli; l’Arte dei Cuoiai e dei Galigai; l’Arte dei Corazzai e degli Spadai; l’Arte dei Coreggiai; l’Arte dei Chiavaioli; l’Arte dei Legnaiuoli; e l’Arte dei Fornai. Nonostante che le Arti esistessero anche in precedenza (Giovanni Villani riporta le sette Arti Maggiori al 1266), gli ultimi statuti che le riguardano sono compresi generalmente fra i decenni 1290 e1320. . Il comune di Firenze, dove soltanto un limitato gruppo di arti “ufficiali” veniva configurato nella costituzione, differiva decisamente dagli altri comuni italiani, che organizzavano invece in via formale un più vasto arco di attività. La pratica fiorentina era quella di associare i vari lavori all’interno delle Arti già esistenti (perciò Giudici e Notai, Medici e Speziali, Vaiai e Pellicciai, Linaioli e Rigattieri, Oliandoli e Pizzicagnoli, Cuoiai e Galigai, Corazzai e Spadai – tutte attività associate raggruppate insieme). Per esempio, i Tintori lottarono per ottenere un’organizzazione indipendente nel quattordicesimo secolo, ma la conseguirono soltanto provvisoriamente, negli anni 1378-82, al tempo del tumulto dei Ciompi. I pochi individui identificati con l’occupazione di “Tintori” nelle elezioni delle Arti del quindicesimo secolo erano membri dell’Arte della Lana o dell’Arte dei Linaiuoli e Rigattieri. Ulteriori sotto-gruppi si notano nel quindicesimo secolo: gli Orafi erano associati per lo più all’Arte della Seta; gli Aromatari e i Barbieri con i Medici e Speziali; i Pesciaiuoli con i Beccai; i Coltellinai con i Fabbri; i Sarti con i Linaiuoli e i Rigattieri; gli Scultori (per esempio la famiglia dei Della Robbia) con i Maestri di Pietra e di Legname; i Biadaiuoli con gli Oliandoli e i Pizzicagnoli; i Cassettai con i Legnaiuoli. Venivano fatte anche distinzioni di lavoro nella composizione delle differenti Borse dalle quali erano tratti i Consoli delle Arti. I Consoli dell’Arte della Lana erano estratti dalle quattro borse rappresentanti le diverse circoscrizioni della città (chiamate “conventi”): S. Pancrazio (la parte occidentale della città), Oltrarno (la parte meridionale), S. Martino (la parte settentrionale), e S. Piero Scheraggio (la parte orientale). I Consoli dell’Arte della Seta erano tratti da tre Borse: Setaiuoli, Ritagliatori e Fondacai (proprietari dei magazzini -- comprendenti gli orafi). I Consoli dell’Arte dei Linaiuoli e Rigattieri venivano estratti da due Borse: Linaiuoli e Rigattieri. Le arti imposero certe modalità prescritte di produzione, matricolazione, scrutinamento e risoluzione delle dispute interne. Ciascuna era governata da un magistrato di “Consoli”, sorteggiati fra i maestri eleggibili delle arti – i lavoratori subordinati nelle varie attività (“sottoposti”) erano esclusi da tale privilegio. I Consoli stavano in carica per un periodo di quattro mesi, ed entravano in ufficio in gennaio, maggio, settembre. . L’Arte della Lana aveva otto consoli; Seta, Medici e Speziali, Beccai, Calzolai e Fabbri ne avevano sei; Calimala (Mercatanti), Cambio, Vaiai e Pellicciai, Linaiuoli e Rigattieri, Maestri di Pietra e di Legname, Oliandoli e Pizzicagnoli, Coreggiai, Chiavaioli, Legnaioli e Fornai ne avevano quattro; Vinattieri, Albergatori, Cuoiai e Galigai, Corazzai e Spadai ne avevano tre. Gli scrutini degli eleggibili venivano organizzati all’interno di ciascuna arte. Il sorteggio e i divieti all’insediamento finale operavano in maniera simile a quella valida per i Tre Maggiori. Nella passata generazione ci sono stati pochi studi sulle arti fiorentine. Si può supporre che una famiglia particolare si iscrivesse soprattutto ad un’arte (come avvenne qualche volta), comunque ci fu chiaramente una certa flessibilità nell’appartenenza alle arti. Alcune famiglie (per esempio i Medici) trovarono economicamente e politicamente vantaggioso associarsi a molte arti. I cognomi, di certo, non sono prove sicure di coesione familiare, e si vede come molti di essi (celando in realtà branche di famiglie) fossero largamente distribuiti fra diverse arti, sia maggiori che minori. . La Mercanzia . La Mercanzia (dal 1308 -- la Universitas mercatorum, o, nel quindicesimo secolo, i Sei di mercanzia) costituiva l’alta corte commerciale. Il suo magistrato (che stava in carica per un periodo di tre mesi nel primo Quattrocento) si componeva inizialmente di un membro per ciascuna delle cinque arti di maggior prestigio mercantile: Mercatanti, Cambio, Lana, Seta e Medici e Speziali. Un sesto membro della corte venne aggiunto estraendolo dalle arti minori nel 1372 (e al tempo dei Ciompi c’erano cinque membri dalle arti minori, che ritornarono ad essere uno nel 1387). I membri delle Arti Maggiori erano estratti dalle Borse composte da ciascuna delle cinque arti rappresentate; il sesto membro della corte era tratto da una Borsa combinata, composta da rappresentanti dell’Arte dei Vaiai e Pellicciai e delle quattordici Arti Minori. La corte impiegava anche un giurista straniero (il cui nome non appare nell’archivio-dati). . . La Mercanzia rappresentava una magistratura piuttosto importante nel tardo Trecento e nel primo Quattrocento. I suoi membri sedevano ex-officio nel Consiglio del Popolo, e partecipavano anche alle estrazioni per i Tre Maggiori. La corte si occupava di materie importanti come fallimenti, bancarotta e frode, e di trattati commerciali con gli stati stranieri. Progressivamente, nel quattordicesimo secolo, essa si assunse il compito di eseguire le sentenze pronunciate dai consoli delle arti. Gradualmente (e particolarmente nel periodo dopo la rivolta dei Ciompi) i Tre Maggiori ed altre alte magistrature usurparono i poteri delle arti, subordinando queste ultime allo stato, ed anche la Mercanzia ebbe un ruolo in questo processo. Nel 1393 essa si arrogò la funzione di supervisore nelle elezioni dei consoli delle arti, dando perciò avvio ad una serie di registri archivistici (“Tratte di tutti i consolati delle arti”), che registravano le estrazioni anche per l’ufficio della Mercanzia, e per venti delle ventuno arti (l’arte dei Giudici e Notai era esclusa). La Mercanzia diminuì un po’ d’importanza nel tardo Quattrocento per una serie di misure introdotte sotto Lorenzo de’ Medici negli anni ’70 (e nel 1477 i periodi annuali di rotazione delle cariche dei magistrati della Mercanzia furono ridotti da quattro a tre). . Elezioni delle Arti . A partire dal dicembre del 1393, la Mercanzia registrava i risultati delle elezioni dei magistrati della stessa Mercanzia e dei consoli di 20 delle 21 arti (le elezioni dell’Arte dei Giudici e Notai non erano controllate dalla Mercanzia e, ad eccezione di un’elezione nel 1393, esse sono del tutto mancanti dall’archivio-dati). I registri dell’Archivio della Mercanzia (“Tratte dei consolati delle arti”) non sono sopravvissuti integralmente. Dei circa diciannove volumi di elezioni fra il 1393 e il 1538, che dovevano essere originariamente presenti, cinque non sono sopravvissuti. Ci sono di conseguenza delle lacune nei dati. I risultati delle elezioni sono completi dal dicembre 1393 all’agosto 1421, dall’agosto 1429 al dicembre 1443, dall’agosto 1465 all’aprile 1474, e dall’aprile 1480 al dicembre 1497. Non abbiamo codificato materiale dopo questa data, anche se siamo riusciti invece a colmare la lacuna degli anni 1433-34, mancanti dal registro 83 della Mercanzia, grazie al registro 109 (“Bastardello di Tratte”). I registri della Mercanzia continuano, dopo un’altra lacuna fra gli anni 1498 e 1507, fino alla fine delle Repubblica. Per gli anni mancanti del quindicesimo secolo, forse si potrebbero, con alcune ricerche, trovare fonti per individuare i “seduti” del magistrato della Mercanzia, ma è dubitabile che si possa reperire un ampio spettro di nomi per le altre arti. . I registri della Mercanzia per le elezioni delle arti sono molto simili ai Giornali delle Tratte relativi alle estrazioni dei Tre Maggiori, e sono la fonte dei nomi per la serie 06 dell’archivio-dati. I registri contengono i nomi e le date di estrazione per tutti i “veduti” e i “seduti”, indicando per ciascuno il risultato dell’estrazione, l’ufficio e la data della borsa. Sfortunatamente, non tutti di questi registri sono sopravvissuti. Vi sono nomi in serie continue dall’elezione del dicembre del 1393 all’agosto del 1421, dall’agosto del 1429 al dicembre del 1443, dall’agosto del 1465 all’aprile del 1474, e dall’aprile del 1480 al dicembre del 1497. David Herlihy ha codificato i registri fino al 1497.In realtà i volumi continuano fino agli anni ‘30 del Cinquecento, dopo un’altra lacuna fra il 1498 e il 1507. Non abbiamo potuto completare la serie dopo il 1497, anche se abbiamo colmato il vuoto degli anni 1433-34, che mancavano dal registro 83 della Mercanzia. Sarebbe senz’altro possibile trovare ulteriori nomi di individui estratti in ufficio negli anni mancanti (specialmente per la stessa Mercanzia), ma è comunque dubbio che l’intero spettro delle elezioni delle arti potrebbe essere in questo modo ricostruito. Nondimeno, i registri sopravvissuti forniscono una buona base per valutare, per la maggior parte del quindicesimo secolo, la partecipazione di individui e di famiglie in arti differenti.
Un’importante rinuncia : bisogna d’acchito riconoscere che questa non è un’edizione integrale dei Giornali delle Tratte, dei prioristi e degli altri registri archivistici sui quali i dati sono basati. I nomi nei registri appaiono in forma latina, mentre Herlihy, seguendo la lunga tradizione di tradurre in italiano i nomi in forma latina del Rinascimento fiorentino, ha così operato, e noi ne abbiamo seguito l’esempio. Nello stesso modo si è comportato con le occupazioni e i luoghi di origine (nonostante che noi abbiamo riportato molti titoli di occupazioni nella loro forma originale). Si può vedere nel talloncino visibile sulla prima pagina del sito Web il nome “Zanobius Benedicti Carocci de Strozzis”, che invece appare nell’archivio-dati come “Zanobi [di] Benedetto [di] Caroccio Strozzi”. La differente ortografia italiana dei nomi e dei cognomi usati da differenti codificatori è stata standardizzata. Dopo aver usato gli archivi informatici, si deve ammettere che una tale analisi (in pratica il vantaggio tratto da un simile archivio) sarebbe stata impossibile senza qualche giudiziosa standardizzazione dei nomi. Ci sono comunque ulteriori informazioni sul trattamento dei nomi nell’apposita Nota dei nomi.
Altre informazioni nell’archivio si presentano in forma di codici numerici, il cui significato è stato anch’esso puntualmente controllato. Seguendo la pratica di Herlihy, le date sono state adattate all’uso moderno di fare cominciare l’anno il primo gennaio. Le date di entrata in ufficio tratte dai prioristi dopo il 1343 sono state adattate in modo da corrispondere con quelle dell’elezione riportate dai Giornali delle Tratte, effettuate negli ultimi giorni del mese precedente quello dell’entrata in carica, e non con l’inizio della carica stessa. La designazione delle borse (arti maggiori, borsellino, arti minori) sono state edite con una certa ampiezza quando c’erano lacune nei Giornali o nei registri della Mercanzia, sempre che la borsa da cui veniva estratto l’incaricato rientrasse nel sistema consuetudinario della distribuzione degli uffici. Abbiamo controllato i dati attentamente, valutando la coerenza interna. Qualche errore di codificazione, controllo e pubblicazione ovviamente rimane, ma le discordanze a questo punto non possono che riflettere le ambiguità espresse dai registri originali.
David Herlihy codificò i nomi in modo selettivo sia dai Giornali delle Tratte che dai registri della Mercanzia, tanto da escludere un’intera categoria di uomini “veduti” ma non “seduti” in ufficio. Un largo numero di nomi veniva respinto dall’accesso all’incarico dietro il motivo di un “Divieto generico” (RDRAW codice ‘02’), cioè per una ragione non specificata nei registri dei Giornali. In genere poteva significare che l’individuo in questione era rigettato perché: 1) egli era già seduto in un altro ufficio, 2) egli aveva avuto un ufficio troppo recentemente, o 3) un membro della sua più stretta famiglia era contemporaneamente in carica. David Herlihy incluse sistematicamente uomini con tale particolare Divieto per il registro 595 delle Tratte (1376-1381), ma in seguito se ne interessò soltanto occasionalmente. Ciò è avvenuto probabilmente perché queste estrazioni, anche se numerose, non aggiungevano un significato particolare all’archivio-dati (gli individui in questione non erano né minori, né fiscalmente insolventi, né assenti, o morti, ecc.) La gestione delle borse da parte degli accoppiatori avveniva prima delle estrazioni registrate nei Giornali, così non si ricavavano da esse neppure particolari considerazioni politiche. Stimiamo che nel 1430, per i Tre Maggiori, qualcosa come 300 di tali estrazioni (forse 30.000 per l’intero archivio-dati) possano essere state omesse dal file, incremetando quindi il numero delle registrazioni complessive per quell’anno dalle presenti 887 alle circa 1200 reali. Nonostante che inizialmente sperassimo di aggiungere questi casi mancanti, abbiamo infine concluso che David Herlihy abbia agito bene nel tralasciarli. In ogni caso, non abbiamo rimosso dal file quei casi con il RDRAW codificato come 02 che già vi fossero stati immessi; così 836 casi restano nei Tre Maggiori e 391 nelle elezioni delle Arti, che potranno servire da campioni per un ulteriore analisi di questa situazione.
ESTRAZIONI FLORENTINE RENAISSANCE RESOURCES:Online Tratte of Office Holders 1282-1532
Edited by David Herlihy, R. Burr Litchfield, Anthony Molho and Roberto Barducci ( Copyright R. Burr Litchfield and Anthony Molho, 2000. All rights reserved.) ESTRAZIONI FLORENTINE RENAISSANCE RESOURCES:Online Tratte of Office Holders 1282-1532 l'edizione elettronica della Brown University di cui sopra ( Online Tratte of Office Holders 1282-1532 ) e' di altissimo profilo coprendo l'intero periodo repubblicano e permettendo di utilizzare i dati per fare statistiche le piu' diverse e anche di ricavare delle rudimentali genealogie
Studio importantissimo e molto affidabile e' quello del professor Sergio Raveggi , pubblicato (sul Portale della Storia di Firenze ) la serie della Signoria dal 1282 al 1343, con l'aggiunta di Gonfalonieri di compagnia e di Buonuomini basato principalmente sulPriorista di palazzo https://www.storiadifirenze.org/wp-content/uploads/2013/07/14-priori.pdfCOMPOSIZIONE DELLA SIGNORIA NEGLI ANNI 1282-1343 by PROF. SERGIO RAVEGGI COMPOSIZIONE DELLA SIGNORIA NEGLI ANNI 1282-1343 by PROF. SERGIO RAVEGGI una ricerca imperdibile , una visione d'insieme per gli anni 1282--1343 corredata da interessanti appendici e note Inoltre vengono identificate le famiglie
STUDI CARTACEI EDITI
Il Priorista fiorentino istorico di Domenico Rastrelli volume 1 anno 1783volume 2 anno 1783 volume 3 anno 1783 volume 4 anno 1785
Purtroppo lo studio comprende solo il periodo
Barbadoro Bernardino Consigli della Repubblica fiorentina (1301-1315) In appendice : Priori e Gonfalonieri dal 15 febbraio 1301 al 15 febbraio 13
Cronaca fiorentina di Marchionne di Coppo Stefani a cura di Niccolo' Rodolico : A questa cronaca e' acclusa una lista completa di Ufficiali ( di autore non chiarito ) che va dal 1282 fino alla Signoria entrata in carica il primo maggio 1385 fino a quella che copre tutto aprile 1386 L'opera e' presente nei volumi delle Delizie degli eruditi toscani di padre Ildefonso Nel 2008 la "Firenze Libri" ne ha pubblicato una riedizione nella collana diretta da Giovanni Cherubini , Giuliano Pinto , Andrea Zorzi comprende solo Priori e Gonfalonieri dalle origini all’aprile 1386
Un diario molto interessante la cui pubblicazione e' stata curata da Anthony Molho e da Franek Sznura Leo Olschki editore Alle bocche della piazza : diario di un anonimo fiorentino (1382--1401 ) ci permette di coprire un periodo molto complicato il periodo che va dal 1382 fino al 1401
Un priorista di Pagolo di Matteo Petriboni e di Matteo di Borgo Rinaldi edito da Istituto Nazionale di studi sul Rinascimento e la cui trascrizione e' stata curata da Gabriella Battista e da Jacqueline A. Gutwirth Questo Priorista ci permette di coprire il periodo ( 1407-1459 )
Occorre anche ricordare un opera molto importante quella di Nicolai Rubinstein Il governo di Firenze sotto i Medici ( 1434--1494 ) ........................................
Ovviamente poi occorre far riferimento al Priorista a famiglie piu' famoso quello del Mariani pubblicato on line dall'archivio di Stato di Firenze . .
Partecipazioni alla signoria dei Carnesecchi fiorentini nel periodo della Repubblica di Firenze
Ruolo politico dei Carnesecchi di Firenze : uffici INTRINSECI
Gonfalonieri di Giustizia e Priori delle Arti nel periodo 1282 1532 ……: Elenchi dei Gonfalonieri di Giustizia e dei Priori delle Arti Gonfalonieri di Compagnia e Buonuomini ………………………………….: Elenchi dei Gonfalonieri di compagnia e dei Buonuomini Senatori del Ducato e del Granducato di Toscana ………………………. : Elenchi dei Senatori del Ducato poi Granducato di Toscana
Consoli delle Arti nel periodo 1282 1532………………………………….Elenchi dei Carnesecchi Consoli delle Arti Otto di Guardia e di Balia ……………………………………………: Otto di Guardia e di Balia tra i Carnesecchi ( contributo dr Paolo Piccardi ) Buonuomini delle Stinche ……………………………Carnesecchi che hanno svolto la carica di "Buonuomini delle Stinche" ( contributo dr Paolo Piccardi )
Un priorista cinquecentesco pubblicato dalla Orsini De Marzo ……………………………I Carnesecchi in un priorista a famiglie cinquecentesco
|
|
storiaaristocraziafiorentina
Ricevo dalla gentilezza del dr Guido Fineschi Sergardi questa importante ed interessante estratto :
MANOSCRITTI ..................................IN PARTICOLARI ....ESTRATTI FATTI DA TOMMASO FORTI
Ruolo politico dei Carnesecchi di Firenze : uffici estrinseci
COSTANTINOPOLI
Antonio Carnesecchi anno 1500 Emino della Nazione fiorentina a Costantinopoli ( di questa notizia data dal Mariani non ho trovato conferma altrove ) Andrea di Paolo di Simone 1501-1504 Emino della Nazione fiorentina a Costantinopoli
A questa informazione su Antonio emino nel 1500 non ho trovato conferma altrove
" Dominio e patronato: Lorenzo dei Medici e la Toscana nel Quattrocento" di PATRIZIA SALVADORI
La giustizia, era una figura consueta nella vita politica delle citta’ e dei centri maggiori della Toscana , anche prima della dominazione fiorentina . Ma mentre nel periodo precedente il Podesta’ veniva scelto direttamente dalle Magistrature locali , che attingevano a un nucleo di professionisti itineranti , provenienti anche da altri Stati italiani, con la dominazione di Firenze questi ufficiali vennero definitivamente sostituiti da cittadini fiorentini , sprovvisti per lo piu’ di un adeguata preparazione giuridica e appartenenti in buona misura al ristretto nucleo di famiglie che componevano il ceto dirigente urbano (6) La figura del Rettore si trovava pertanto a operare in quel dualismo di poteri che caratterizzava le formazioni territoriali del Quattrocento, poiche’ l’ufficiale estrinseco doveva da un lato rappresentare il potere centrale nelle zone del dominio , e dall’altro tutelare , secondo l’antica tradizione comunale, gli interessi delle citta’ e dei paesi nei quali ricopriva l’incarico per un breve lasso di tempo.(7)
(4) I Salari potevano variare da una somma di 4000 lire al semestre per le cariche di Capitano e Podesta di Pisa ( che avevano al seguito una quarantina di persone ) fino alla somma di 250 lire per le podesterie piu’ piccole; l’importo del salario era stabilito dalla Dominante. ANDREA ZORZI Giusdicenti e operatori pg 520 (6) Sebbene a cavallo tra il XIV e il XV secolo si assista ad un ampliamento del numero complessivo delle famiglie ammesse a tali uffici , di fatto queste cariche soprattutto quelle piu’ importanti , erano concentrate in un ristretto numero di casati . Circa venti famiglie ricoprirono in modo stabile un nutrito numero di incarichi e solo quattro di esse (Rucellai , Carnesecchi , Corsini , Corbinelli ) fecero parte in modo continuativo del vertice. ANDREA ZORZI Giusdicenti e operatori pg 531
"La trasformazione di un quadro politico. Ricerca su politica e giustizia…." di ANDREA ZORZI Ne’ contribuirono a migliorare il livello medio di qualita’ dell’esercizio delle giurisdicenze la marginalizzazione delle quote di uffici spettanti agli artigiani e ai membri delle corporazioni minori che nel giro di pochi decenni tra XIV e XV secolo furono ridotte da 1/3 del totale degli uffici estrinseci a ¼ delle sole podesterie minori , in conseguenza della concentrazione del potere , nella seconda meta’ del quattrocento , per esempio su circa 250 gruppi familiari ammessi agli uffici ,il 20% occupo’ mediamente il 46% del totale degli incarichi, con un vertice del 5% di famiglie ( tra le quali sempre presenti Rucellai , Carnesecchi , Corsini , Corbinelli ) che da solo ne copri in media il 18%………………
Vicari e Podesta' : Vicari e Podesta' Vicari e Podesta' : Vicari e podesta' Vicari e Podesta : Vicari e Podesta' Capitani di Giustizia di Castrocaro Capitani di Giustizia di Castrocaro : elenco dal 1403 al 1500 : Contributo del dr Cristiano Verna Podesta di Fiesole Carnesecchi Podesta' a Fiesole ..……………….Contributo di Roberto Segnini Vicari e Podesta' Podesta' e Vicari Vicari e Podesta' I Vicari/Podesta di Lari : Elenchi Vicari e Podesta' I Vicari/Podesta di San Miniato al Tedesco : Elenchi Vicari e Podesta' I Vicari/Podesta di San Miniato al Tedesco : Elenchi a pg 219-220 Vicari e Podesta' I Vicari/Podesta di Poppi : Elenchi Vicari e Podesta' LAVORO DI TRASCRIZIONE DELLE SCHEDE CARTACEE DELL’ARCHIVIO DEL VICARIATO DI POPPI Vicari e Podesta' I Vicari/Podesta di Pescia : Elenchi Governatori e Capitani Livorno : Elenchi ………………………….per la cortesia della dottoressa Serafina Bueti e del personale ASLi Vicari e Podesta' I Vicari del Valdarno superiore : Elenchi ………………………………..contributo del conte Massimo Cavalloni Vicari e Podesta' Carnesecchi Vicari del Valdarno superiore : Elenchi…………………..contributo del conte Massimo Cavalloni
Vicari e Podesta' Carnesecchi ufficiali nella Valdichiana: …………………..contributo del dr Angelo Gravano - Bardelli
missive degli Otto di Pratica ...............Carnesecchi nominati nelle missive degli Otto di Pratica un affresco nel palazzo dei Vicari di Scarperia ...............tratto dal sito www.piccoligrandimusei.it/VicariOpere.phtml Vicari di Vicopisano ...............Carnesecchi vicari a Vicopisano Vicari e Podesta' : Carmignano Vicari e Podesta' : Barga Vicari e Podesta' : Barga
Podesta' di Fiesole : Podesta' di Fiesole Vicari e Podesta' : Scarperia ecc...........
Annali e Memorie dell' Antica, e Nobile Città di S. Sepolcro Intorno alla ... Di Pietro Farulli http://books.google.it/books?id=dAZAAAAAcAAJ&pg=PT2&dq=carnefecchi+sepolcro&hl=it&ei=V37BTurQDcP2sgaS4di-Aw&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=4&sqi=2&ved=0CEIQ6AEwAw#v=onepage&q&f=false
Le vite d'uomini illustri fiorentini Di Filippo Villani,Giammaria Mazzuchelli (conte),Alessandro Goracci http://books.google.it/books?id=t9TQAAAAMAAJ&pg=PA260&dq=carnesecchi+gasparo&hl=it&ei=JX_BTpmDDo6xhAeG28SeBA&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=1&sqi=2&ved=0CDAQ6AEwAA#v=onepage&q=carnesecchi%20gasparo&f=false
Gonfalonieri di San Sepolcro …………………………………………………… … Gonfalonieri di San Sepolcro ( Arezzo ) Carnesecchi Gonfalonieri a San sepolcro …………Francesco di Gasparo Carnesecchi Gonfaloniere di San Sepolcro (probabilmente Caneschi)
Podesta e Capitani a Pistoia …………....documento d'archivio sugli uffici di Pistoia by dr Guido Fineschi Sergardi
MONTEPULCIANO …………....documento d'archivio sugli uffici di Montepulciano by dr Guido Fineschi Sergardi
Vicari e Podesta' Vicari/Podesta/Capitani in varie zone xxxx
Castello di Poppi
particolare Castello di Poppi : Giovanni di Luca Carnesecchi
Stemma a Cutigliano (Pistoia) Secondo Farinati Uberti e' lo stemma di Antonio di Andrea di Paolo di Simone Carnesecchi Capitano a Cutigliano nel 1503
Da Wikipedia per Francesco Bini : stemma dei Carnesecchi sul palazzo del Podesta' a Galluzzo (Opera del Della Robbia)
Ostina --antica fattoria di Ostina
Stemma a Colle val d'Elsa di Paolo di Berto di Zanobi ( attenzione non Paolo di Berto di Grazino )
particolare _ dalla foto di Francesco Bini.
wikipedia: palazzo del vicario a Pescia : stemma all'esterno-----by Francesco Bini
per la foggia antica pare essere lo stemma di Zanobi di Berto di Grazino Carnesecchi
infatti a Pescia : anno 1384 Podesta' Zanobi di Berto di Grazino Carnesecchi anno 1402 Vicario Zanobi di Berto di Grazino Carnesecchianno 1473 Vicario Piero di Simone di Paolo Carnesecchi anno 1509 Vicario Bernardo di Francesco di Berto Carnesecchi anno 1520 Vicario Simone di Piero di Simone Carnesecchi anno 1521 Vicario Bernardo di Andrea di Bernardo Carnesecchi anno 1528 Vicario Bartolomeo di Piero di Simone Carnesecchi anno 1613 Vicario annuale Pierfrancesco del sen Cristofano Carnesecchi anno 1630 Vicario annuale Giovanbattista di Zanobi del sen Bartolomeo Carnesecchi
In Toscana si trovano ancora decine di stemmi Carnesecchi , vicari ,podesta .capitani ed anche di sepolture nelle chiese o ornamento di palazzi Ne ho raccolto una buona parte in questa pagina ………………… .Targhe , lapidi , stemmi in Toscana
Targhe , lapidi , stemmi ………………… una questione interessante : stemmi matrimoniali
Da notare che lo stemma dei Carnesecchi fiorentini viene spesso dall'artista che scolpisce o dall'artista che affresca o dipinge o graficizza rappresentato come un troncato In realta' come mostra la sepoltura di Pero di Durante Ricoveri e quella successiva di Luca di ser Filippo Carnesecchi in origine era un scudo azzurro con in punta un rocco d'oro e bandato con quattro bande ( poi divenute tre ) d'oro anch'esse
Lapide di Santa Maria Novella ….La lapide di Pero di Durante di Ricovero in Santa Maria Novella : Quasi un albero genealogico
DEGNA DI NOTA E' QUESTA CONCESSIONE ARALDICA DEL COMUNE DI SAN MINIATO AL TEDESCO
Notar quindi si vuole, come il Comune di Samminiato l' anno 1491 concedè a Matteo di Manetto Carnesecchi, e suoi figliuoli, e discendenti di poter portare 1' Arme stessa della Leonessa per in riguardo dei buoni portamenti fatti da esso Matteo stato Vicario sei mesi di detta Terra e dei meriti di Zanobi Carnesecchi stato Vicario ivi 1' anno 1410. e di quelli ancora di Manetto padre di esso Matteo statone Vicario 1' anno 1440.
by Domenico Maria Manni Matteo , Manetto suo padre, Zanobi di Berto di Grazino suo nonno
Albero genealogico ………Discendenza di Manetto di Zanobi di Berto Grazini
http://books.google.it/books?id=QI5YAAAAMAAJ&pg=RA1-PA103&dq=matteo+manetto+carnesecchi&hl=it&sa=X&ei=mQIHVI7MI87b7Aa1t4HADA&ved=0CCQQ6AEwAA#v=onepage&q=matteo%20manetto%20carnesecchi&f=false
Domenico Maria Manni, Osservazioni Istoriche sopra i sigilli antichi de' secoli bassi, Vol. XIV, Firenze, 1743, Sigillo n. IX, pp. 95-103.
Il Sigillo dei Signori Dodici del Comune di San Miniato
OSSERVAZIONI ISTORICHE SOPRA IL SIGILLO IX. "Dal Sig. Abate Gio. Paolo Ombrosi, giovane di ottima aspettazione, sono stato favorito d'alcune reflessioni d'Amico suo sopra il Sigillo de' Dodici del Popolo della nobile Terra, ed ora Città, di S. Miniato, alle quali alcun'altra cosa di mio mi è paruto di dovere aggiungnere, come in appresso; il tutto per dar luce, e chiarezza al Sigillo stesso. L'antica Repubblica di Samminiato faceva per Arme come fa anco di presente una Leonessa con stocco (un tipo di spada a lama lunga e sottile, adatta ai colpi di punta, n.d.r.), come si vede appunto nell'impresso sigillo. In un altro Sigillo posseduto dal Sig. Canonico Innocenzio Buonamici di Prato la Leonessa sembra essere senza lo stocco, bensì coronata, avente attorno le parole SIGILLUM · IMPERIALIS · CASTRI SANCTI · MINIATIS. Ciò premesso, chiaramente si vede, ch'esso non era Sigillo particolare d'alcun Magistrato, ma proprio del Comune, il qual era governato a vicenda, e secondo l'estrazioni, da dodici Persone, chiamati i dodici Difensori del Popolo, e dipoi vi aggiunsero CAPITAN PARTIS GUELFE. Il governo di quella allora Repubblica fu or di Parte Guelfa, ed or di Ghibellina, secondo che l'una prevaleva all'altra, o che cos' richiedevano i reflessi politici: Comecchè Samminiato era residenza de' Vicari Imperiali, che vi aprirono il lor Tribunale fino al tempo d'Ottone I, come attestano i Bonincontri, Malespini, Boninsegni, Villani, Ammirati ec. E de fatto per esser così benemerito dell'Imperio, a principio inclinò il governo a Parte Ghibellina. Del 1202. lo dice chiaramento il Bonincontri nel Lib. 4 de' suoi Annali. Del 1240. attesta Giovanni Villani, che Federigo II. molti prigioni Guelfi mandò a Samminiato. Cosa simile riferisce nel suo Viaggio il chiarissimo Sig. Giovanni Lami sotto l'anno 1249 di alcuni Fiorentini Guelfi da Federigo messi in progione in S. Miniato, ove i più morirono di miseria; e ciò coll'autorità degli Annali del Bonincontri. E nel 1281 il medesimo Villani, poiché riceverono il Vicario Imperiale, che venne in Toscana in favore de' Ghibellini. Nel 1320 i Samminiatesi erano uniti con Castruccio contro i Fiorentini; eccoli Ghibellini. Nel 1324 in lega co' Fiorentini contro Castruccio; ed eccoli Guelfi. Contro la volontà dei Fiorentini si dettero all'Imperator Carlo IV da cui riceverono cortesie straordinarie, come racconta Matteo Villani nel Libro 4 Cap. 63 ed accettarono il Vicario Imperiale, che iusdicebat in tutta la Toscana, ed a lui, ed alla sua Curia si devolvevano le Cause d'appello anco criminali, come si riconosce dal fatto riferito dal medesimo Matteo Villani al Libro 5 Cap. 26 che quei tre Cittadini di Firenze, accusati di offesa maestà, benchè di essi noino sospetto cadesse nel petto dell'Imperatore, nondimeno convenne, che si appresentassero in giudicio a Samminiato, ove furono dichiarati non colpevoli. In altri tempi non mi pare, che il Governo di Samminiato fosse Ghibellino, con tutto che questo paese fosse per antico la Residenza degli Imperatori, e de' loro Vicari nel luogo sopraccitato: vedo bene, che in molte congiunture favorì i Guelfi, e prima. Nel 1251 i Fiorentini convennero co' Lucchesi, che si sarebbero adoprati di tirar dalla loro i Samminiatesi, così l'Ammirato il giovane: tal promessa mi fa credere, che i Samminiatesi o fussero, od inclinassero a Parte Guelfa, perché se fossero stati pretti Ghibellini, a tanto non si sarebbe avanzato il Comune di Firenze. Nel 1260 è chiaro, che di quivi li mandò le genti all'Arbia, e fu di gran giovamento ai fuggitivi. Nel 1276 nella pace conclusa alla Fossa Arnonica i Samminiatesi erano collegati co' Fiorentini, che si governavano a Parte Guelfa; così l'Ammirato il giovane. Nel 1289 i Samminiatesi spedirono soccorso contro i Ghibellini d'Arezzo, dove il franco ed esperto valore d'un Cavaliere Samminiatese fu causa della vittoria di Campaldino: così raccontano le Croniche di Dino Compagni. Nel 1297 racconta il sopraccitato Scipione, che nell'esercito spedito in favor del papa non solo vi erano le milizie di quivi, ma di più era Capitan Generale di tutto l'esercito Bertoldo Malpigli da Samminiato. Nel 1301 il medesimo Scipione afferma che si confermò la taglia de' Guelfi in Toscana, alla quale comandava come Generale Barone de' Mangiadori da Samminiato. Nel 1308 nelle Croniche del nostro Ser Giovanni di Lelmo si narra, che i Fiorentini, Sanesi, Samminiatesi, Lucchesi, ed altri Gulefi andarono coll'esercito contro gli Aretini. Nel 1313 nelle suddette Croniche si fa menzione che, perché i Pisani ruppero guerra a' Samminiatesi, furono confinat nelle loro Ville molti Samminiatesi di Parte Ghibellina. Nel 1318 nelle dette Croniche si narra che nella pace fatta in Napoli colla mediazione del Re Ruberto, i Samminiatesi come Guelfi ec. Nel 1325 dopo la rotta d'Altopascio dice il Villani Libro 9 Cap. 303 che da nullo Guelfo ebbono subito aiuto, se non da Samminiato. Nel 1343 raccontano l'Ammirato, ed il Boninsegni, che vedendosi alle strette i Fiorentini al tempo della cacciata del Duca d'Atene, chiesero aiuto ai Samminiatesi, i quali in meno di ventiquattro ore sperirono loro duemila uomini in soccorso, che molto ricreò, ed incoraggì lo sbigottito popolo di quella Città, la quale governandosi a Parte Guelfa, è credibile, che ricorresse agli amici, che se in Samminiato fosse stato governo Ghibellino, certamente non gli si sarebbe spedito così valido soccorso. Nel 1347 mi do a credere, che in questo tempo visi vivesse a Parte Guelfa, per la lega fatta tra i Fiorentini, e' Samminiatesi, nella quale fra l'altre convenzioni si legge, che i Grandi di Samminiato fossero Grandi di Firenze, ed i Grandi di Firenze fossero Grandi di Samminiato. Vi è lo strumento riferito anco dall'Ammirato, e da altri. Ed in questo anno, io poco dopo vado pensando, che fatto il Sigillo, di che si discorre, perché quei Gigli pare, che denotino la stretta unione, che si fece in quest'anno tra i due Comuni, e poteasi dare che anco in Firenze si facesse un Sigillo coll'Arme propria del Comune di Firenze, con accanto, o sopra la Leonessa di Samminiato (lo che per altro non si crede) per denotare, che si viveva fra loro in concordia, ed aleanza. Mè qui disdice l'aggiungere per maggiore schiarimento del Sigillo, come si trovano alcuni Ricordi MSS, circa gli affari di Samminiato, che nominano opportunamente i Dodici del Sigillo stesso; l'uno sotto l'anno 1309 ed è che: Piglio di Mess. Ridolfo Ciccioni feì nel viso Ser Fredi di Ser Ruggieri Bertacci della Contrada di Pancoli con un coltellaccio il dì primo di Maggio, il quale Ser Fredi usciva detto dì de0 Signori Dodici del Popolo di S. Miniato, e tutti i giurati per tal cosa con il Gonfalone incontanente consero alla Casa di detto Piglio, e quella per la parte li toccava spianarono fino a' fondamenti, essendo Capitano del Popolo Mess. Leuccio de' Guazzalotri da Prato, il quale dipoi condannò detto Piglio per detta ferita, e maleficio commesso in l. 1500 i suoi beni applicando alla Camera del Comune la metà, ed all'offeso il resto. L'altro: i Ciccioni, e Mangiadori, e gli altri Nobili di S. Miniato adì 14 agosto 1309 roppero il Popolo di detta Terra, ed arsero tutti i Libri, e Statuti del Comune, e cacciarono li Signori Dodici del Palazzo, e così il Capitano del Popolo, e questo fecero perché s'era fatto uno Statuto, che i Nobili fossero tenuti sodare dinanzi al Capitano di lire 1000 di non offendere nessuno popolare, la qual cosa i Nobuli recusando, furono forzati combattere insieme. Vincendo i Nobili, come s'è detto di sopra molte Case de' Populari abbruciarono, e guastarono, e specialmente quelle di Bindo Vannucci, di Ser Matteo di Ser Arrigo Malederrate, e di Ser Giunta da Brusciana, e molte altre messe a scacco. E dopo questo il giorno seguente ad ora di Vespro detti Ciccioni, e Mangiadori con altro Nobili fecero consiglio per riformare la Terra, e dettero autorità, e potestà, e balia a Mess. Betto Tagliameli da Lucca in quel tempo Podestà di S. Miniato; e Mess. Barone de0 Mangiadori, e Mess. Tedaldo de' Ciccioni furono eletti Capitani, e Riformatori a riformar la Terra; i quali abitavano, e facevano residenza nel Palazzo nuovo del Popolo, dove elessero li Signori Dodici; dipoi con detti Signori s'elesse il Consiglio del Popolo, e della Guardia, e così d'accordo fu riformata la Terra, ed il Podestà per vigor dell'arbitro datoli fortemente puniva con aspezza, e specialmente Cinello di Bardo Bonfigli della Contrada di Pancoli, il quale avea morto Vanni di Ser Piero il Giovedì a' 22 d'Agosto, e volendolo ricomprare gli amici suoi lir. 1500 non ottenne la grazia, ma il dì seguente gli fu mozza la testa. Molte cose di Samminiato sono riferite dal soprallodarto Sig. Dottor Giovanni Lami nel suo Viaggio. Ma per dire qualche cosa della Divisa di tal Luogo, ella, come è stato accennato di sopra, si è una Leonessa bianca in campo rosso avente uno stocco nella branca destra, sebbene poco nel Sigillo si conosce. In altro Sigillo parimente antico della Terra, oggi Città medesima, si legge attorno: SANTTUS · MINIATUS · FIGURAM · DAT · LEONINAM. Notar quindi si vuole, come il Comune di Samminiato l' anno 1491 concedè a Matteo di Manetto Carnesecchi, e suoi figliuoli, e discendenti di poter portare 1' Arme stessa della Leonessa per in riguardo dei buoni portamenti fatti da esso Matteo stato Vicario sei mesi di detta Terra e dei meriti di Zanobi Carnesecchi stato Vicario ivi 1' anno 1410. e di quelli ancora di Manetto padre di esso Matteo statone Vicario 1' anno 1440. Ciò, che in varj luoghi in altri tempi a diverse Famiglie è stato fatto, full'esempio di quel che ha praticato talvolta il Comune di Firenze verso gli Ufficiali loro forestieri, che hanno fra noi amministrato la giustizia."
E' la linea genealogica di Manetto :
Zanobi di Berto di Grazino 1410 Manetto di Zanobi di Berto 1440 Matteo di Manetto di Zanobi 1491
è una Leonessa bianca in campo rosso avente uno tocco nella branca destra , sebbene poco nel Sigillo si conosce. In altro Sigillo parimente antico della Terra, oggi Città medesima, si legge attorno: SANTTVS- MINIATVS FIGVRAM DAT LEONINAM.
San Miniato (Leonessa d'argento in campo rosso),
cortesia di Stefano Mari : San Miniato
da Wikipedia : odierno stemma del comune di San Miniato al Tedesco
LA PRIMA DIVINA COMMEDIA A STAMPA DI FOLIGNO
Il nome dei Carnesecchi e' legato indirettamente alla prima edizione mondiale a stampa della Divina Commedia di Dante Alighieri La prima volta fu infatti stampata a Foligno nel 1472 in 800 copie Di queste 800 copie oggi se ne conoscono 33 Era un edizione che doveva essere poi finita artisticamente dal miniatore Tra le 33 copie una porta un abbozzo di stemma partito La partitura alla destra araldica sembra essere l'abbozzo dello stemma Carnesecchi fiorentino con un errore INVECE CHE DI BANDE ARALDICHE SIAMO STRANAMENTE IN PRESENZA DI BARRE ARALDICHE NON SO SE ERRORE O DISTINZIONE VOLUTA PER UN MOTIVO A ME IGNOTO il Gargani ad esempio attribuisce ad Alamanno Carnesecchi ( del ramo di Bernardo di Cristofano ) un arma con le barre invece delle tradizionali bande ( ma potrebbe essersi sbagliato ) >
Alcuni ricercatori americani asseriscono la figura nella partitura alla sinistra araldica esser la bianca leonessa di San Miniato armata di stocco Il possesso dell'opera e' in effetti compatibile con gli interessi di Matteo di Manetto di Zanobi che vediamo intento alla copia di un manoscritto mentre era a Castrocaro nel 1474 Questa Divina Commedia e' stampata per la prima volta nel 1472 la concessione e' del Comune di San Miniato e' del 1491 Ove fosse vera l'ipotesi l'apposizione dello stemma ( ove si trattasse dei Carnesecchi ) deve essere posteriore di ventanni almeno alla data di edizione
Io personalmente ipotizzo invece trattarsi di uno stemma matrimoniale Un uomo Carnesecchi sposo ad una donna forse dei Bonaccorsi corazzai , vicini dei Carnesecchi nel quartiere di San Giovanni Bonaccorsi che innalzavano uno stemma con un leone d'oro armato di una mazza Non ho al momento alcuna notizia che confermi questa mia ipotesi
Castello di Poppi---Salone Cortesia generale Massimo Iacopi http://www.iacopi.it/
ANCORA DEGNA DI NOTA E' LA CONCESSIONE FATTA DA LEONE X A BERNARDO CARNESECCHI DI ANDREA DI BERNARDO DI CRISTOFANO E ALLA SUA DISCENDENZA
Titolo di conte palatino Concessione araldica del capo di Leone X sullo stemma
ASFi : Raccolta Ceramelli Papiani :stemma di Bernardo di Andrea di Bernardo Carnesecchi , sormontato dal capo di Papa Leone X
Bernardo di Andrea di Bernardo di Cristofano Carnesecchi era un acceso partigiano mediceo e sara' successivamente senatore sotto Cosimo I Priore al momento della visita di Leone X sara onorato insieme con tutti gli altri membri della signoria col titolo di Conte palatino e con la concessione di poter apporre al proprio stemma il capo di Leone X cosi come da immagine
Il Monaldi sbaglia il nome e anziche' come Bernardo lo cita come Benedetto e molti poi ne seguono l'errore Altri sbagliano vedendone il padre in Andrea di Paolo di Simone anziche' , come e' vero , in Andrea di Bernardo Quell'Andrea di Bernardo celebre anche per la partecipazione ai tornei
|
|
GENEALOGIAF09
ECCO UNA SUMMA DEI CARNESECCHI DI FIRENZE NATI TRA IL 1400 e NELLE PRIME DECADI DEL CINQUECENTO i dati sono ricavati per gli anni successivi al 1450 principalmente dai registri dei battesimi del Battistero fiorentino consultati e trascritti dal dr Angelo Gravano Bardelli Metto in evidenza come lo stock onomastico ristretto legato all'abitudine di "rifare i morti" mette sempre in difficolta' l'identificazione sicura
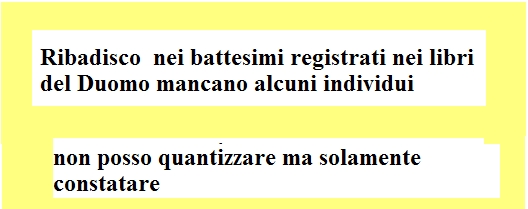
SUMMA
|
Storia dei Carnesecchi 1 .........................................un piccolo riassunto della storia ora narrata
I PIU' ANTICHI STEMMI SOPRAVVISSUTI

Vedendo le immagini di tante raffigurazioni Stemmi si puo' notare come in realta' nella rappresentazione prevalga il gusto e la sapienza dello scalpellino ,del pittore ,dell'affrescatore
In definitiva non ce ne e' uno uguale all'altro
Rimangono fissi alcuni elementi ma le proporzioni degli elementi variano continuamente
Quello che conta sono le bande , il rocco , e i colori : per il resto si varia dal capo bandato al troncato con molta liberta' per l'artigiano
E senza far troppo caso alle differenze
Infine troppi restauri sono fatti ancor oggi in barba alle conoscenze araldiche e genealogiche alterando a volte quelli che dovrebbero esser considerati dai beni culturali documenti da preservare
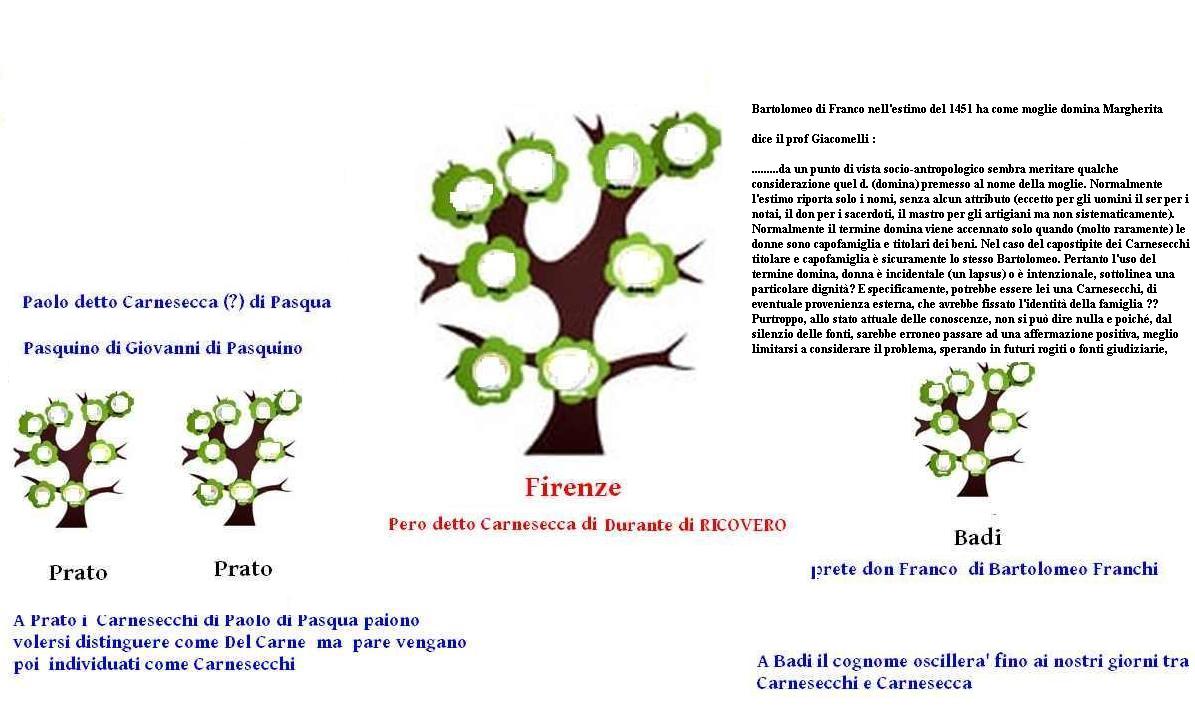
I Carnesecchi di Siena ehanno evidentemente una loro originalita' ma non e' detto che sopravvivano
I Carnesecchi di Badi sembrano avere un legame coi Carnesecchi fiorentini per via femminile
I Carnesecchi di Borgo San Sepolcro ammesso che esistano ( nel caso i documenti contengano errori ) potrebbero avere legami diretti con Firenze
I Carnesecchi di Prato e i Del Carne affondano i progenitori in un epoca in cui le genealogie dei Carnesecchi fiorentini sono oscure per cui non e' ora possibile escludere categoricamente legami anche se l'ipotesi di mancanza di legami e' la piu' probabile
|
carnesecchipratobadi
PRIMA RICORDIAMO ALCUNI CARNESECCA
storia dei Carnesecchi< …………………………………………………Ricordiamo alcuni Carnesecca trovati nei documenti
1480--1500 ORA COMPAIONO ALTRE FAMIGLIE CARNESECCHI OLTRE QUELLA FIORENTINA
I documenti per ora trovati mi hanno portato a localizzare in luoghi diversi diverse famiglie col cognome Carnesecchi ( quindi non piu' il solo soprannome Carnesecca o il cognome Carnesecca ) Luoghi evidenziati sulla mappa
|
|
carnesecchipratobadi
ESAMINIAMO LE NUOVE FAMIGLIE CARNESECCHI
FIRENZE Grazie anche agli spogli del dr Angelo Gravano Bardelli ( spogli che coprono gli anni 1450--1610 ) sulle fedi di battesimo del Battistero di Firenze mi sono fatto un'idea della situazione. A Firenze non ho trovato prove dell'esistenza di altre famiglie Carnesecchi oltre a quella storica . Solo il battesimo di Francesco di Bonaccorso di Francesco Carnesecca mi ha lasciato nel dubbio non riuscendo a collocarlo genealogicamente. Mi e' parso di notare ( COME GIA' FATTO NOTARE) che tra le fedi messe in rete sul sito dei BATTESIMI di FIRENZE manchino alcune registrazioni
BADI Badi e' un piccolo paese a cavallo dell' Appennino Pistoiese-Bolognese Qui agli inzi del cinquecento si forma un gruppo con cognome Carnesecchi forse legato ai Carnesecchi storici dall'entrata nel gruppo di una donna dei Carnesecchi Comunque un gruppo sicuramente di diversa origine Sono un nucleo abbastanza numeroso Muteranno il cognome da Carnesecchi a Carnesecca nel 1800
PRATO A Prato troviamo addiritura due famiglie con questo cognome apparentemente distinte tra di loro. Nessuna di queste due famiglie sembra aver legami coi Carnesecchi storici MA E' DA NOTARE COME I CARNESECCHI DI PASQUINO USINO UNO STEMMA IDENTICO A QUELLO DEI CARNESECCHI FIORENTINI Rappresentano dei nuclei molto numerosi Le due famiglie ( Carnesecchi di Prato e Del Carnesecca/Carnesecchi ) compaiono nei documenti a Prato gia' a cavallo della fine del trecento e degli inizi del quattrocento Non sono pero' in grado ancora di datare in modo preciso il momento della cognomizzazione ma sospetto fossero cosi chiamati gia' ad inizio quattrocento Sicuramente non e' posteriore degli anni a cavallo tra quattrocento e cinquecento Nel catasto del 1427 pero' non figura nelle portate nessuna famiglia cognominata Carnesecchi o Del Carnesecca o Del Carne ( fonte : dr Piccardi Paolo ) Questo non esclude che fossero gia' identificati in questa maniera
I Del Carnesecca/Carnesecchi per distinguersi abbandonarono successivamente nelle portate fiscali il cognome Carnesecchi o Del Carnesecca per assumere quello di Del Carne . Ma continueranno comunque ad esser identificati spesso nei documenti ancora come Carnesecchi Non so se i Del Carne intendessero distinguersi dai Carnesecchi perche' erano stirpi diverse o per diatribe familiari
Di certo alla fine del quattrocento i Carnesecchi di Prato sono evidentemente identificati in questo modo
Molto piu' tardi ( a mezzo cinquecento ) compare a Prato : Ulivieri Carnesecchi che originera' una terza famiglia
BATTESIMI A PRATO Fonte della ricerca : INCIPIT
I battesimi della Cattedrale (già pieve) di S. Stefano si conservano dal 1480 circa e riportano le nascite di tutta la città e dei sobborghi. Bartolomeo di Amaddio di Bartolomeo del Carneseccha 1483 Paolo di Proveglia Carnesecchi 1485 Bartolomeo di Amaddio di Bartolomeo Carnesecchi 1487 Agnola di di Proveglia di Iacopo Carnesecchi 1487 Marco di Amaddio Carnesecchi 1489 Bartolomea di Proveglia di Iacopo Carnesecchi 1492 Adovarda di Paolo di Antonio Carnesecchi 1492 Marco di Pasquino di Marco Carnesecchi 1493 .........................
SAN SEPOLCRO Nel 1519 e' gia cognominata a San Sepolcro una famiglia Carnesecchi Sembra esssere un nucleo molto ristretto compare tra i Gonfalonieri della citta' con Francesco di Gasparo Ho troppo poche notizie per poter capire la loro origine ( Ma potrebbero essere della famiglia dei Caneschi cognome diffuso nell'aretino ( nel caso o un errore dello storico che ha compilato gli elenchi o dello stampatore )
OSSERVAZIONE Agli inizi del cinquecento circolano per la toscana almeno 4 gruppi cognominati Carnesecchi I Carnesecchi storici con questo cognome dal 1380 , i Carnesecchi di Badi e Prato (2 famiglie ) con questo cognome dal 1490 circa Ci sarebbero dei Carnesecchi a San Sepolcro dal 1519 ma sono quasi sicuro che non si tratti di Carnesecchi ma bensi di Caneschi (errore dello storico nella compilazione )
|
|
carnesecchipratobadi
ALBERI GENEALOGICI NEL 1500 PRATO/BADI
A complicare lo studio genealogico ( col rischio di omonimie ) tra la fine del quattrocento e l'inizio del cinquecento compaiono ( come vedremo diffusamente ) famiglie cognominate Carnesecchi a Prato e a Badi Difficilmente i Carnesecchi di Prato hanno legami parentali con i Carnesecchi fiorentini mentre e' possibile un legame dei Carnesecchi fiorentini coi Carnesecchi di Badi per via femminile
Ecco Bartolomeo Franchi la cui nascita si puo' ipotizzare tra il 1420 ed 1430
Ho visto in archivio l'estimo del 1451 ma purtroppo non fornisce alcun dato nuovo circa il motivo per cui i discendenti di Bartolomeo Franchi nel 1563 assunsero tutti il cognome Carne sechi o Carnesecchi, ma emergono alcuni (pochi) dati nuovi perchè al 1451 Bartolomeo era vivente ed era già titolare di gran parte dei beni che poi perverranno i primi eredi. L'estimo del 1451 è molto importante perché si pone alla fine della lunga depressione del 1300-1450 ed agli inizi della eccezionale ripresa rinascimentale. Coincise anche col definitivo sopravvento dei Bentivoglio e col loro sostanziale riconoscimento da parte dell'autorità pontificia e dei legati, col riconoscimento della sostanziale autonomia bolognese, e con un tentativo di avere un quadro molto dettagliato della situazione (censimento delle persone, abitazioni, possessi, animali, suppellettili, debiti e crediti) quale in seguito non si sarebbe più ripetuto. Tuttavia da comunità a comunità si registrarono differenze e, ad esempio, a Badi non è registrata l'età delle persone come avviene invece in altri casi (ad esempio Capugnano), comunque, anche a Badi risultano nel 1451 registrate anche le donne che in seguito verranno omesse se non titolari dei beni. Al 1451 la famiglia di Bartolomeo Franchi risulta composta da 5 bocche ed è semplice e completa, probabilmente costituita da non moltissimo tempo, poiché, oltre alla moglie, vi risultano solo tre figli, esattamente 1 figlio e due figlie, mentre in seguito i figli (senza considerare le figlie che non verranno più registrate) risulteranno abbastanza numerosi.. Il quadro è il seguente: Bartolomeo Franchi = donna Margherita ____________________________________________________ Tommasino ; (Bartolo)Mea ; Margherita da un punto di vista socio-antropologico sembra meritare qualche considerazione quel d. (domina) premesso al nome della moglie. Normalmente l'estimo riporta solo i nomi, senza alcun attributo (eccetto per gli uomini il ser per i notai, il don per i sacerdoti, il mastro per gli artigiani ma non sistematicamente). Normalmente il termine domina viene accennato solo quando (molto raramente) le donne sono capofamiglia e titolari dei beni. Nel caso del capostipite dei Carnesecchi titolare e capofamiglia è sicuramente lo stesso Bartolomeo. Pertanto l'uso del termine domina, donna è incidentale (un lapsus) o è intenzionale, sottolinea una particolare dignità? E specificamente, potrebbe essere lei una Carnesecchi, di eventuale provenienza esterna, che avrebbe fissato l'identità della famiglia ?? Purtroppo, allo stato attuale delle conoscenze, non si può dire nulla e poiché, dal silenzio delle fonti, sarebbe erroneo passare ad una affermazione positiva, meglio limitarsi a considerare il problema, sperando in futuri rogiti o fonti giudiziarie, . . I possessi di Bartolomeo erano i seguenti: - casa murta, coperta di piagne, con casamento, aia, prato, orto in Mansovrana (confina rio, beni di S. Prospero) ......................................................... £ 30 - pezza vignata, ivi (S. rpspero, rio)..................................................... " 10 - pezza vignata, ivi (via)....................................................................." 10 - pezza arativa cstagneta a bonari (?) (Ghitino Cambini, S. Prospero).........." 15 - pezza castagneta zazobian (?) (s. Michele, Corso da Badi)....................." 10 - pezza querciata a (= il) lagazo (Corso da Badi, via)................................ " 10 - pezza castagneta donegado (S. Prospero, via)....................................." 10 - pezza castagneta redichapori (?) (Zanino da Badi, S. Prospero)..............." 10 - pezza prativa campiano (S. Prospero, Petronio (??))..............................." 10 - pezza castagneta a cariani (beni di S. Giusto di Suviana, beni comunali)...." 10 - pezza prativa al bucedo (Pietro di Matteo, rio)......................................" 10 - pezza arativa al pozo (= il poggio) (rio da due lati, via)..........................." 30 - pezza vignata vigna redonda (via da due lati, Marco).............................." 15 £ 180 supellettili..............................................£ 20 animali: 3 pecore e 50 capre....................." 25 (12) 1 paio di buoi.............................." 20 (10) debiti verso 3 persone.............................." 40 Totale.....................£ 202 . A differenza di altre comunità a Badi non viene data la superfice dei terreni, che comunque non dovrebbe essere molto rilevante. Il calcolo non risulta interamente esatto. La proprietà non è eccezionale ma fa comunque di Bartolomeo il terzo possidente della comunità e in particolare egli appare decisamente il più qualificato per possesso di animali ed in particolare per il numero delle capre. Il centro originario della famiglia in Badi si conferma il borghetto di Mansovrana, alto sulla valle della Limentra (oggi sul lago di Suviana), non molto distante dalla parrocchiale di S. Prospero e caratterizzato da un rio e da una discreta sorgente. Per il momento non sviluppo altre considerazioni. Cordiali saluti Alfeo Giacomelli
I CARNESECCHI DI BADI : una famiglia contadina
Negli anni che vanno dal 1450 al 1500 una famiglia di Badi , paese a cavallo dell'Appenino pistoiese-bolognese viene identificata come Carnesecchi : il motivo piu' probabile e' che il cognome possa derivare dal matrimonio con una donna dei Carnesecchi fiorentini o pratesi ;
I Carnesecchi di Badi ………….Una famiglia Carnesecchi a Badi, una storia curiosa ( da notizie e documenti raccolti dal Prof. Alfeo Giacomelli )
Edoardo Penoncini Il giuspatronato nelle chiese di Santa Maria Assunta del Castelluccio e S. Prospero di Badi
………..Sacerdoti locali a Granaglione si prese a nominarli a partire dal Cinquecento con don Franco Carnesecchi, ma a Capugnano già dal 1469 venne eletto un esponente della famiglia Zanini di Lùstrola,….
http://www.storiadidassi.it/s&d_g000006.pdf
Ivana Giacomelli L’archivio parrocchiale di San Michele Arcangelo di Stagno (1639 --1885)
pubblicato in "Nuèter noialtri - Storia, tradizione e ambiente dell’alta valle del Reno bolognese e pistoiese", a. XXVIII, 55 (giugno 2002), pp. 42-50. © Gruppo di studi alta valle del Reno Distribuito in digitale da Alpes Appenninae - www.alpesappenninae.itL’archivio parrocchiale della chiesa di San Michele Arcangelo di Stagno si presenta sufficientemente fornito di documenti e permette di seguire la storia di questa piccola comunità per quasi tre secoli. Attualmente, dopo la soppressione della parrocchia, i libri sono conservati nell’archivio arcivescovile di Bologna. La documentazione comprende 4 libri dei battezzati che abbracciano il periodo dal 1639 al 1881, 3 libri dei morti dal 1646 al 1885, 1 libro dei matrimoni dal 1818 al 1889. Esiste poi una serie di stati d’anime che vanno dal 1692 al 1875, con interruzioni di maggiore o di minor durata…………………………………………………… ………………Si estinguono nel Seicento la famiglia Carnesecchi, non localizzata , e la famiglia Bardotti, di cui si fa cenno in un solo documento del 1640. Da questa famiglia deriva il toponimo Ca’ dei Bardotti, indicante un casolare, un seccatoio ancora oggi ben individuabile e non lontano dal fiume Limentra.In seguito, forse proprio per l’estinguersi della famiglia Bardotti, nello stesso luogo si insediò la famiglia Bertini, che da poco tempo si era trasferita a Stagno da altra parrocchia, visto che un documento del 1668 la qualifica come nunc habitans in praedicta parrochia S. Michaelis de Stagno, pertanto lo spostamento appare recente. Altre famiglie estintesi nel Seicento sono quelle dei Manfredini e dei Pedroni, non localizzate. http://www.alpesappenninae.it/articoli/N055Giacomelli.pdf?id=117
BATTESIMI FONTI : fedi di battesimo della discendenza di BADI
ABBOZZO DI GENEALOGIE dei Carnesecchi di Badi Per la cortesia di Lidia Dalmazzo e suo marito Daniele Donati
BATTESIMI FONTI : fedi di battesimo della discendenza di BADI
ABBOZZO DI GENEALOGIE dei Carnesecchi di Badi Per la cortesia di Lidia Dalmazzo e suo marito Daniele Donati
Lidia Dalmazzo ha insieme al maritoDaniele Donati fotografato tutti i registri esistenti nella chiesa di San Prospero di Badi e li ha messi su DVD Un lavoro encomiabile che ha messo in salvo il rimanente Infatti una parte dei battesimi , che pare scendessero addirittura al quattrocento ,e' andata distrutta nei secoli passati; battesimi rimanenti cominciano solo dal 1644 I registri dei morti partono dal 1644 I registri dei matrimoni solo a partire dal 1644 I registri dei consensi : alcuni I registri delle cresime o dei confermati dal 1625 Gli stati delle anime : alcuni 1826 1828 1858 1895
ABBOZZO della STORIA DI BADI by Lidia Dalmazzo
Da notare che di Badi e di Stagno si parla nel XIII secolo ne il LIBER CENSUM del comune di Pistoia edito per il dr Quinto Sintoli nel 1907 si tratta di regesti di documenti pistoiesi e della montagna pistoiese
Alberi dei Carnesecchi/Carnesecca di Badi costruiti da Giambattista Comelli
|
I CARNESECCHI DI PRATO
Coi dati in parte raccolti dalla societa' di ricerca INCIPIT ho provato a costruire questi incompletissimi alberi genealogici
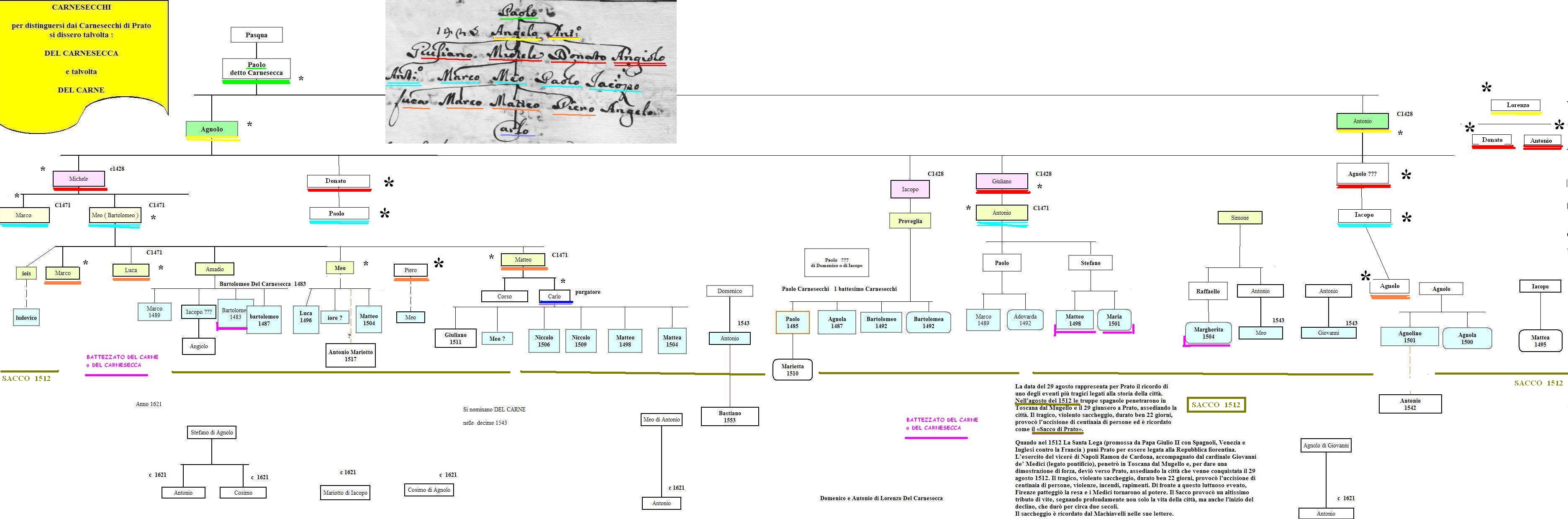
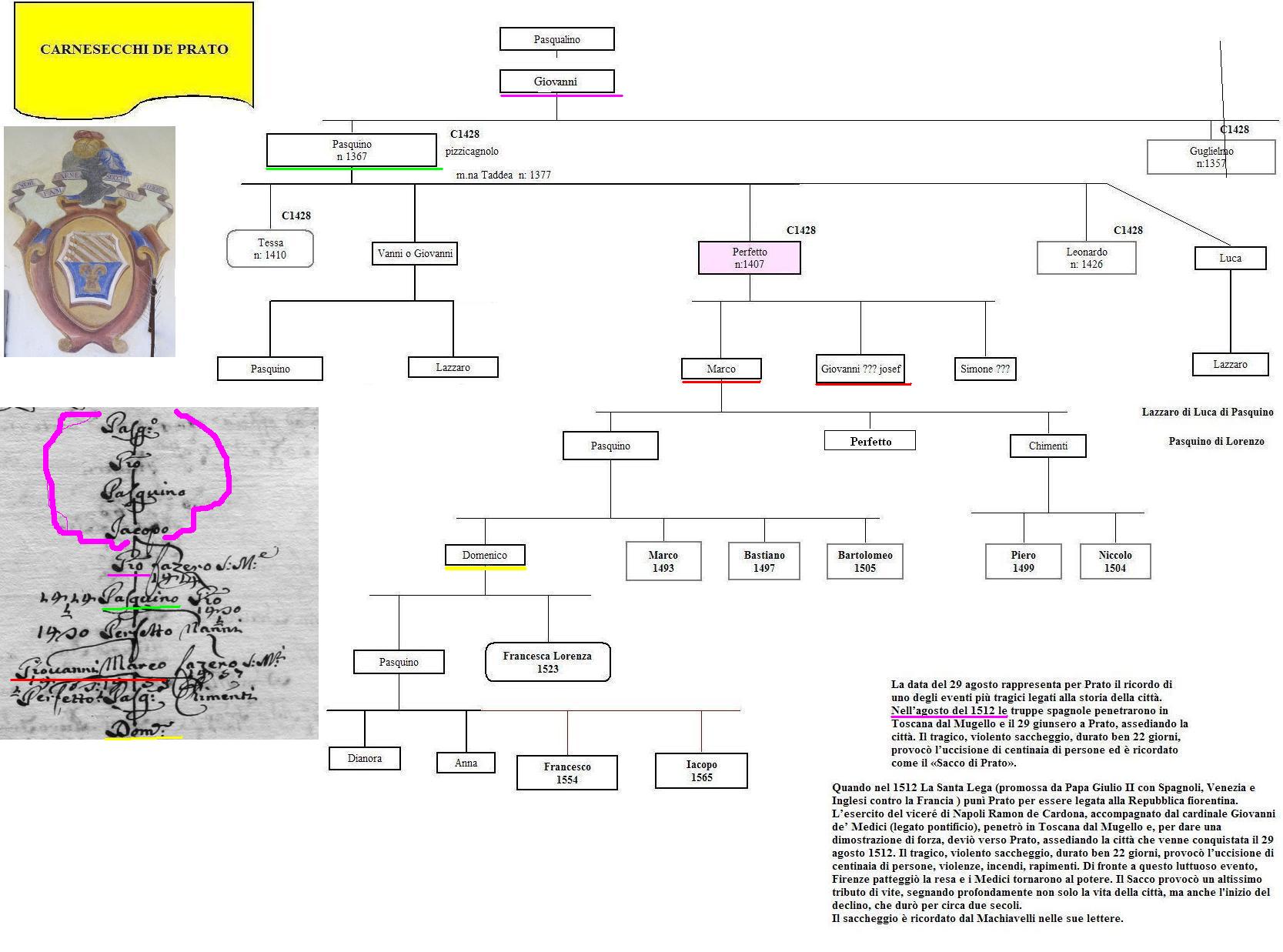
ALLA FINE DEL QUATTROCENTO QUINDI NON POSSIAMO PIU' PARLARE SOLAMENTE DEI CARNESECCHI DI FIRENZE MA BISOGNA PARLARE ANCHE DEI CARNESECCHI DI BADI E DI PRATO
|
carnesecchipratobadi
Le origini dei Carnesecchi di Prato e dei Del Carne di Prato non sono mai state investigate e anche gli alberi genealogici non sono sicuri Abbiamo visto una fuga da Firenze a Prato di Patarini a mezzo 1200 Abbiamo visto a Prato la presenza degli antenati di Dante Alighieri a mezzo 1200
A Prato negli anni che vanno dal 1270 al 1280 compare tra gli Anziani un taverniere di nome Ricovero di cui non sono riuscito a definire oltre la figura Il nome Ricovero e' molto comune L'omonimia con il taverniere Ricovero padre di Durante attira comunque la mia attenzione aprendo un fronte d'indagine E' improbabile che Ricovero avesse abbandonato Firenze per spostarsi a Prato ma non si sa mai..............
un ipotesi completamente da verificare ..Su di una possibile origine a Prato dei Carnesecchi fiorentini : Ricoverus tavernario "anziano" del comune di Prato per porta Gualdimare
LE TRE FAMIGLIE CARNESECCHI DI PRATO
Intorno al 1372 viveva in Prato Paolo di Pasqua detto Carnesecca. Successivamente nel 1397 sempre a Prato e' estratto come consigliere dell'Arte dei pizzicagnoli : Pasquino di Giovanni di Pasqualino ( non so se fosse chiamato Carnesecca ) . Nel catasto del 1427 non figura alcuno nominato come Carnesecca o Carnesecchi. Non so quando a Prato iniziassero degli individui a cognominarsi Carnesecchi ( devo verificare ancora nei catasti successivi ) e' vero comunque che iniziarono ad usare questo cognome solo molto piu' tardi dei Carnesecchi fiorentini che gia intorno al 1380 iniziavano ad essere identificati cosi. Dall'opera del Fiumi su Prato e' difficile stabilire quando inizia la cognomizzazione perche' opera sul principio : ……. se raggruppiamo per casato le singole poste espressamente cognominate o che ci e' stato possibile cognominare ( ancora in questo secolo XVI il cognome e' sovente omesso )……….. Quindi il Fiumi usa ai suoi fini statistico-economici cognominare con un cognome che temporalmente solo piu' tardi sarebbe entrato in uso per identificare i membri quella famiglia . Per ora il primo atto che conosco in cui si nomina un Carnesecchi e' un atto del 1509 in cui compare la moglie di un discendente di Paolo : Charllo di Matteo Charnesecchi. Comunque quello che oggi posso solo dire e' che ad un certo momento i discendenti di Paolo Carnesecca e i discendenti di Pasquino di Giovanni presero il cognome Carnesecchi e questo momento e' per ora da fissarsi tra il 1427 ed il 1509 ( Sebbene mi convinca poco come ci si possa cognominare col nome di un antenato di un secolo prima : mentre piu' convincente mi risulta che per la gente fossero gia' i Carnesecchi ) E' da ricordare che discendenti di Paolo talvolta si definiscono Del Carnesecca (o Del Carne ) sicuramente per differenziarsi dai Carnesecchi di Pasquino. E' questa cosa accade sicuramente a detta del Fiumi nelle decime del 1543 Cosi la discendenza di Paolo alterna i cognomi Del Carnesecca , Del Carne , Carnesecchi. Curioso e' che i Carnesecchi di Pasquino adottino uno stemma uguale a quello dei Carnesecchi fiorentini. Non conosco nulla dello stemma dei Carnesecchi di Paolo Nel 1563 compare a Prato nei documenti un certo Ulivieri Carnesecchi che sembra non appartenere a nessuno dei due gruppi genealogici finora visti. Da questo momento siamo in presenza di tre famiglie Carnesecchi. Nel 1584 Pasquino di Domenico dei Carnesecchi di Pasquino agisce in giudizio contro i Carnesecchi di Ulivieri per una ragione che ci appare strana : cioe' chiede che venga impedito ai Carnesecchi di Ulivieri perche' fosse loro impedito di usare il cognome e lo stemma che usavano i Carnesecchi di Pasquino ( stemma che era in realta' quello dei Carnesecchi fiorentini ) : …………….Usurpavint nomen et insignia de Carnesecchis de Prato……………………………………….. I Carnesecchi di Ulivieri, continueranno a chiamarsi Carnesecchi ( anche se i genealogisti li definiranno Carnesecchini : negli atti pero' non c'e' traccia di un simile cognome almeno cosi mi pare ) e nonostante che nell'istanza di Pasquino di Domenico siano definiti persone "humili et vilj " faranno molta strada divenendo prima nobili di Prato e poi nobili di Firenze. I Carnesecchi di Paolo e i Carnesecchi di Pasquino apparentemente si estingueranno ( meglio sarebbe dire : scompariranno da Prato ). Apparentemente perche' lo stemma del 1850 in San Francesco sta a dimostrare il contrario
A Carnesecchi di Pasquino B Carnesecchi o Del Carne o Del Carnesecca C Carnesecchi di Ulivieri o Carnesecchini poi nobili di Prato , poi nobili di Firenze
VICENDA INTERESSANTISSIMA QUESTA DEI CARNESECCHI DI PRATO
vai alla pagina 28 La strana vicenda dei Carnesecchi della citta' di Prato ( su notizie raccolte da Roberto Segnini ed informazioni del dr Vieri Mazzoni )
Carnesecchi Pasquino di Domenico di Pasquino fece deporre l'arme e il casato ai Carnesecchi che fu ordinato dirsi Carnesecchini e fare arme differente dalla sua la quale era la medesima che i Carnesecchi di Firenze ed e' sopra ina sepoltura nel Chiostro di san Francesco
Denuncia da parte dei Carnesecchi di Pasquino contro i Carnesecchi di Ulivieri per usurpazione di cognome e di insegne
I Carnesecchi di Ulivieri , inizieranno una rapida ascesa sociale e riprenderanno il cognome adotteranno momentaneamente come arme :
>
( riproduzione del dr Roberto Segnini) Stemma dei Carnesecchi del giglio di Prato
Questo e' uno stemma riportato nel Ceramelli-Papiani Cosi blasonato : Troncato: nel 1° d'azzurro, al destrocherio di carnagione vestito di rosso, tenente un giglio dello stesso; nel 2° pure d'azzurro, a tre sbarre d'oro; e al filetto in fascia d'oro passato sulla troncatura. Questo stemma fu presentato nel 1735 circa dall'alfiere Sebastiano di Lorenzo Carnesecchi, quando fu ascritto alla cittadinanza fiorentina. (cfr. fasc.1244).
Questo e' lo stemma attribuito da Casotti e da Benelli (tratto da wikipedia) Nello stemma proposto dal Casotti e dal Benelli al posto delle sbarre tre bande e manca il filetto potrebbe essere lo stemma dei Del Carne a cui in una certa fase i Carnesecchi di Ulivieri sembra dichiarassero di riallacciarsi genealogicamente
Il giglio e' nella forma lo stesso giglio che appare sullo stemma del Comune di Prato seppur di colore rosso Prima nobili di Prato poi ammessi alla nobilta' fiorentina
Nel 1765, per l'ammissione alla nobiltà di Prato, lo stesso ottenne di fregiarsi del blasone dei Carnesecchi patrizi fiorentini, estintisi nel 1756 (cfr. fasc.1244)
battesimi di Prato ..Battesimi di Prato raccolti da INCIPIT societa' di ricerca genealogica
Con la data del 1850 nella chiesa di San Francesco a Prato compare questo stemma Carnesecchi ( strano per il numero delle bande ) tesimonianza della sopravvivenza probabilmente dei Carnesecchi di Pasquino
da Wikipedia per Francesco Bini
LE PIU' NOTE FAMIGLIE DI PRATO ENRICO FIUMI nel capitolo : SOMMARIO GENEALOGICO DELLE MAGGIORI FAMIGLIE PRATESI DALL'ETA' COMUNALE ALLE SOGLIE DELL'ETA' CONTEMPORANEA Elenca queste famiglie : Abatoni , Dell'Abbaco , Albertinelli vedi Guizzelmi , Albertini , Aliotti ,Allegretti , Amadei , Amadori , Amannati , Ambrogi , Ammirati ( fiorentini ), Angiolini , Apolloni , Degli Arati vedi Tieri , De Arbore , Arigoni , Arrighetti ,Arrighi , Baldanzi , Baldinucci , Banchelli ,Banchi , Bandieri , Baldini vedi Rocchi , Del barba vedi Buonconti , Barcosi , Bardi , Bartolini , Bartolozzi , Barzaloni , Bastianini , Becherini , Belchiari ,Bellandi , Bellendoti , Del Bello , Bellondini vedi Bolsinghi ,Benamati , Benini , Benintendi ,Benricevuti , Benuzzi ,Bertelli , Berti , Bettazzi , Bettini ,Bianchini , Bicchi , Bicicci , Bidori , Bielli , Bifolchi , Bigagli , Billi , Bindi ,Binducchi , Bini , Bisconti , Bizzochi , Dal Bo , Boatteri , Bocchineri vedi Gherardacci , Boccioli vedi Cennini , Boddi vedi Briganti , Bolsinghi , Bombi , Bomboni , Bomparenti , Bonati , Bondi vedi Bombi , Bonfiglioli , Bonfil , Bottari , Bovacchiesi ,Braccioli , Brancacci , Bresci , Briganti , Buonamici , Buonconti , Del Buono , Buonristori ,Buonvisi , Buri , Cacciafuochi , Caiozzi , Calendi , Calendini , Caluri ,Calvi , Cambioni , Campani ,Cancellieri , Cardelli , Carlesi , Carmagnini , Del Carne , Carnesecchi , Carnesecchini , Dalle Carra , Carradori vedi Dalle Carra , Casini ,Casotti , Castellani , Cavalcanti vedi Bovacchiesi , Cazzetteri , Ceccarelli , Ceccatelli , Ceffini ,Celmi , Cennini , Cepparelli ,Cercignani , Dalle Chiavi , Ciamberli , Cianfanelli ,Ciapini , Cicambelli , Cicognini ,Della Cima , Cini , Del Cinque , Cipriani , Cironi , Ciughi , Ciutini , Cocci , Comparini , Conti , Convenevoli , Coppini , Cortesi ,Costantini , Cristiani , Cugi , Dagomari , Datini , Davini , De Gros , Desii , Dondi ,Dragoni Ermellini Fabbruzzi , Fagioli , Farfalli , Del Fattore , Fazini vedi Ferracani , Fazzi , Fedi , Ferracani , Ferranti , Fiascaini , Filugelli , Del Fioco , Fioravanti , Foresi , Fortebracci , Fracasci ,Franceschi , Franchi , Franchini , Francioni , Fraschetti , Frati , Fronti , Gabellotti , Galigai , Galli , Gargalli , Gatti , Geppi , Gherardacci , Gherardi , Ghibellini , Ghigi vedi Del Fioco , Gini , Giordani , Giuntalodi , Giunti-Modesti , Godenzi , Goggi ,Golli , Del Gollo vedi Golli , Gori , Gottoli , Grassi , Grifi , Gualmi , Guardini ,Guarducci , Guazzalotti , Guidotti , Guiglianti , Guiliccioni , Guizzelmi , Infangati ,Inghirami , Landi , Latini , Lazzerini , Lenzini , Leoncini , leonetti ,Levaldini , Lichi , Limberti , Losti , Luparelli vedi Verzoni , Macci , Magalotti , Maganzini vedi Ristori , Magi vedi Bartolozzi , Magini , Magni , Magnolfi , Malpeli , Malvagini ,Malvisi , Manassei , Mannucci , Marabotti , Marchesuoli , Marchi , Marchiani , Marcovaldi , MARI , Marinari , Martini ,Mascagni , Masi , Masolini , Mazzamuti , Mazzei , Mazzinghi , Mazzoni , Megli , Melani , Mercatanti ,Mercatucci vedi Coppini , Merini ,Meucci , Migliorati ,Migliorini , Milanesi o Melanesi , Miniati , Mochi , Moddei , Modesti , Mugnesi , Muzzarelli-Verzoni vedi Verzoni , Muzzi , Naldini vedi Rinaldeschi , Nerli , Nesti , Niccoli , Niccolozzi vedi Bonfiglioli , Nistri , Nomi , Novellucci , Nuti , Degli Obizzi , Degli Organi , Ormanetti , Pacchiani , Pacini , Palchetti , Palei vedi Bettazzi , Palli , Pallotti vedi Ciutini , Pandolfini , Pantani , paoli , Parenti , Parigi , Pastacaldi , Pellegrini , Perondini ,Pesci , Pesciolini vedi Pesci , Piani , Pieri , Pigli ( fiorentini ) , Pilli vedi Pigli , Pini , Pipini , Polverini , Pontecchi , Pratesini , Pratolini vedi Saccagnini , Del Priore vedi Pugliesi , Puccini , Pugliesi , Quartucci , Rabatti , Ramaioli , Rani , Reggiani , Regnadori vedi Ringhiadori , Ricci , Del Riccio vedi Ricci , Rinaldeschi , Rinaldi , rinforzati , Ringhiadori , Ristori , Rocchi ,Romiti , Ronchini , Roncioni ,Ronconcelli , Del rosso , Saccagnini ,Saccardi , Sacchi , Salvi poi Salvi - Cristiani ,Sandri vedi Marcovaldi , Santini , Sassoli , Sassolini (fiorentini ), Scarioni , Schieri vedi Verzoni , Dello Schiso , Scribentini , Scrigni , Del Sega , Serotti vedi Verzoni , Sgrilli , Sinibaldi , Soffi poi Soffi-Ghibellini , Soldani , Spedalieri , Spighi , Stagi , Stanghi , Steffer , Stradetti , Strigelli , Struffaldeschi , Talducci , Tani , Targetti , Tarpucci , Taviani , Ticci , Tieri , Tignosi vedi Galigai , Tini ,Toccafondi , Tontonberli vedi Saccardi , Torelli , Della Torricella , Torrigiani , Troiani , Tronci , Ugurlandi , Vai , Valentini , Vannozzi vedi Rocchi , Vavassori ( bergamaschi ) , Della Verde , Vermigli , Vernati , Verzoni , Vestri , Vignaleschi , Villani , Vinaccesi , Visconti , Visi , Vivorati , Wyse , Zaccagnini vedi Saccagnini , Zarini , Zelmi , Zeti , Come visto compaiono in questo elenco : DEL CARNE , CARNESECCHI ; CARNESECCHINI ALBERI GENEALOGICI DEL CASOTTI per la cortesia del dr ROBERTO SEGNINI |
I Carnesecchi di Pasquino paiono esser di condizione leggermente superiore rispetto ai Del Carnesecca sebbene anche tra i Carnesecchi di Pasquino troviamo umilissimi artigiani
I Del Carnesecca paiono vivere di mestieri piu' umili ed essere molto prolifici
Il sacco del 1512 rappresenta sicuramente un evento traumatico per le linee genealogiche
|
carnesecchipratobadi
UNA PAGINA TRISTE ANNO 1505 : UN LADRO CHE FINISCE MALE
Dal libro : Gli antichi spedali della "Terra di Prato" - Volume 1 - Pagina 125
Giovanni di Matteo Carnesecchi fu preso come ladro. Dal dì 30 di agosto 1505 gli fu dato il vitto. Fu impiccato nel settembre successivo; non si conosce il giorno. Viene annotato che non pagò le spese. Non ho altra informazione se non queste poche righe Non ritrovo Giovanni di Matteo in nessuna delle genealogie in questo sito ricostruite Era probabilmente uno dei Carnesecchi pratesi Ammesso che avesse una trentina di anni , suo padre Matteo doveva esser nato almeno nel 1450
|
----------------------------------------------------------------------------------------------------
INTERESSANTE : 19 agosto 1508 Giuliano di Luca Carnesecchi procuratore di donna Sigismonda di Borgo Sansepolcro
|
I Carnesecchi di Borgo San Sepolcro o forse i Caneschi
Nella serie dei gonfalonieri di Borgo San Sepolcro tre volte (1516, 1519 , 1530 ) figura un Carnesecchi : Francesco di Gasparo Non sono per ora riuscito a collocare Francesco Di Gasparo nelle genealogie dei Carnesecchi fiorentini. Tra i nomi dei gonfalonieri di Borgo San Sepolcro non sembra figurare che i soli Carnesecchi con cognome riferibile a famiglia fiorentina. Dopo il 1530 piu' alcuna traccia di Carnesecchi tra i gonfalonieri In realta' sono convinto di trovarmi di fronte ad un errore dello storico nella compilazione FORSE LA FAMIGLIA A CUI APPARTIENE FRANCESCO DI GASPARO NON E' DEI CARNESECCHI MA BENSI QUELLA DEI CANESCHI FORSE A SAN SEPOLCRO NON CI SONO MAI STATI CARNESECCHI RESIDENTI
Una famiglia Carnesecchi a Borgo San Sepolcro ………….I Carnesecchi di Borgo San Sepolcro
-----------------------------------------------------------------------------------------------
STORIA DI BORGO SAN SEPOLCRO
Annali, E Memorie Dell' Antica, e Nobile Città Di S. Sepolcro Intorno alla ... Di Pietro Farulli
BORGO SAN SEPOLCRO
alle pag i commissari fiorentini tra cui Simone Carnesecchi (1450 ) Paolo Carnesecchi ( 1490 ) Giovanni Carnesecchi
Le vite d'uomini illustri fiorentini Di Filippo Villani,Giammaria Mazzuchelli (conte),Alessandro Goracci
alle pagine la storia di Borgo San Sepolcro alle pagine elenco gonfalonieri di giustizia tra cui Gasparo Carnesecchi
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Luca Signorelli come abbiamo visto era sposato con Galizia Carnesecchi figlia di Pierantonio o di Piermatteo Un matrimonio avvenuto intorno al 1470 Il padre di Galizia non compare nelle genealogie che ho ricostruito e mi e' nato il dubbio che questi Carnesecchi abbiano a che fare con Borgo Sansepolcro Se questo dubbio avesse valore potremmo ipotizzare legami giovanili di Luca Signorelli con questo luogo Luogo che era la patria di Piero della Francesca considerazione che potrebbe spostare da Arezzo a Borgo san Sepolcro l'apprendistato del Signorelli e datarne gli inizi www.carnesecchi.eu/Luca_Signorelli.htm
|
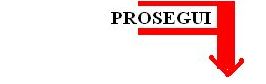
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ing. Pierluigi Carnesecchi La Spezia anno INIZIO 2003
